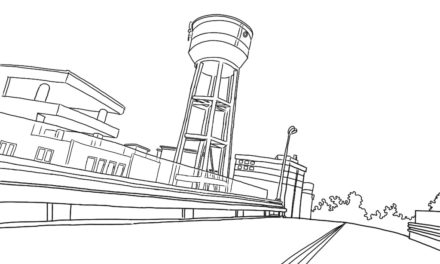Di GIROLAMO DE MICHELE.
1. L’ordine del discorso populista
Nel “dialogo” intessuto sul manifesto da Benedetto Vecchi e Marco Revelli a partire dal libro Turbopopulismo di Revelli e Telese ci sono due passaggi degni di sottolineatura. Scrive Revelli:
Steve Bannon ha detto di recente che «se vogliamo che il capitalismo sopravviva dobbiamo trasformare le persone in capitalisti». La struttura psicologica di quel grande bacino che sostiene la Lega di Salvini e l’intera destra sovranista ci dice che quel programma è già in buona misura compiuto. Quegli elettori hanno, certo, i piedi affondati nello sterco del capitalismo contemporaneo, ma la testa totalmente dentro la sua narrazione ideologica. Producono valore nello stesso tempo in cui ne percepiscono una, sia pur minore, parte attraverso i fondi pensione finanziarizzati, i magri risparmi investiti, le dilazioni sulle carte revolving. […] Per questo, nella forma attuale assunta dal populismo, non c’è più nulla di ambivalente. Non è più il radicalismo trasgressivo del grillismo delle origini, ancora oscillante tra destra e sinistra. O quello tematizzato da Laclau. È ormai, compiutamente, una delle tante forme con cui la destra estrema usa le masse per privarle di ogni possibile autonomia. Per questo qualsiasi forma di resistenza, fosse anche solo quella morale, alla loro avanzata non è solo benvenuta. È necessaria. [29.12.2019]
Gli aveva in certo senso risposto, ex ante, Benedetto Vecchi:
Il populismo è la forma politica che definisce rigidi e angusti confini all’ordine del discorso politico, manifestando al contempo una cangiante capacità egemonica e innovativa nella società. Se un movimento inizialmente di opinione come le «sardine» vuol violare i confini dell’ordine del discorso dominante deve dunque forzare le compatibilità dettate dalla fabbrica del consenso. Se lo farà è partita aperta. Come lo farà è ancora tutto da scrivere, proprio da quelle «sardine» che hanno deciso di prendere la parola. [24.12.2019]
Questi due passaggi mi sembrano importanti per tracciare le coordinate del piano sul quale si è manifestato l’evento delle sardine: un contesto che è al tempo stesso il cuore dell’evento, la sua causa scatenante. Se si perdono di vista queste coordinate, la discussione sulle sardine diventa oziosa, accademica, e soprattutto futile: e allora ciascuno può tirar fuori dallo scaffale il classico che ha già detto in anticipo come andrà a finire, o dettare la linea al movimento, stilarne il dress code in stile-Voltaire, contarne le pulci o spazzolarlo contropelo con la brusca dell’annata e stagione che crede. Buon per loro: io, di solito, ho da far cose più serie, costruire su macerie, o mantenermi vivo.
2. Sardine da Roxy Bar
Alcuni anni fa, un’importante emittente televisiva prese una grossa cantonata con un programma musicale che, in onda il sabato in prima serata, aveva come target ragazzi e ragazze che uscivano di casa sul tardi per andare in discoteca. Auditel garantiva che quella fascia di ascolto non aveva un programma di riferimento: fu un flop clamoroso. Fatto sta che quel programma esisteva: Roxy Bar, condotto da Red Ronnie, su una piccola emittente che il sabato sera raggiungeva ascolti da major – ma che non spendeva soldi per farsi rilevare gli ascolti da Auditel, e che quindi per Auditel non esisteva.
Un episodio che dice molto sulla provenienza di questa sparsa moltitudine che si è stretta come sardine in diverse piazze. Da dove vengono? In buona parte, da quell’ampia fetta di potenziali elettori che non votano (in parte perché non ne hanno ancora l’età), e quindi sfuggono alla fittizia tripolarizzazione elettoral-sondaggistica Lega-PD-M5S. Ovvero, cambiando il quadro di riferimento, da quegli interstizi, o intersezioni, fra questa e quella fascia o componente sociale. Universitari, ma anche precari, col motorino a fare consegne o nei lavori precari fra una stagione e l’altra per pagarsi gli studi. Non facilmente collocabili in questo o quel settore perché ne attraversano più d’uno. Così come alcune e alcuni sono, anche, nei Friday For Future o nelle manifestazioni femministe, o nelle mobilitazioni per la riapertura dei porti e la libertà di salvataggio dal naufragio. Alcune, non tutte: quante, al momento non è dato sapere. Questo carattere inatteso, imprevisto, non immediatamente collocabile nei ranghi è un primo dato da tenere presente. Dall’altrove da cui provengono, le sardine pongono molti problemi. Non è detto che siano in grado di indicarne le soluzioni: ma porre il problema è cosa fondamentale.
Provo a elencarne alcuni, senza pretesa di completezza.
3. La crisi della crisi della rappresentanza
Il primo problema posto è interno a un’obiezione che viene fatta loro: essere uno strumento di cooptazione del consenso per le prossime elezioni regionali. Il che è probabilmente vero: ma questa verità è parte del problema, non della soluzione. Ci arrabattiamo da anni nella crisi della rappresentanza, senza venirne a capo. Altrove ci sono stati Syriza, Podemos, il kirchnerismo (non importa qui come sono poi andate a finire): da noi, Bertinotti e Vendola, con gli esiti che conosciamo (dell’attuale coriandolizzazione di liste e partitini di sinistra non vale neanche la pena parlare). Peraltro, non s’è visto – a differenza, forse, della Francia, dove quantomeno il tentativo è in atto – un movimento reale in grado di tentare l’abolizione dello stato di cose presenti in direzione dell’azione diretta, dell’autogestione – se non in limitati settori sociali, che esprimono una tendenza, ma senza averla attualizzata. Se il “desiderio dell’uomo forte” che il Censis ha ritenuto di fotografare di recente è il prodotto della crisi della rappresentanza, l’alternativa fra Lega, PD e M5S, determinato dal 40% di astensionismo che transustanzia un 20-25% in 40%, e poi in maggioranza dei seggi, è il prodotto della crisi della crisi della rappresentanza: può non piacere, ma le sardine pongono il problema all’ordine del giorno. Può non piacere la soluzione implicita in molte di loro (sempre ricordando che il movimento si diffonde a macchia di leopardo in più delle due regioni nelle quali si voterà prossimamente): ma non è per colpa loro che il problema esiste. Non è detto che sia la matita elettorale la soluzione: ma bisogna saper distinguere fra le sfumature del peggio. Senza mai dimenticare che è del peggio che stiamo parlando.
4. Salvini è il nome del peggio?
Il secondo problema che pongono le sardine coincide con la seconda obiezione che si rivolge loro: l’equazione Salvini=fascismo, la demonizzazione dell’uomo con la felpa. Il manifestare non contro chi governa, ma contro chi è all’opposizione, cosa che non si sarebbe mai vista finora.
Di nuovo: le sardine pongono il problema. In questo caso, hanno il merito di aver detto il nome della Bestia.
Andiamo per ordine. In verità, le sardine non sono state le prime a mettere il nome-Salvini (ovvero: ciò di cui Salvini è nome) in primo piano, in posizione ostinata e contraria. Basta fare un giro in rete, seguendo l’hashtag #maiconsalvini, per scoprire che sono anni (diciamo, giusto perché me lo ricorda il manifesto di Zerocalcare appeso alla porta che ho di fronte: dal 2015?) che si manifesta contro Salvini e il pericolo fascista e razzista di cui è il nome. Fino a ieri, però, a difendere Salvini c’erano non solo le forze dell’ordine, ma soprattutto quelle forze politiche per le quali non bisognava sopravvalutare l’uomo con la felpa, e in ogni caso non si doveva estremizzarne le idee fino a dichiararlo fascista. Quelle forze politiche che la parola “Fascismo” (in buona compagnia con molti media mainstream) non la pronunciavano mai – neanche in casi di aggressioni, talora omicide, fasciste. Le sardine hanno avuto la capacità di imporre questo ordine del discorso, spazzando via i tatticismi politicanti, a livello di massa: gli va riconosciuto.
L’accusa di “opporsi a chi si oppone” è, involontariamente, rivelatrice nella sua stupidità. Perché è successo, eccome, nella storia: cos’altro erano quei movimenti antifascisti di massa degli anni Sessanta e Settanta? Ma soprattutto: quale misera idea del potere alberga nella mente, e nella cultura politica, di chi crede che il potere sia questione di “maggioranza” e “opposizione”? (Di questo, più avanti).
E dunque, diciamolo con chiarezza: Salvini è oggi il nome del fascismo. Del fascismo inteso non come aggettivo con valore spregiativo, ma come sostantivo. Della versione aggiornata del fascismo, di un fascismo upgrade, 2.0 (“postfascismo”, propone qualcuno): ma, nella sua struttura di fondo, sempre fascista. Ovvero, La dottrina del fascismo di Mussolini, il Primo e Secondo libro del fascista, la Difesa della razza di Nello Quilici: quella roba lì, pari pari. Che bisognerebbe, per così dire, (ri)studiare (come alle origini del Ventennio, anche oggi ci sono alzate di sopracciglio a sinistra, cantori del sovrastrutturale o epigoni del tale che credette Mussolini uno dei tanti cavalli che la borghesia cambia a proprio piacere): certo, arricchendone la lettura con Gobetti, Gramsci, Foucault, Bauman, ecc. Ma partendo da lì, dai fondamentali. Dietro il consenso di massa della destra, dietro quel 50% (del 60%: cioè il 30% reale) c’è la fascistizzazione della società. L’odio verso l’altro – il migrante, il portatore di qualsivoglia diversità di genere, religione o gruppo etnico, la donna non bisognosa di supporti androsterogeni, l’anziano con pervicace autosufficienza –, il conclamato desiderio di morte digitato dalle tastiere o concretizzato in memorandum e decreti-sicurezza, la crescente disumanizzazione che si manifesta con scurrili sgrammaticature o raffinati distinguo politico-intellettuali anche nelle fila che si vorrebbero avverse alla destra, l’ascesa, egemonica a destra, patetica a sinistra, del sovranismo hanno un nome comune: comprenderlo ci aiuterà a tracciare una linea di demarcazione molto più chiara fra noi e il campo avverso.
5. L’odio, la scimmia e il tam-tam
Terzo problema, di nuovo coincidente con un’accusa – bifida, questa: il rifiuto delle parole di odio. Punto sardina n. 5: «Pretendiamo che la violenza venga esclusa dai toni della politica in ogni sua forma. La violenza verbale venga equiparata a quella fisica». Per qualche liberal dal cognome francamente eccessivo, si tratterebbe dell’introduzione di un novum giuridico inaccettabile in punta di diritto; piuttosto che inserirlo nella riscrittura dei decreti-sicurezza sull’immigrazione (le sardine ne chiedono l’abrogazione, ma che te lo dico a fare?), meglio sarebbe tenersi i decreti-Salvini: affonderanno altre barche e annegheranno altri esseri umani, ma la santità del diritto, signora mia…
In modo avverso e speculare – banalità contro banalità: «mi pare banale questo rifiuto acritico dell’odio: esiste ed è sacrosanto l’odio di classe». E ci mancherebbe, che a sfruttate e sfruttati fosse negato il diritto di mandare affanculo il loro sfruttatore. Certo, sulla punta del pennino varrebbe ricordare che l’odio dell’oppresso che genera virtuosi tumulti e rovescia principati ha un proprio nome, che è “indignazione”: così insegnano Machiavelli e Spinoza – ma tant’è…
Passettino avanti: non il solo materialismo, ma ogni assennata concezione del linguaggio (o della semiotica, o di entrambi) insegna che è il contesto a determinare il significato. Il sintagma “Tutti gli uomini sono uguali” cambia significato se è scritto in una dichiarazione universale dei diritti, sul manifesto di un convegno imprenditoriale per l’aliquota fiscale unica, su uno striscione che apre una marcia di immigrati, o sul cartellone di una manifestazione contro la violenza di genere. Qui, nei punti programmatici delle sardine, “odio” ha un significato ben preciso: gli hate speech. Il che significa (ci sono vaste bibliografie in proposito) che il linguaggio è un campo conflittuale e non una teleferica che sposta significati da qua a là; è un dispositivo di potere che assegna ruoli e posizioni e distribuisce funzioni; che è irretito nel campo del simbolico, che le parole sono come bauli che contengono simboli, cioè concezioni del mondo, o frammenti di esse. E che gli strumenti attraverso i quali il linguaggio viene trasmesso sono anch’essi costitutivi del linguaggio.
Il discorso del potere, delle Bestie comunicative, dell’uso dei social, e dell’opposizione a questo potere (fascista nella forma, dunque nella sostanza) della becero-destra è tutto qui. Controprova: si confrontino, al netto delle specifiche effettualità, le campagne di odio contro Greta Thunberg, Carola Rakete, Liliana Segre – contro i loro “corpi alieni”, per dirla come Cristina Morini. Vi si troverà la stessa struttura discorsiva, a stessa costruzione linguistica della vittima designata in quanto meritevole di essere vittima: la stessa costruzione fascista del disumano.
Gli hate speech non li ha inventati Salvini: ma nel servirsene, li legittima, ne rafforza la struttura e ne amplifica la prassi. Più di 10 anni fa lo denunciava Javier Marías dalle pagine di El País:
Quello che sta succedendo in Italia – e prima in Polonia, con i gemelli Kaczynski – è molto preoccupante. Siamo in presenza di politici vincenti che hanno abbattuto la frontiera tra ciò che si può e ciò che non si può dire in pubblico. Hanno scelto di parlare e comportarsi come molti dei loro elettori, con la differenza che questi possono farlo solo in privato. Una forma superiore di demagogia consiste nel non limitarsi a dire al popolo quello che questi desidera sentire, ma addirittura nell’adottarne i discorsi e il vocabolario brutale che fino a ieri erano confinati solo nel privato, e in tal modo legittimarli. “Quello che tu dici a bassa voce io lo dico ad alta voce, davanti alle telecamere e ai microfoni, e così ti autorizzo e ti adulo. Guarda: io sono in tutto e per tutto come te, e per di più non mi nascondo. Non nasconderti neanche tu: vieni fuori, e votami!” [“Brutta e povera Italia”, 18 maggio 2008].
È la peste del linguaggio di cui scriveva Calvino nelle Lezioni americane, riannodando i fili di una ventennale discussione con Pasolini e Sciascia. Le sardine hanno il merito di aver posto all’ordine del discorso politico gli hate speech: prendiamone atto, e mettiamolo a tema. Scrive Murakami, nel suo ultimo romanzo, che «Internet nella giungla non funziona bene. Nella giungla ci sono altre reti di comunicazione. Ad esempio, il tam-tam. O attaccare un messaggio al collo di una scimmia». Piuttosto che fare i Tommaseo de noantri facendo la punta alle matite con cui scriviamo la parola “odio”, chiediamoci quali tam-tam e quali scimmie, quali relazioni concrete in luogo di quelle fittizie, quali parole cui diamo materialità nei volti fisici possiamo valorizzare: «Quando gli strumenti della civiltà non funzionano, suonare un tamburo o servirsi di una scimmia sono cose che acquistano valore».
6. L’ordine del discorso politico
Ultimo punto, e ultima critica: il programma delle sardine è talmente vago da essere vuoto (variante: è un contenitore vuoto ripieno del solo odio verso Salvini). Perché i pochissimi che muovono lo sciame sono vaghi e vuoti, ossia eterodiretti da un paio di Soros al ragù. Fioriscono in rete elenchi di temi assenti dal programma delle sardine, da parte di leonesse e leoni da tastiera: la mamma dei benaltristi è sempre gravida (ma ai tempi, chiedo, avevamo tutti compitato a memoria Grundrisse e Sesto inedito del Capitale, o c’era anche qualcuno alla cui indignazione poteva bastare un «Cosa diciamo? Basta! Cosa vogliamo? Tutto!»?). Di colpo, ritornano in voga pratiche di lettura che riconducono il discorso, nella sua univocità e linearità, all’autore-demiurgo, a un gioco di significazioni preliminari che attendono solo di essere decifrate, per manifestare una qualche verità nascosta che attende il suo disvelatore. In un mondo nel quale esplodono ai quattro angoli del pianeta movimenti leaderless, ci sforziamo di ricondurre a un capetto, a sua volta succube di un capo, questo movimento, replicando con insensatezza i tentativi di liquidare come complotti eterodiretti dal capitale le donne di NUDM e i Friday For Future.
E se invece quelli (non “quello”: quelli) delle sardine fossero discorsi plurali, discontinui, la cui multilateralità – piena di discontinuità, contraddizioni, scabrosità, stop-and-go – fosse il prodotto di decine di migliaia di voci che si ritrovano in un ambiente aperto qual è una piazza pubblica, nella forma dell’assemblea di fatto?
Se questi discorsi non fossero riducibili alla rarefazione del discorso singolare, del singolo tweet o della singola apparizione televisiva?
Se, in luogo di un contenutismo che finisce per essere brutale pragmatismo, si cecasse di leggere l’ordine del loro discorso programmatico come l’enunciazione di un possibile? Se ci si chiedesse, insomma, in quale mondo possibile, da costruire, avrebbero legittimità i loro enunciati?
Se rileggo i loro enunciati e i loro punti sardina, a mo’ di breviario – non anonimo né invisibile, per fortuna –, ci trovo la possibilità di un mondo nel quale nessuno è illegale; nel quale l’abrogazione dei decreti-sicurezza non potrebbe che essere il primo passo; nel quale sono le relazioni concrete che si istituiscono orizzontalmente, nella forma dell’assemblea e dell’alleanza fra corpi, a determinare il sociale; nella quale la vulnerabilità è il principio della composizione dei corpi e della potenza di essere (come Spinoza, e dopo di lui alcuni cari e cattivi maestri non hanno cessato di insegnarci).
È quello che vogliono le sardine? No, non ancora.
È quello che hanno la forza di fare? No, non per ora, domani chissà.
Che fare? Due possibilità, direi: stare alla finestra e aspettare che le cose siano decise da altri.
Oppure entrare nelle piazze delle sardine con i nostri discorsi e i nostri enunciati, e vedere cosa succede a mescolarli con loro. Provare a prolungare l’abrogazione dei decreti-sicurezza con parole come mediterranea, porti aperti, libertà di movimento. A moltiplicare il “Non siamo soli ma parte di relazioni umane” nella costruzione di corpi composti. A rafforzare l’appello alla bellezza contro la retorica populista ricordando, con Camus, che la bellezza e gli sfruttati ambedue esistono, e che stare dalla parte di entrambi non è impossibile, ed è il compito di una vita.