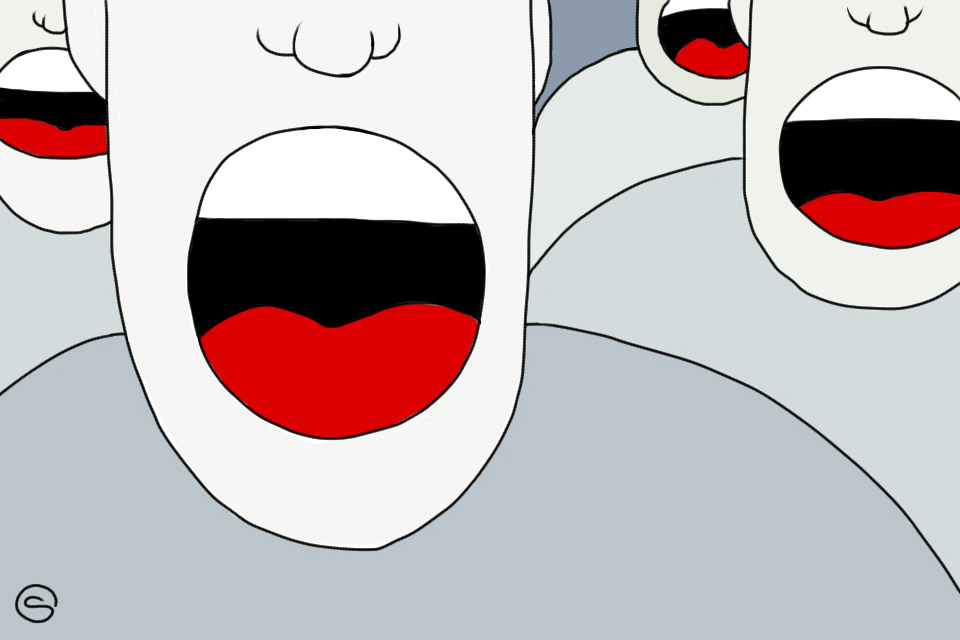di Astra, Communia Roma, Esc Infomigrante, Lab!Puzzle, Loa Acrobax, Resistenze Meticce, Yo migro – Strike.
“Sulla base delle situazioni vissute dai migranti nel mondo, la nostra ambizione è di far valere il diritto per tutti di circolare e di stabilire liberamente la propria residenza sul nostro pianeta e contribuire a costruire un mondo senza muri”.
Così recita la Carta Mondiale dei Migranti, approvata nell’isola di Gorée in Senegal, il 3 e 4 febbraio dell’anno 2011. Il punto di rivendicazione è particolarmente avanzato: alla dichiarazione del diritto alla libertà di circolazione per donne e uomini in carne ed ossa, nell’era della governamentalità della mobilità umana, si aggiunge quella relativa alla praticabilità di autodeterminare la propria esistenza, i propri progetti, le proprie aspirazioni. Un atto di forza, intimamente politico, esercitato da soggettività in movimento che sono in grado di mettere in tensione categorizzazioni giuridiche e sociali, di nominare le disuguaglianze, di praticare, con i propri corpi inermi, sfiancati, spesso violentati e uccisi, una possibilità, oltre la specificità delle appartenenze sociali, etniche, culturali. Con questo non intendiamo dire che necessariamente in ogni atto di forza, come quello della violazione del confine, sia contenuto un processo di soggettivazione o di costruzione di pratiche e linguaggi comuni, né è nostra intenzione privare i migranti di esperienza e densità sociali, che, si sa, restituiscono capacità singolari ed articolate di agire progettualità e traiettorie di vita. Ci sembra, tuttavia, interessante, soprattutto in questa fase, ed almeno in parte, interpretare la gestione della mobilità umana (comunque, atto di sottrazione, contestazione, cittadinanza) come paradigma della crisi della governance europea. Una mobilità che, ricordiamo, è anche dentro lo spazio europeo, praticata da intere generazioni precarie, “in pelle nera o bianca”, cresciute nella retorica dell’assottigliamento delle frontiere interne e della comune identità europea.
Più volte abbiamo ribadito in questi anni, al fianco di chi si mette in viaggio e per il nostro comune orizzonte, come, insieme, in una trappola mortifera, austerity e populismo di stampo xenofobo, abbiano funzionato quale dispositivo di confinamento materiale e simbolico delle vite, nella gestione degli spazi metropolitani, dei mercati del lavoro e dei regimi di welfare, contribuendo ad assegnare posizioni subalterne e differenziali nell’accesso alla cittadinanza e ri-producendo diseguaglianze sociali.
È vero, le frontiere hanno, negli ultimi anni, spesso, mutato forma; ed hanno assunto con il tempo e con le continue normazioni un compito sempre più complesso nel contenimento dei corpi, contribuendo a selezionare chi è autorizzato o meno a fare ingresso nello spazio europeo ed a sostenere il processo di differenziazione delle molteplici forme della mobilità umana, nell’ottica di una specifica ri-collocazione all’interno della stratificazione economica, sociale e culturale. Le missioni militari dal carattere salvifico/umanitario, la nascita delle burocratiche procedure degli hotspot, le politiche di relocation, la ridefinizione della vocazione dei Cie, come anche la pluriformità (Cara, Hub, Cas…) del lucroso sistema di accoglienza, vanno interpretati, pertanto, come elementi funzionali, in modo articolato, e per approssimazione, alla strategia europea della chosen migration, situata già nella metà degli anni duemila (a partire dal 2005) ed enfatizzata durante gli anni della crisi economica e finanziaria. Un processo ampio, che coinvolge i cosiddetti Paesi terzi attraverso i partenariati per la mobilità, l’esternalizzazione delle frontiere, il potenziamento anche finanziario degli aspetti investigativi del controllo, che ha come effetto immediato quello di allargare l’esperienza di “illegalizzazione”, di discriminare l’accesso alle risorse (peraltro sempre più scarse) e di rendere maggiormente ricattabile e disponibile la soggettività al lavoro. L’insistenza sulla migrazione altamente qualificata (highly skilled), rimanda, nei documenti europei, alla capacità di attrazione delle nostre economie e sarebbe correlata alla “carenza di competenze” sul mercato, quando sono noti sia i meccanismi di disarticolazione delle politiche di demand driven, sia i processi di de-qualificazione ed overeducation che caratterizzano la partecipazione al mercato del lavoro della manodopera straniera (la Carta blu UE, direttiva 2009/50/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 108/2012, così fortemente sbandierata, conterebbe poco più di un centinaio all’anno di titolati altamente qualificati che hanno fatto ingresso nel nostro territorio nazionale, nel 2014 e 2015). Disambiguare le interpretazioni sulla nozione di “competenza” e disvelare le sofisticate misure (anche normative) messe in atto, soprattutto nell’ultimo decennio, per attrarre manodopera scelta, fidelizzata e fortemente “mobile”, ci appare, in questa fase, quanto mai prioritario.
È trascorso poco più di un anno dalla presentazione dell’Agenda europea sulla migrazione (Bruxelles, 13 maggio 2015), che ha avviato un mutamento, o più precisamente un ispessimento, del concetto di frontiera da parte dell’Unione, accelerato dall’aumento del numero dei migranti intenzionati a chiedere asilo nel nostro territorio.
Il flusso di profughi (gestito in ottica mainstream come “crisi dei rifugiati”) che dal 2015 si è orientato attraverso la nota Balkan Route, diretto principalmente verso i paesi del nord Europa, ha incontrato sempre più ostacoli a causa delle barriere erette ai confini dei Paesi di transito, a prescindere dall’orientamento politico dei governi, con la minaccia, ventilata ed in alcuni casi attuata (si pensi alle proposte di Slovenia, Ungheria, Austria, Croazia, etc.) in forma temporanea, di non applicare il Trattato di Schengen.
Il fronteggiamento e la gestione dell’attuale situazione di “emergenza” si fonda, nell’idea della Commissione, su alcuni pilastri: l’istituzione di “punti di crisi” (hotspot, appunto) multifunzionali atti a velocizzare le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo; il controllo delle frontiere esterne (dando maggiore efficacia ai dispositivi di rimpatrio) e la lotta contro la migrazione irregolare, la tratta e il traffico di migranti; la cooperazione con i Paesi terzi strategici, di transito e origine dei flussi, rafforzata attraverso programmi di sviluppo e protezione regionale (a cominciare dal Niger, il Mali, l’Africa settentrionale e il Corno d’Africa); il consolidamento di un quadro unitario delle politiche e delle procedure di asilo, perché si controllino gli abusi dovuti ai processi di asylum shopping; il rafforzamento dei canali per la migrazione legale e qualificata (in assenza di quote nazionali di ingresso per lavoro disponibili) e l’integrazione socio-occupazionale, soprattutto delle fasce di popolazione maggiormente vulnerabile.
In risposta alla portata dei flussi, comunque contenuti nello spazio europeo rispetto ai Paesi situati nelle regioni interessate da conflitti, la strategia adottata in attuazione dell’Agenda è chiara: applicare politiche storicamente sostenute dalle destre europee, come il mantra “aiutiamoli a casa loro” (cui forniscono una cornice politically correct le recenti misure di co-sviluppo regionale), a costo di forzare il diritto internazionale, o addirittura di riscrivere sostanzialmente il diritto d’asilo.
Tra maggio e settembre 2015, la Commissione Europea ha di fatto ristretto le possibilità di accedere alla procedura di richiesta di protezione internazionale, introducendo il metodo basato sugli hotspot, centri di frontiera in cui identificare e fotosegnalare i migranti, con cui vengono immediatamente e sommariamente distinti i potenziali richiedenti asilo dai migranti cosiddetti “economici”, in un’opera di costruzione sistemica e sociale dell’irregolarità, della discriminazione, anche fisica, tra soggetti potenzialmente titolari di diritti e soggetti che non lo sarebbero. Alla solerzia con cui sono stati realizzati gli hotspot, dove l’accesso alla procedura per la protezione è reso difficile (in Italia) o ai limiti dell’impossibile (in Grecia), si contrappongono gli esigui effetti reali della ricollocazione per la redistribuzione fra gli Stati membri di richiedenti protezione internazionale sbarcati in Italia e Grecia, in base a quote nazionali calcolate con criteri condivisi. Ad oggi, poche centinaia di ricollocati (a febbraio i numeri parlano di 279 dall’Italia e di 1.500 in tutto tra Italia e Grecia), mentre la proposta di introdurre stabilmente il meccanismo, superando di fatto il Regolamento di Dublino, che impone al primo Paese membro in cui il migrante arriva la competenza sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, è stata bocciata. E allora, niente ricollocazioni interne: più facile imporre come scrivere una finanziaria per uno Stato membro, o realizzare centri e procedure che limitano il diritto d’asilo, piuttosto che realizzare una politica “razionale” di distribuzione dei richiedenti protezione internazionale. Come salvare Schengen, senza rivedere Dublino?
L’accordo UE-Turchia di marzo. Un atto che aggira l’approvazione che il Parlamento europeo deve dare ai Trattati, entrato in vigore dal 1° giugno, fondato sul riconoscimento della Turchia come Paese di transito sicuro, per questo considerato compatibile anche per il reinvio di potenziali richiedenti asilo provenienti dall’interno del Paese, tagliando fuori anche questa categoria (inclusi i siriani) dall’ingresso nell’area Schengen. Difficile immaginare i rimpatri forzati e per gruppi etnici verso la Turchia senza una violazione del divieto di respingimento, per cui ogni domanda d’asilo deve essere esaminata individualmente, non secondo l’appartenenza a una collettività; drammaticamente grottesco venire a conoscenza di espulsioni di Kurdi in Turchia, o anche di siriani e afghani dalla Turchia verso Paesi notoriamente sicuri come Siria e Afghanistan…dove intanto si continua a morire.
Con il Migration Compact, ad aprile, il governo Renzi ha proposto all’UE di implementare in altri Paesi, e con una cornice più strutturata, l’accordo con la Turchia. Il documento, incassato il consenso delle principali figure istituzionali comunitarie, è indicato dalla Comunicazione CE del 7 giugno come alla base del piano per “un nuovo partenariato con i Paesi terzi in tema di migrazioni”, che viene discusso in questi giorni (28 e 29 giugno) in Consiglio Europeo a Bruxelles.
Il piano europeo si basa su accordi con Paesi terzi africani (insieme a Giordania e Libano) e sulla stabilizzazione della Libia. Come nel caso della Turchia, che riceverà 6 miliardi di euro di finanziamenti per accogliere ed integrare i profughi, si prevede un piano di investimenti pubblico-privati che dovrebbe generare un volume complessivo di 62 milioni di euro, subordinando l’uso della cooperazione internazionale ad una collaborazione nelle politiche di blocco delle partenze e di riammissione di coloro che, da quei Paesi, ritenuti al pari della Turchia come Paesi terzi sicuri, tentano di entrare nel territorio degli Stati europei. La proposta del governo italiano, inoltre, getta le basi per produrre una nuova ondata di dispositivi economici, politici e militari di natura neocoloniale, da distribuire nei paesi “di origine” e “di transito” che saranno coinvolti. Nella prospettiva del Migration Compact, infatti, la gestione e il contrasto dei flussi migratori diventano una leva attraverso cui aprire mercati per i capitali europei, esportare e distribuire tecnologie militari e agenti in carne e ossa, spingere i Paesi africani a integrarsi sempre più massicciamente nei mercati finanziari internazionali. Siamo sicuri che se questo piano venisse implementato, i flussi migratori potrebbero diminuire solo a patto di dispositivi polizieschi di controllo sempre più crudeli, perché all’interno di un simile piano le cause che costringono tante persone a partire potranno solo aumentare ed acuirsi.
Se, come sembra, l’attuazione dell’Agenda europea sulle migrazioni avverrà a botte di compact con Paesi africani e mediorientali, si assisterà ad una netta restrizione delle possibilità di riconoscimento del diritto di asilo in Europa, già depotenziata fortemente dall’approccio hotspot, generatore di “illegali”, in piccola parte tradotti nei Cie e in maggioranza destinatari di provvedimenti di respingimento differito, con l’ordine di lasciare il territorio nazionale in 7 giorni. “Illegali” costretti a scegliere tra due opzioni: rimanere irregolarmente sul territorio italiano lavorando in condizioni invisibili e precarie o tentare la prosecuzione della traiettoria migratoria, pur se già identificati, ancora più vulnerabili di fronte alle limitazioni imposte dallo spazio europeo. “Illegali”, cui si aggiungono richiedenti asilo che vorrebbero ricongiungersi in Europa con familiari e comunità di origine o soggetti che semplicemente si sono sottratti dall’identificazione fotosegnalata. Uomini e donne (spesso con bambini ed anziani al seguito) in cammino.
Lo spazio europeo, oltre le territorialità nazionali, resta il nostro orizzonte semantico e politico. Lo è dentro ed insieme a quello metropolitano, prefettizio e ingovernabile, in cui si riconfigurano, nell’individualizzazione e precarizzazione delle vite, “nuovi assemblaggi di territori, poteri e soggettività” (per dirla con Sassen), fuori dalle dicotomie centro/periferia. Entrambi i territori emergono come campi di conquista delle politiche neoliberiste e dei provvedimenti securitari, xenofobi e della “integrazione buona”, quella che retoricamente e simbolicamente (ma non per questo senza ripercussioni ed effetti gravi sulle vite dei soggetti) costruisce regimi di significazione escludenti e marginalizzanti.
È proprio in questi spazi che incontriamo quelle “eccedenze umane” mobili che mettono in tensione ogni lettura semplificata e rigida delle frontiere e dei confini.
Chi attraversa, chi transita, da identificato o respinto in via differita, precedentemente vagliato e selezionato, esprime bisogni, domande, desideri, che interrogano, innanzitutto, il sistema dei servizi e quello dell’accoglienza. Ma che sono già oltre il confine.
Politicizzare tale “campo” di azione significa, a nostro avviso, mettere fortemente a critica un modello di accoglienza basato poliedricamente su assistenzialismo, contenimento, emarginazione e sfruttamento delle vite (di ospiti e operatori). Ma significa anche marcare un territorio, attraverso la tessitura di relazioni ed esperienze sociali, che siano in grado di segnare uno scarto rispetto alla filantropia assistenzialista (pur necessaria), sperimentando metodi, dispositivi, linguaggi innovativi.
Idomeni, Lesvos, Ventimiglia, Calais, Taranto, Castelnuovo di Porto…, in modo differente ed a differenti livelli, evocano percorsi di solidarietà concreta e pratiche conflittuali e costituenti contro i confini e, al di là di essi, le forme di confinamento dentro lo spazio metropolitano, in cui esperimenti di forme di mutualismo, accoglienza e cooperazione dal basso convergono con l’ambizione di decidere sulla gestione degli assetti territoriali, dei servizi, degli spazi, delle relazioni sociali, dei modelli di convivenza.
Restituire dignità, quale capacità di voice e agency, ai soggetti che animano queste esperienze può anche voler dire semplicemente camminare loro accanto.