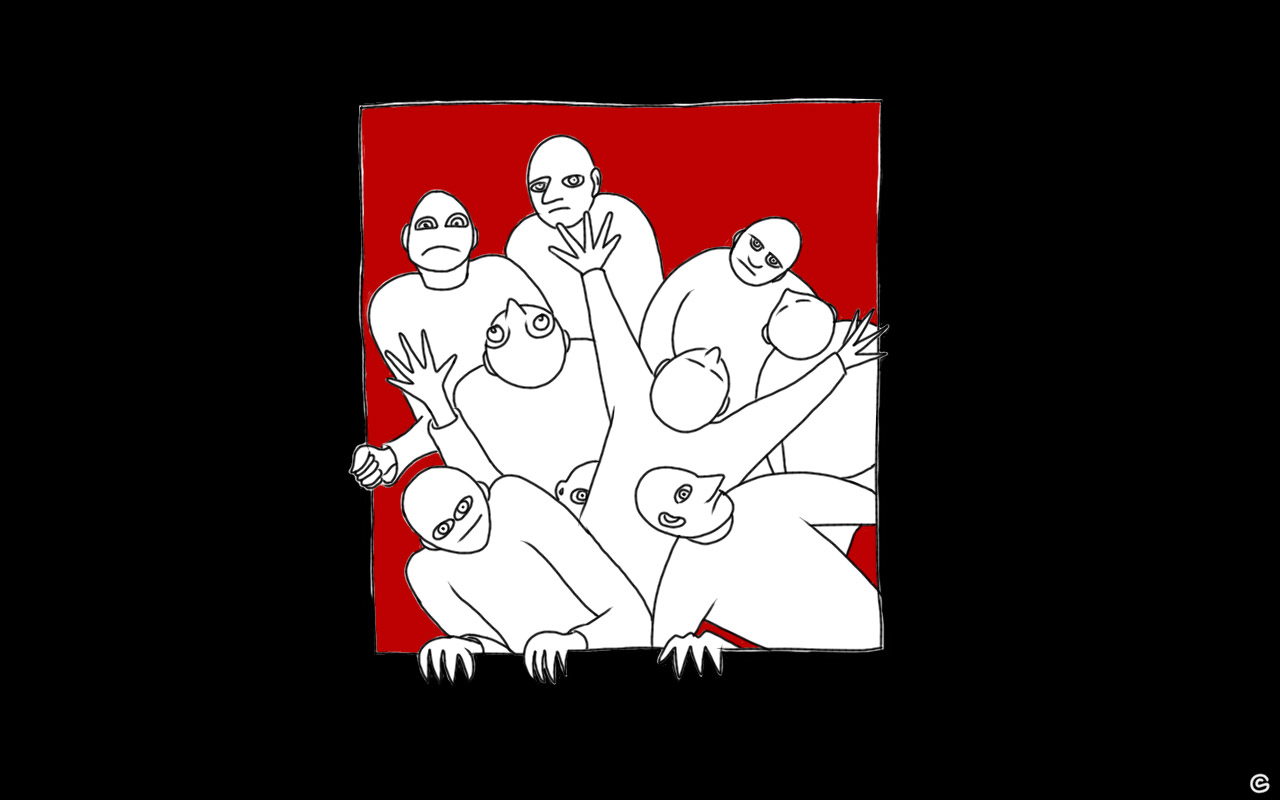di GIROLAMO DE MICHELE.
Nel mio cuore ho un debole per storpi, bastardi e cose rotte (Tyrion Lannister)
1. Di cosa scriviamo quando scriviamo (di crisi)?
Il successo mediatico di Game of thrones – fiction tratta dalle Cronache del ghiaccio e del fuoco di G.R.R. Martin – sembra non conoscere limiti: record di ascolti, moltiplicazione di discussioni on line sui possibili finali della serie (per la cui conclusione si dovrà attendere il 2019), mobilitazione della stampa mainstream, più o meno costretta a confrontarsi con un prodotto popular che mescola con accortezza leggibili riferimenti storici, miti, citazioni filmiche e ogni altra possibile scheggia dell’inconscio collettivo che le immagini-movimento hanno prodotto e sedimentato, con un mix di “alto” e “basso”, tanto per il materiale quanto per gli immaginari di riferimento che non può non far pensare alle analoghe macchine narrative di Boiardo e Ariosto. Al netto di qualche grande firma che, mobilitata per “alzare il livello” della critica televisiva, è incorsa in memorabili scivoloni – tipo credere che l’appellativo “madre di draghi” per Daenerys significhi che «la fatina bionda partorisce draghi sputafuoco»; o l’improbabile quête di un improvvido chevalier du lac che ha relegato il genere fantasy nel campo del reazionario (ma che te lo dico a fare?) –, questa narrazione seriale può venir buona per allargare il discorso al campo dell’immaginario, e dell’inconscio che lo produce. Mettendo in chiaro che la condizione di questa produzione è quella delineata nel cuore della crisi da un acutissimo scritto di Lanfranco Caminiti, che in qualche modo tracciò il confine nel 2011:
Lo spread non comunica nulla, se non un dato che sembra oggettivo e bizzarro come il tempo: accanto alle informazioni meteo, le televisioni e i quotidiani vanno introducendo le informazioni spread. Lo spread non appartiene alla nostra esperienza umana quotidiana, a meno di non essere uno che tutti i giorni interviene sul mercato secondario dei titoli. La continua reiterazione dei movimenti dello spread ha finito per uccidere qualsiasi narrazione possibile. Forse, è proprio questo il punto: l’informazione, ossessiva, espropria la narrazione. Siamo inzeppati di analisi, grafici, ragionamenti, statistiche e sequenze, ma piuttosto di facilitarci nel comunicare qualcosa, una qualsiasi esperienza, questa mole di dati diventa disumana, un paesaggio di macerie, una voragine. Non ci sono eroi, nello spread, non ci sono codardi, non ci sono passioni, amori, tradimenti. Lo spread non potrà mai essere un personaggio. E senza personaggi non ci sono storie.
Giusto per capire di cosa parliamo, quando parliamo di produzione e narrazione di immagini.
2. Affinità e divergenze fra noi e i compagni (maschi) di Podemos
Nel poco appassionante (non certo per il tema, e con le dovute eccezioni) dibattito sul centenario della Rivoluzione d’Ottobre, è difficile negare (e perché, poi?) che la selvaggia cavalcata dei Dothraki contro le falangi dei Lannister non abbia provocato un brivido in chi ancora si riconosce nel sintagma “rude razza pagana”; e che il vedere la Khaleesi cavalcare il drago volante e sbaragliare le schiere della Regina non abbia causato un qualche sussulto di memoria verso quei compagni generosi ma avventati – o forse: avventati perché generosi – che si chiedevano, 40 anni fa, quale rapporto istituire fra venti di scirocco, guerra rivoluzionaria e aviazione.
E non potevano suonare aliene a orecchie educate le discussioni fra Daenerys, Tyrion e John Snow su dove vada posto il punto di equilibrio fra uso della forza rivoluzionaria, senza che il mezzo si rovesci in fine, l’effetto in causa – cioè il terrore in terrorismo (avranno discusso in questi termini Lenin e Trotzkij, nel ’17?). E – diciamola tutta – vedere lord Randyll Tarly, un servile gendarme razzista che parla come Salvini e assomiglia a Minniti, ardere come uno zolfanello, non poteva lasciare insensibili. Insomma, il Trono di Spade solletica l’analogia politica, e la rifonda nella forma della favola.
È quello che già nel 2013 avevano compreso Pablo Iglesias e i compagn@ di Podemos, scrivendo a più mani Vincere o morire. Lezioni politiche nel Trono di Spade, tradotto quest’anno da Nutrimenti (pp. 328, € 18). Che può darci indicazioni utili sia su come interpretare la fiction, sia sulle produzioni teoriche dentro Podemos. In verità, i contributi del libro sono stati scritti fra la terza e la quarta serie, e dunque alcune affermazioni sono state smentite e/o superate dalla narrazione. Una fra tutte: che degli elementi fondanti della legittimità sia assente l’inclusione – è la critica di Monedero – è cosa che di certo, dopo l’ingresso dei Bruti e dei Dothraki sulla scena del Nord, cioè nel campo del politico, non è più affermabile.
Il che apre diversi problemi, soprattutto nella componente maschile del libro.
 In sintesi: un gruppo di autori (Pablo Iglesias, Carlos Monedero, Íñigo Errejón Galván) riduce la complessità narrativa al solo tema politico, nei termini di un conflitto per il potere letto tenendo insieme il Machiavelli del Principe, Laclau e Mouffe, con pesanti (e ambigue) inserzioni schmittiane e un tentativo malriuscito di recuperare Gramsci che in questo caso suona un po’ come il tentativo di aggiungere un vermuth di marca a un Americano Rosso fatto col Crodino. È sintomatico che questa ermeneutica si incarti in una discussione sulla figura di Daenerys Targarian, che viene desessualizzata e risignificata come mero (al neutro) portatore di potere – da cui l’altrettanto inadeguata lettura unilaterale della figura dei draghi come forza rivoluzionaria o, all’opposto, come arma di distruzione di massa. E l’altrettanto insoddisfacente giudizio unilaterale su Ed Stark, prototipo del politico dai principi morali incrollabili che «non si preoccupa che il mondo sia buono: l’importante è che sia lui il buono» (Iglesias). Il che sembra svalutare il dilemma, tuttora presente, fra rigore morale e opportunismo necessario (mentre Winter is coming – anzi, Winter is here), e sottintendere che i parrhesiasti hanno la nobile morte che si meritano, ma la politica è altro.
In sintesi: un gruppo di autori (Pablo Iglesias, Carlos Monedero, Íñigo Errejón Galván) riduce la complessità narrativa al solo tema politico, nei termini di un conflitto per il potere letto tenendo insieme il Machiavelli del Principe, Laclau e Mouffe, con pesanti (e ambigue) inserzioni schmittiane e un tentativo malriuscito di recuperare Gramsci che in questo caso suona un po’ come il tentativo di aggiungere un vermuth di marca a un Americano Rosso fatto col Crodino. È sintomatico che questa ermeneutica si incarti in una discussione sulla figura di Daenerys Targarian, che viene desessualizzata e risignificata come mero (al neutro) portatore di potere – da cui l’altrettanto inadeguata lettura unilaterale della figura dei draghi come forza rivoluzionaria o, all’opposto, come arma di distruzione di massa. E l’altrettanto insoddisfacente giudizio unilaterale su Ed Stark, prototipo del politico dai principi morali incrollabili che «non si preoccupa che il mondo sia buono: l’importante è che sia lui il buono» (Iglesias). Il che sembra svalutare il dilemma, tuttora presente, fra rigore morale e opportunismo necessario (mentre Winter is coming – anzi, Winter is here), e sottintendere che i parrhesiasti hanno la nobile morte che si meritano, ma la politica è altro.
Ancor più incongruo è, nel tentativo di calare la narrazione del Trono nelle categorie di Laclau e Mouffe, il tentativo di affermare un “vuoto” nella scena politica di Westeros, confondendo di fatto “potere” con “governo”. Se la morte del re Baratheon, e le due deboli successioni del giovani sovrani Lannister (il folle Joffrey e il manipolabile Tommen) creano un vuoto di governo, del quale provano ad approfittare forze esterne – la casa Tyrrell, la setta ultrareligiosa e populista del Credo Militante –, è anche vero che, com’è del resto ovvio, non c’è mai un vuoto di potere, perché il potere è dappertutto: nella famiglia Lannister, nelle finanze della Banca di Ferro, e via via diffuso nel mille rivoli dei poteri locali, fino alla Barriera, e oltre – financo fra i Bruti e gli Estranei. E fra questi rivoli si tessono le mille trame che irretiscono i corpi e le soggettività.
Secondo Errejón Galván, questa pluralità si condensa nel concetto schmittiano di lotta: «tutti i concetti, le espressioni e i termini politici hanno un senso polemico». Termini quali Stato, repubblica, società classe, sovranità, e via dicendo,
Sono diversi campi di battaglia, ogni volta occupati da nuovi sfidanti; con parole di Ernesto Laclau, significanti vuoti, non associati a un significato particolare, che possono rappresentare una molteplicità di elementi eterogenei, e che per breve tempo si appropriano di uno di questi elementi nel momento in cui un nuovo confine li ancora e li associa a un’identità popolare che acquista la legittimità di pretesa universale.
Ed è la guerra, «funzione interna alla politica», che determinando «il pensiero e l’azione dell’uomo» (Schmitt) provoca quello specifico comportamento politico che «determina le fazioni e le identità» (Laclau e Mouffe).
In definitiva, conclude Errejón, «nel Trono di Spade l’unica certezza è la lotta»: una lotta concepita come mero gioco di potere. Non a caso, alcuni autori si lasciano sedurre dalla discussione fra Varys e lord Baelish sulla natura del caos: se sia un pozzo profondo, come afferma Varys (la cui azione politica sembra orientata a trattenere il caos per salvare il Reame), o una scala che va percorsa, come sostiene Baelish, il cui agire mira a destituire ogni legittimità esistente senza costruire alcunché, costi quel che costi. Viene da chiedersi se non sembri un dialogo sul politico fra Cacciari e Agamben. Ma oltre le due facce del nichilismo politico ci sono istituzioni e moltitudini, la cui comprensione sembra negata al Ragno Tessitore e a Ditocorto, così come ai loro ermeneuti (e anche a chi, dedicando una vita a girare attorno al nichilismo di Schmitt, si è mosso da destra a sinistra rimanendo sempre sullo stesso posto).
3. Sovversione dei ruoli e guerra queery
Errejón e Iglesias non avevano visto la quinta e sesta serie, scrivendo i loro saggi: ma avevano cospicui elementi, dentro e fuori la fiction, per non cadere nell’errore che la serie si è incaricata di smentire.
 Il loro montaggio di Laclau, Schmitt e un Machiavelli appiattito sul solo Principe funziona solo a condizione di espellere dal campo di battaglia i processi di soggettivazione e le composizioni di classe dei soggetti: e di considerare equivalenti la presa di potere di Daenerys, che spezza le catene delle schiavitù e compone una coalizione di ex reietti – barbari, eunuchi, schivi, donne (e draghi) – con l’ascesa al potere della setta fanatica del Credo Militante, una sorta di Popolo della Famiglia guidata da un più sobrio sacerdote (l’Alto Passero), che si avvale di un consenso di massa nella plebe della capitale, che passa dall’asservimento alla corona (uno dei motti dei Lannister è: «un leone non si chiede cosa pensa il gregge») all’asservimento a un’ideologia integralista che si nutre del richiamo populista al disprezzo verso i regnanti, il cui apice è la Marcia della Vergogna che la Regina reggente Cersei, denudata e indifesa, è costretta a fare, esposta al ludibrio e al disprezzo in quanto donna e corpo sessuato e osceno cui sono attribuite condotte immorali. Nulla, nelle tesi di Laclau ed Errejón, permette di sottoporre a critica la volontà di potere del Credo Militante, straordinaria (nella sua verosimiglianza) esemplificazione di quelle pulsioni populiste e razziste nelle quali taluni piccoli lenin de noantri credono di potersi immergere.
Il loro montaggio di Laclau, Schmitt e un Machiavelli appiattito sul solo Principe funziona solo a condizione di espellere dal campo di battaglia i processi di soggettivazione e le composizioni di classe dei soggetti: e di considerare equivalenti la presa di potere di Daenerys, che spezza le catene delle schiavitù e compone una coalizione di ex reietti – barbari, eunuchi, schivi, donne (e draghi) – con l’ascesa al potere della setta fanatica del Credo Militante, una sorta di Popolo della Famiglia guidata da un più sobrio sacerdote (l’Alto Passero), che si avvale di un consenso di massa nella plebe della capitale, che passa dall’asservimento alla corona (uno dei motti dei Lannister è: «un leone non si chiede cosa pensa il gregge») all’asservimento a un’ideologia integralista che si nutre del richiamo populista al disprezzo verso i regnanti, il cui apice è la Marcia della Vergogna che la Regina reggente Cersei, denudata e indifesa, è costretta a fare, esposta al ludibrio e al disprezzo in quanto donna e corpo sessuato e osceno cui sono attribuite condotte immorali. Nulla, nelle tesi di Laclau ed Errejón, permette di sottoporre a critica la volontà di potere del Credo Militante, straordinaria (nella sua verosimiglianza) esemplificazione di quelle pulsioni populiste e razziste nelle quali taluni piccoli lenin de noantri credono di potersi immergere.
Al contrario, volendo giocare con i concetti della politica, la coalizione di Daenerys è innervata da una composizione di classe all’interno della quale la Kaleesi ha saputo leggere non solo la composizione tecnica dei reietti, ma anche e soprattutto la loro composizione politica, con un processo di guerra rivoluzionaria nella quale l’offensiva contro la casa regnante è al tempo sesso processo di soggettivazione di soggett@ liberi non per concessione della regina, ma “liberati” perché si sono riappropriati di una libertà che apparteneva loro. Con le parole di René Zavaleta citate da Castillo e Porras:
Un’articolazione storica tra forza e novità, un’articolazione di base o di sovrastruttura, del tipo di vita interna o culturale, ovvero di valori e sensi con i quali si vedono e sperimentano le forze produttive e le relazioni sociali.
Daenerys non si limita a conquistare legittimità attravrso il carisma: crea istituzioni ed eserciti, che a loro volta producono metamorfosi e sovversioni delle credenze, dei costumi, delle pratiche. Pratiche costituenti, insomma: lungi dal limitarsi al Principe, di Machiavelli la Kaleesi sembra aver letto soprattutto i Discorsi, e anche – non è cosa da poco – Dell’arte della guerra.
Il discorso di Daenerys agli schiavi:
Non mi dovete la vostra libertà. Io non posso darvela. Non mi appartiene, quindi non posso darvela. Se la rivolete, dovete riprendervela da soli!
non può essere ricondotto alla sola diade potere/legittimità, perché, al di là del consenso immediato, esso costituisce l’avvio di una riappropriazione di sé in termini di risoggettivazione. Esemplare, non per caso, è la figura di Missandei, la giovane scriba ed ex schiava che traduce il discorso di Daenerys agli assoggettati, e che nel corso della serie rimarca più volte il proprio essere divenuta libera, fino all’appropriazione della propria sessualità attraverso pratiche (il suo amante è un eunuco che non può penetrarla) che il Credo Militante, e anche il Popolo della Famiglia, avrebbero bollato come oscene. Ma non si faccia l’errore di scambiare Daenerys per un archetipo, o prototipo, femminile: nel Trono di Spade c’è una tale pluralità di figure femminili, da riempire ogni casella di una eventuale tassonomia – dai ruoli più “alti” a quelli più “bassi”, dal più al meno nobile sotto qualsivoglia profilo etico, politico, sociale. Non una di meno, per davvero. E non una di meno anche rispetto alla violenza di genere: se fino a un certo punto poteva sembrare che (lo aveva rilevato, in modo non banale, Zerocalcare) ci fosse una certa compiacenza e una apparente mancanza di attenzione a come si narra uno stupro, ora sappiamo che anche questa forma di violenza è un’esperienza dalla quale il corpo femminile viene attraversato, ma che questo attraversamento produce effetti – al limite, la vendetta. E in ogni caso, come mostra lo stupro “simbolico” che subisce Cersei, uno stupro è uno stupro, chiunque sia la vittima.
Non è quindi un caso che siano proprio le letture femministe (Cristina Castillo, Sara Porras, Clara Serra Sánchez) che, coniugando Butler con Foucault, mettono in luce la differenza femminile e la riappropriazione del corpo come centro di quel vortice di soggettivazione che porta non solo la Kaleesi, ma l’intera moltitudine di donne, bastardi, eunuchi, nani prostitute, invalidi, mutilati, uomini effemminati o donne mascoline, insomma di portatori e portatrici di una «vita impossibile» (Butler) a metamorfosare la propria identità e a «insorgere agendo»: perché «tutti possono ribellarsi contro ciò che li vincola, sì, ma non li assoggetta completamente» (Serra Sánchez e Fernández Rubiño). La libertà dei “soggetti inverosimili” è il divenire della sovversione dei ruoli all’interno di una guerra queery (Castillo e Porras) – del resto, non si diceva un tempo che comunismo è processo al comunismo?
Questo ci porta a un’ultima osservazione: il Trono di Spade si caratterizza per un alto numero di protagonisti che non sopravvivono. Si dirà: c’è la guerra di tutti contro tutti. Vero: ma cosa determina la sopravvivenza, poniamo, di un John Snow e di un Tyrion Lannister, e la morte di Eddard o Rob Stark? Una certa predisposizione alla mutevolezza, alla flessibilità. Di fatto, a morire non sono né i “buoni” né i “cattivi”: sono quelli che non sanno adattarsi al mutamento, che non variano la propria natura. Che hanno, direbbe Machiavelli, natura triste. Mentre quasi tutti i sopravvissuti hanno patito, o messo in atto, mutamenti nel carattere, nelle condotte, nelle credenze.
4. Del figurale nelle fiction
Il racconto è la mappa che è il territorio. Devi ricordarlo (Neil Gaiman, American Gods)
Se si accetta il piano discorsivo di Iglesias e compagn@ – il Trono di Spade come pre-testo per svolgere lezioni politiche –, questa lettura potrebbe concludersi qui. Ma facendolo, dovrei ignorare alcune eccedenze di senso che ci dicono che quello politico non è l’unico piano discorsivo possibile; o meglio: lo è, solo perché tutto – anche l’estetico, il narrativo, il simbolico – è politico.
«Nel Trono di Spade l’unica certezza è la lotta», scrive Errejón. Ebbene, no: l’unica certezza è l’Inverno.
Il valore simbolico dell’Inverno in arrivo eccede la sua ricodificazione come crisi economica globale, o crisi politica spagnola. Così come certe figure – dagli Estranei ai Draghi – eccedono le loro interpretazioni, peraltro di notevole povertà (soprattutto per gli Estranei). Fatto è che le figure del Trono di Spade sono più ricche delle loro attualizzazioni: e lo sono perché condensano un potenziale, un divenire che è irriducibile a ogni attualizzazione e presentificazione che si pretenda senza residui. Non siamo nel campo del presente storico, ma in quello del simbolico: ma è un simbolico in divenire. Non sono archetipi immutabili, ma figure che restano sé stesse pur mutando. Per le quali sembra valere quello che scrive Wendy Doniger O’Flaherty, che ha reinterpretato in modo originale e sovversivo (quantomeno per i fondamentalisti indù) le narrazioni mitiche induiste:
Poiché gli dei dell’Induismo sono «immortali» solo in un senso peculiarissimo – essi, infatti, muoiono e rinascono – la maggior parte dei grandi dilemmi umani ricadono nell’ambito della loro esperienza e sovente sembra che differiscano dai mortali solo in qualche dettaglio di minor conto, e ancor meno degli asura. Essi costituiscono dei simboli come nessun essere umano potrà mai costituire, per quanto «archetipica» sia la storia della sua vita. Essi sono altrettanti attori, i quali impersonano dei ruoli che sono reali soltanto per noi; sono le maschere dietro cui scorgiamo i nostri stessi volti. Per questa ragione le storie relative agli dei, alle quali io limiterei il referente del termine «miti», hanno un impatto del tutto diverso rispetto alle storie relative a esseri umani, che io chiamerei «leggende». [Introduzione a Dall’ordine al caos. Miti dell’induismo, Guanda, 1989, p. 17-18]
Se per le figure delle fiction, così come per quelle delle narrazioni filmiche o romanzesche, sembra valere quanto vale per le figure dei miti, la categoria di “realismo” viene investita da una dura critica, e con essa la distinzione fra personaggi, o figure, “realistiche” e “fantastiche”.
 Lo si vede bene prendendo come caso esemplare una fiction che ha profondamente modificato sia l’immaginario dello spettatore, sia le modalità pratiche di narrazione fictionale: The Wire. Questa serie ha segnato un prima e un poi rispetto all’insieme delle narrazioni noir o crime, e non solo (ne è un indice, ad esempio, la forma della sigla di apertura, che appare a tutt’oggi insuperata). The Wire si avvaleva di robuste dosi di mimesi del “reale”, grazie a due autori col culo in terra quali Ed Burns e David Simon (per il secondo si può senz’altro parlare di una esplicita adesione alla critica marxiana dell’economia politica). Ma chi ha creduto di poter etichettare The Wire con aggettivi come “sociologizzante” ha davvero capito poco o nulla: soprattutto, non ha compreso che le figure di quella serie sono tanto più reali (David Simon è stato per anni cronista di nera, Ed Burns insegnante nelle scuole pubbliche) quanto più sono archetipiche; la loro adesione alla realtà è l’altra faccia del fascio di potenzialità in divenire che ogni personaggio incarna. Il che spiega come mai, a distanza di 10 anni dalla sua chiusura, da certe modalità narrative di The Wire tutt’ora non se ne esce, neanche per una serie di recente successo come True Detective (quanto alle narrazioni sedicenti noir o crime italiane, meglio stenderci sopra un robusto plaid: non c’è Suburra o Pizzofalcone che valga i pionieristici tentativi del duo Lucarelli-Infascelli).
Lo si vede bene prendendo come caso esemplare una fiction che ha profondamente modificato sia l’immaginario dello spettatore, sia le modalità pratiche di narrazione fictionale: The Wire. Questa serie ha segnato un prima e un poi rispetto all’insieme delle narrazioni noir o crime, e non solo (ne è un indice, ad esempio, la forma della sigla di apertura, che appare a tutt’oggi insuperata). The Wire si avvaleva di robuste dosi di mimesi del “reale”, grazie a due autori col culo in terra quali Ed Burns e David Simon (per il secondo si può senz’altro parlare di una esplicita adesione alla critica marxiana dell’economia politica). Ma chi ha creduto di poter etichettare The Wire con aggettivi come “sociologizzante” ha davvero capito poco o nulla: soprattutto, non ha compreso che le figure di quella serie sono tanto più reali (David Simon è stato per anni cronista di nera, Ed Burns insegnante nelle scuole pubbliche) quanto più sono archetipiche; la loro adesione alla realtà è l’altra faccia del fascio di potenzialità in divenire che ogni personaggio incarna. Il che spiega come mai, a distanza di 10 anni dalla sua chiusura, da certe modalità narrative di The Wire tutt’ora non se ne esce, neanche per una serie di recente successo come True Detective (quanto alle narrazioni sedicenti noir o crime italiane, meglio stenderci sopra un robusto plaid: non c’è Suburra o Pizzofalcone che valga i pionieristici tentativi del duo Lucarelli-Infascelli).
Félix Guattari ha messo in luce come la narrazione filmica abbia sempre a che fare con un «”eccesso” delle materie dell’espressione sul contenuto» che rende problematico un possibile paragone fra l’inconscio al cinema e l’inconscio psicoanalizzato, e fra le reciproche repressioni. È innegabile che l’inconscio cinematografico subisca «la contaminazione dei significati di potere». Al tempo stesso l’inconscio cinematografico «si manifesta a partire da concatenazioni semiotiche» che non sono riconducibili senza residui a concatenazioni strutturate dalla rigorosa formalizzazione dell’espressione e del contenuto su piani distinti: «Il suo montaggio, a partire da spezzoni semiotici a-significanti, da intensità, da movimenti, da molteplicità, tende essenzialmente a sottrarlo alla delimitazione significante» [Félix Guattari, “Il divano del povero”, in Rivoluzione molecolare. La nuova lotta di classe, ed. or. 1977, ried. PGreco, 2017]. Da qui il conflitto permanente fra il tentativo di fissare l’inconscio filmico cristallizzando generi e stereotipi comportamentali «omogenei ai campi semantici dominanti», e la resistenza di un inconscio macchinico che mette in discussione, esprimendosi, «l’idea di un soggetto trascendentale dell’enunciato, l’opposizione tra discorso e lingua». Perché il «soggetto in sé» è null’altro che «una particolare opzione, quella di una specie di follia normale»:
È illusorio credere che esista soltanto un soggetto, un soggetto autonomo e centrato su un individuo.
Questa eccedenza che si esprime nelle narrazioni fictionali attesta che le fiction televisive hanno ormai raggiunto il livello dell’espressione filmica, e che ciò che si dice e si critica per l’una vale anche per le altre.
1 – continua ⇒ qui
(questo testo è dedicato ad Alan D. Altieri – Valar morghulis, bro’)