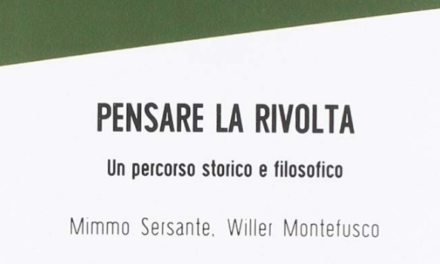di GIROLAMO DE MICHELE. (⇒ qui la prima parte)
È sempre l’assurdo mistero delle strane forze dell’esistenza… che ne dici di una vagonata di valium? (Albert Rosenfield)
5. «Di quale dio stiamo parlando?»
«Sì, è ancora la Terra di Dio», disse lo speaker del telegiornale, «ma la domanda è: di quale dio stiamo parlando?» (Neil Gaiman, American Gods)
Neil Gaiman ha fatto propria la pagina di O’Flannery – fornendo ai lettori una preziosa chiave di lettura – nel suo American Gods, un vero capolavoro della narrativa del terzo millennio, ora trasposto in una fiction di alto livello.
La trama è geniale, nella sua apparente semplicità: gli dèi del passato, migrati in America al seguito dei loro popoli («siamo arrivati fin qui viaggiando nelle loro menti», spiega Odino), si radunano attraversando gli States per combattere contro i nuovi dèi del mercato e dei media. È la secolarizzazione, bellezza! «Ben presto la nostra gente ci ha abbandonato, ricordandosi di noi soltanto come creature del paese d’origine, creature che credevano di non aver portato nel nuovo mondo», afferma ancora Odino: e mentre i vecchi dèi vivono nascosti esistenze sempre più miserabili – «ci spogliamo, ci prostituiamo e beviamo troppo; lavoriamo alle pompe di benzina e rubiamo e truffiamo e viviamo nelle crepe ai margini della società. Vecchi dèi, in questa nuova terra senza dèi» –, nascono nuove divinità «che crescono sopra nodi di fede: gli dèi delle carte di credito e delle autostrade, di Internet e del telefono, della radio e dell’ospedale e della televisione, dèi fatti di plastica, di suonerie e di neon».
Perché gli dèi esistono se ci sono uomini che credono in loro: si tratta di un conflitto interno all’immaginario – o, come afferma uno dei nuovi dèi, di un mutamento di paradigma dell’immaginario attraverso il quale le nuove divinità pretendono di possedere il futuro e di consegnare le vecchie alla discarica della storia. Perché, dopo tutto, la stessa America è un prodotto dell’immaginario:
San Francisco non si trova nello stesso paese di Lakeside più di quanto New Orleans non si trovi nello stesso paese che ospita New York, o Miami in quello di Minneapolis. Magari condividono alcuni simboli culturali – i soldi, il governo federale, gli svaghi – e ovviamente il paese è lo stesso, ma quel che crea l’illusione che si tratti di un’unica nazione sono i dollari, il Tonight Show e i McDonald’s, nient’altro». [E la stessa storia americana] è un frutto della fantasia, ingenuo schizzo a carboncino per la massima parte non verificata, pura rappresentazione della cosa, non la cosa in sé.
Ora, è pur vero che i nuovi dèi hanno riprogrammato la realtà: «il linguaggio è un virus, la religione un sistema operativo e le preghiere sono junk mail». Ma resta che le religioni – vecchie o nuove – «sono per definizioni metafore», punti di osservazione che condizionano le azioni, «posizioni di vantaggio da cui osservare il mondo»: sono produzioni linguistiche performative, così come lo è la narrativa. Ma attenzione:
La narrativa ci permette di entrare in altre menti, in altri luoghi, di guardare con altri occhi. E poi nel racconto ci fermiamo, prima di morire, oppure un sostituto muore per noi, che restiamo in buona salute, e nel mondo di là della storia voltiamo pagina o chiudiamo il libro, tornando alla nostra esistenza [c.n.].
Ma cosa accade al mondo della storia, quando noi chiudiamo il libro?
Cosa accade quando American Gods viene trasposto dalla pagina al piccolo schermo?
Dal punto di vista narrativo, alcune variazioni che attualizzano senza presentificare la narrazione rispetto alla pubblicazione del romanzo, nel 2002. Una in particolare ci interessa: l’inserzione di quella peculiare figura della divinità che è Gesù. Nel romanzo, di Gesù si parla solo di sfuggita: «Ho incontrato un tale che mi ha detto di averlo visto fare l’autostop in Afghanistan e nessuno si fermava a tirarlo su. Sai com’è, tutto dipende dal contesto». Nella fiction invece la sua figura è onnipresente e molteplice, ed esprime le diverse potenzialità del suo essere oggetto di fede religiosa. In particolare, come emblema della strage dei migranti, in una straordinaria sovrapposizione del piano simbolico e di quello cronachistico che apre la VI puntata, nella quale i migranti messicani incontrano il loro mexican Jesus mentre questi muore il loro martirio.
Nondimeno, la capacità di parlare al presente (di attualizzare la narrazione) nulla toglie alla natura di produzione simbolico-metaforica che rende possibile questa attualizzazione: produzione che è a-temporale, cioè sottratta alla presentificazione. Nella sua lunga ricerca critica sull’espressione cinematografica (quattro anni di corsi e due volumi), Gilles Deleuze ha sottolineato come l’immagine cinematografica non è mai al presente:
L’immagine è un insieme di rapporti di tempo da cui il presente non fa che derivare, sia come multiplo sia come il più piccolo divisore. I rapporti di tempo non sono mai visti nella percezione ordinaria, ma lo sono nell’immagine non appena essa è creatrice. [Gilles Deleuze, Il cervello è lo schermo].
Da cui, affermava Deleuze alla metà degli anni Ottanta, l’inferiorità della televisione, che «si ferma a delle immagini del presente, presentifica tutto». Questo gap è stato colmato da tempo. Anzi, la particolarità della forma-serie, con gli strumenti espressivi che le sono propri – l’interruzione, l’uso del clifthanger, la possibilità di una fruizione differita (di cui la produzione seriale è ormai consapevole, e con la quale fa i conti), il flashforward – consente di lavorare la forma-tempo in modi peculiari: si prendano, a titolo di esempio, l’uso del va-e-vieni temporale in serie come Downtown, True detective, e soprattutto How to Get Away with Murder. L’attualizzazione dell’evento narrato è la derivazione di un qui-e-ora da una generazione simbolico-metaforica effettuata da un inconscio produttivo che, nel caso di American Gods, si mostra in modo esplicito nell’atto di produrre simboli, figure, miti. Mostra che la produzione di figure è sempre produzione simbolica, e lo mostra mentre produce: narrazione e meta-narrazione al tempo stesso, come la macchina da presa che si mostra all’opera alla conclusione de L’orgoglio degli Amberson.
6. Questa è l’acqua e questo è il pozzo
«A Quentin Tarantino interessa guardare uno a cui stanno tagliando l’orecchio; a David Lynch interessa l’orecchio» (David Foster Wallace)
Di nuovo: cosa accade al mondo della storia, quando noi chiudiamo il libro? Dove “vanno”, o “restano” le creazioni dell’inconscio produttivo tanto del narratore quanto dello spettatore?
Si è detto: produzione di simboli e metafore. Cioè, direbbe qualcuno, la funzione primaria, propria del linguaggio, essendo i tropi concepiti come il carburante della macchina linguistica. Ma
Metafore e metonimie sono semplicemente degli effetti, che appartengono al linguaggio solo in quanto presuppongono già il discorso libero indiretto. Ci sono molte passioni in una passione, e ogni sorta di voce in una voce, tutto un rumore, glossolalia: ecco perché ogni discorso è indiretto» [Deleuze, Guattari, Mille piani (Postulati della linguistica)].
Dietro, o sotto, il va-e-vieni da un “io” a un “tu” c’è sempre una terza persona del singolare che va da un dire a un detto, così come dietro, o sotto, la distinzione fra tropi, fra (forma del) significato e (forma dell’) espressione c’è un unico piano del Reale, un piano di consistenza che ignora le differenze di livello, gli ordini di grandezza e le distanze, le differenze fra artificiale e naturale, la distinzione di contenuti ed espressioni. Tutto, nella macchina produttiva dell’inconscio, è concatenamento: «scrivere non ha niente a che vedere con significare, ma con misurare territori, cartografare, perfino delle contrade a venire» [Deleuze, Guattari, Mille piani (Rizoma)].
 È possibile narrare il piano di consistenza, l’altrove dei personaggi narrati, le forze che connettono le linee di fuga e, facendole precipitare, attualizzano la narrazione?
È possibile narrare il piano di consistenza, l’altrove dei personaggi narrati, le forze che connettono le linee di fuga e, facendole precipitare, attualizzano la narrazione?
Che è come dire: è possibile, nel campo della produzione fictionale, una narrazione che sia narrativa senza esserlo?
Si, è possibile, ed è anche piuttosto interessante – per dirla con DFW, autore di un magistrale scritto su Lynch (David Lynch non perde la testa, in Tennis Tv, trigonometria, tornando: ma in cosa non è magistrale DFW?), è anche fico. Sto parlando della serie 2017 di Twin Peaks – formalmente: I segreti di Twin Peaks – terza stagione. Con la quale Lynch sembra aver spinto la propria capacità narrativa al di là di diversi confini – o forse: ha spostato in avanti più di un confine, per poi superarlo comunque.
Se con American Gods avevamo l’immagine mitico-simbolica nell’atto del suo prodursi, con Twin Peaks è in scena le forze di produzione dell’immagine, prima che essa acceda al simbolico. Eppure, il simbolico si dà comunque: come effetto. Come ottenere l’effetto simbolico senza simbolo – rimanendo quindi al di qua della sua codificazione secondo una qualsivoglia sintagmatica significante? Ad esempio, con un sapiente uso dei volti, nei quali tutti gli effetti espressivi del volto in sé – dalle somatiche particolari all’inevitabile richiamo mnemonico causato dalla ricomparsa di volti al tempo stesso identici (perché attore e personaggio sono sempre gli stessi) e diversi (perché dalla seconda serie di Twin Peaks sono passati 25 anni), a volti-icona che portano con sé un vissuto che rimanda a quell’altrove delle loro comparse in precedenti film, con e senza Lynch. Laura Dern ed Henry Dean Stanton, per dirne due: la cui apparizione concatena lo spezzone narrativo nel quale sono inseriti ai vagabondaggi di Laura in Cuore selvaggio, o di Henry in Paris: Texas – ma anche: al suo essere l’immobile fine del viaggio del fratello in An american history. Eccetera. E poco importa se Lynch abbia o meno consapevolezza di quanto stia prolungando il lavoro di Pasolini sul viso dell’attore, sull’uso del volto comico popolare (Totò, Franchi e Ingrassia, Modugno, ecc.) come forma espressiva che supplisce a quell’assenza di materialità che il cinema paga nel confronto col teatro.
Si diceva, prima che cominciasse la terza serie: come potrà Lynch confrontarsi con una narrazione che gli deve moltissimo, che che è andata avanti dopo di lui (ad esempio: sulla velocità del tempo della narrazione)? La risposta è: alla sua maniera. Ovvero, fregandosene alla grande – Lynch narra come lo avrebbe fatto 25 anni fa; ma al tempo stesso, disseminando di microcitazioni – non più che appigli onirici – da quasi tutto quello che è stato girato negli ultimi anni. Per dirla con DFW: «la misura in cui a lui importa se qualcuno li ha colti o meno: 0».
Twin Peaks 2017, a rigore, non ha trama. Ma al tempo stesso ne ha una solidissima, costruita per concatenamenti mossi non da una narrazione significante, ma da qualsivoglia forma di accostamento, giustapposizione (per analogia, per contrasto, per ambivalenza, eccetera) di immagini e frame narrati(vi) asignificanti. Concatenazioni nelle quali ogni qui-e-ora è un altrove, perché ogni rappresentazione spaziale ha la struttura di un tempo (pur non essendolo: si pensi alla Loggia Nera), così come ogni scorrere del tempo ha l’effetto di uno spazio, ovvero mantiene in compresenza ciò che non dovrebbe coesistere (il/gli Dale Cooper). E, per inciso ma non per caso: quanto dell’uso degli spazi di Lynch è presente in quel gioiello british che è Utopia?
7. «Forse potrebbe tornarvi utile tenere a mente tutto questo»
«Per me, la decostruzione, come avviene nei film di Lynch, di questa “ironia del banale” ha influenzato il modo in cui vedo e strutturo mentalmente il mondo» [David Foster Wallace]
Due, in particolare, mi sembrano gli aspetti sui quali Lynch si è spinto più in là. Entrambi hanno a che fare con «l’assenza di senso o di finalità riconoscibili»: «quasi mai, in un film di Lynch, hai la sensazione che lo scopo sia quello di “divertirti”». Il perturbante è l’assenza di «taciti/inconsapevoli accordi» fra spettatore e regista: «questo è inquietante perché in assenza di un tale accordo inconsapevole perdiamo alcune delle protezioni psicologiche di cui normalmente (e necessariamente) facciamo uso» [DFW].
Il primo è la rappresentazione delle forze. In pochi prodotti filmici come in quelli di Lynch, è in questione il male. Diversamente da Tarantino, a Lynch non interessa la sua messa in scena in forme spettacolari (estetizzanti, dice il benjaminiano che è dentro di me); diversamente da Scorsese, non gli interessa la sua risoluzione, men che meno la sua riduzione a una semantica o una simbolica; diversamente da molta narrativa da botteghino, non gli interessa il consenso dello spettatore alla preannunciata e inevitabile e stereotipata sconfitta dei cattivi, vittime sacrificali di un godimento promesso dal regista allo spettatore). A Lynch non interessa nulla di esprimibile in termini di valori morali, di posizionamento dei personaggi su un asse assiologico:
Piuttosto, gli interessano gli spazi della psiche umana in cui risiede la capacità di compiere il male. I personaggi non sono malvagi in sé, nei film di Lynch: è il male a indossarli come maschere [DFW].
Che le stesse forze che agiscono nelle espressioni del male possano essere attualizzate in frame narrativi in apparenza noir, cioè “classici”, e al tempo stesso esprimersi in una lacerazione del tessuto (di uno dei piani) del reale causata da quella manifestazione del male assoluto che è la prima manifestazione della Bomba Atomica, è del tutto coerente con l’incoerente struttura narrativa lynchiana. Alla quale lo spettatore non chiede alcuna riduzione di complessità o semplificazione.
Il secondo aspetto ha a che fare con la ridondante presenza del sintagma “al tempo stesso” che richiede ogni tentativo di narrare le inenarrabili trame lynchiane. Lynch è il maestro dell’ambivalenza consapevole: un’ambivalenza che ha (meglio: aveva) il suo emblema nel “personaggio” Laura Palmer, nelle prime due serie e nel film-prequel. Ambivalenza che gli era stata rimproverata da buona parte della critica, come prova del suo (di Lynch) non-sapere-dove-andare-a-parare, o addirittura (con una evidente fallacia preterintenzionale) come prova di un carattere malato, o lacunoso, o comunque spregevole sul piano morale. In Twin Peaks 2017 Lynch sposta in avanti i confini dell’uso dell’ambivalenza – non solo bene/male, innocenza/dannazione, ma anche vita/morte, reale/immaginario, dentro/fuori –, e la mette in scena nella duplicazione dei personaggi (il doppelgänger di Dale Cooper, che prelude ad altri possibili doppi). Perché l’ambivalenza di Lynch è importante, e perché ci concerne?
Io sostengo che il vero motivo per cui abbiamo criticato e detestato il confuso “essere entrambe le cose” nella Laura di Lynch, è che ci veniva richiesto un confronto empatico con la stessa confusa ambiguità che troviamo nell’intimo di noi stessi, e che rende la realtà dell’etica individuale così piena di tensione e disagio: ed è proprio per avere un paio d’ore di sollievo da questa ambiguità, cazzo, che ce ne andiamo al cinema. Un film che richiede che queste caratteristiche nostre e del mondo non vengano allontanate attraverso evasioni, emissioni di sentenze o massaggini ideologici, ma che noi ne prendiamo coscienza, e non soltanto ne prendiamo coscienza, ma che a esse facciamo ricorso nella relazione emotiva con l’eroina stessa – questo film ci metterà a disagio e ci farà incazzare [DFW].
Il mondo è una cosa complicata, perché prodotto da forze materiali complicate, all’interno del quale agiscono forze immateriali ancor più complicate. Il reale stesso è complicato: è dominato, diceva il poeta, da una spaventevole contraddizione. Non c’è un fascistissimo Batman milleriano o nolaniano o al tempo stesso un Minniti batmaniano o renziano che possano scioglierne la complessità. E questo è ciò che le fiction sono arrivate a mostrarci.
Cosa farne, sta a noi: questa è l’acqua, e questo è il pozzo. Bevete e scendete.
(questo testo è dedicato ad Alan D. Altieri – Valar morghulis, bro’)