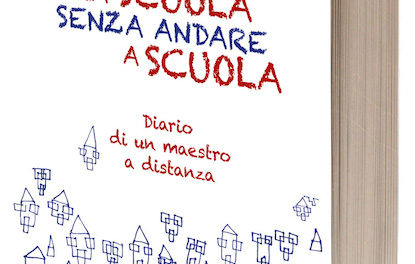di MIMMO SERSANTE.
Ontologia: pensiero, sapere, scienza ma anche un discorso, un dire, un parlare dell’essere che, lo sappiamo da Aristotele, può essere nominato in tanti modi, con i nomi più disparati per via della sua indifferenza e indistinzione (Hegel).
Insomma, per capire cosa o chi è in questione nell’ontologia, è al suo nome – proprio o comune non importa – che dobbiamo prestare attenzione. Il nome prescelto ci indica anche il terreno entro cui siamo costretti a muoverci. Così, se questo nome è quello di Dio – si tratta solo di un esempio –, capiamo subito con quale problematica dobbiamo misurarci. Il nome scelto da Negri è invece quello comune di «operaio sociale» o «moltitudine». Se il primo rinvia alla versione operaista del nostro marxismo (il primo ad averlo usato è stato Romano Alquati), il secondo ci porta direttamente a Spinoza, il filosofo olandese che nel ’600 secondo Negri avrebbe prospettato una storia diversa per il nostro Occidente.
A questi due nomi collego le due fasi che secondo me caratterizzano l’ontologia negriana; chiamo debole la prima fase, quella che copre gli anni Settanta e forte la seconda, maturata negli anni Ottanta, tra la galera (’79- ’83) e i primi anni dell’esilio francese. Gli anni Novanta la renderanno per così dire definitiva e compiuta.
Perché debole l’ontologia degli anni Settanta? Perché se sulla fisionomia dell’essere non ci sono dubbi di sorta – si tratta del ricalco della nuova figura dell’operaio sociale – esso appare ancora impedito a muoversi in libertà, ad agire come soggetto a tutti gli effetti. Neanche la sua qualità autovalorizzante supplisce questa carenza. A mancare all’operaio sociale e alla sua autovalorizzazione è stata la produzione di soggettività1, che è cosa diversa dalla mera composizione politica, soprattutto se quest’ultima è considerata interna a quella tecnica, una sua diretta espressione.
Allora, se la produzione di soggettività non sgorga dalla composizione, quasi fosse una sua conseguenza logica, è perché necessita, come dice Negri da qualche parte, di un salto, di un’innovazione storica. Questo salto e questa cesura storica matureranno solamente nel decennio successivo con la controrivoluzione liberista e con l’affermarsi nell’occidente capitalistico della sua ragione. Solo la scuola operaista colse a tempo questo passaggio epocale il che permise di mettere a fuoco già allora – parliamo della fine degli anni settanta – i termini del problema. Penso in particolare, solo per restare al pensiero di Negri, al saggio Dall’“estremismo” al “Che fare?” pubblicato ne La forma stato del 1977 e al seminario sui Grundrisse dell’anno successivo. In entrambi un ruolo determinante è giocato dal concetto di autovalorizzazione, un altro modo per riqualificare la lotta sul salario ma soprattutto per accennare – ed è la prima volta – al tema della separazione del soggetto proletario dal rapporto di capitale. Ma finché questa indipendenza non è data, finché si è dentro il rapporto di capitale – questa la tesi di Negri – la produzione di soggettività resta appannaggio del padrone e neppure la lotta, pure necessaria, può salvarci. Certamente la lotta è la garanzia che qualcosa nella produzione di soggettività da parte del capitale non ha funzionato a dovere e che il controllo disciplinare non è poi così pervasivo come si potrebbe credere.
Una volta che l’indipendenza è data, bisogna però saperla cogliere e agire di conseguenza; il che non accadde allora, armando ad esempio il nuovo soggetto di un programma adeguato per affrontare la nuova sfida. Per quanto riguarda Negri, l’autocritica ad esempio nei confronti di una certa metodologia lineare e determinista che aveva portato il movimento dell’Autonomia ad appiattire l’analisi dell’autovalorizzazione su quella della crisi, arriverà solo in carcere, a tempo ormai scaduto. Comunque sia, l’autovalorizzazione come separatezza e indipendenza gli tornerà utile nel decennio successivo. E non solo per liberarsi definitivamente del cattivo infinito, lascito del primo operaismo, cui mette capo la logica del dentro e contro, quanto per riprendere per l’ennesima volta il filo con cui tornare a imbastire la trama di un progetto di liberazione comunista.
Ma oggi? Ha senso parlare di un’ontologia forte a fronte di una situazione certamente felice per l’impresa neoliberista ma drammatica per chi ogni giorno deve fare i conti con essa? La moltitudine – il nome con cui Negri ha per così dire ribattezzato il nuovo essere, vale a dire quel lavoro vivo che più direttamente subisce questa tragedia – rassomiglia sempre più a un pugile suonato che solo la forza della disperazione tiene in piedi. Siccome la situazione va avanti da troppo tempo, è legittimo chiedersi quando questa storia finirà perché molto logicamente il capitale continuerà ad avanzare finché non incontra resistenza.
Nel nostro lavoro parliamo del seminario organizzato da Negri a Rebibbia nell’’82. Sotto accusa il noto aforisma gramsciano: pessimismo della ragione, ottimismo della volontà. Con i tempi che corrono, non deve meravigliare se la sinistra oggi extraparlamentare l’abbia fatto propria. Più di qualcuno è anche pronto a scommettere che non ha tutti i torti a pensarla in questo modo. Insomma, considerando che il rapporto di potenza tra capitale e lavoro si è del tutto ribaltato, si dà per scontato che, se di ontologia forte si vuole parlare, essa è stata espressa fin qui solamente dal capitale. L’aspetto buffo è che a fornire le prove che le cose stanno proprio così, sono gli studiosi di sinistra che fanno a gara per mostrare nei dettagli come questa potenza lavora e cosa produce: non solo i soliti dispositivi di governo ma anche e soprattutto specifiche forme di vita, di soggettività. Sto pensando ovviamente all’ultimo capitolo de La nuova ragione del mondo di Pierre Dardot e Christian Laval dall’emblematico titolo La fabbrica del soggetto neoliberista2. E l’elenco di autori e titoli potrebbe continuare3.
Per l’altra ontologia c’è invece poco spazio e sempre etichettata come un fenomeno di resistenza il che significa che non è possibile immaginare un fuori assoluto rispetto alla cosiddetta governamentalità neoliberale; insomma, le resistenze, se nascono, si muovono all’interno dei suoi dispositivi.
Invece per Negri l’adagio gramsciano suona come una resa al nemico di classe, del tipo: razionalmente non c’è nulla da fare, proviamo comunque! No, l’ottimismo è appannaggio della ragione perché la ragione è appannaggio di chi lotta e nella lotta “vince chi ha più contenuti di razionalità”4 da proporre. Come dire: la moltitudine ha dalla sua tutte le ragioni del mondo e c’è una catena di perché a dimostrarlo5.
Ma chi è la moltitudine per Negri? Vi risparmio tutta la lunga, lunghissima storia del concetto che nel caso specifico della moltitudine negriana bisognerebbe però tenere sempre a mente. Per entrare subito nel merito e considerando il riferimento agli operai e ai proletari sfruttati di cui sopra, direi che il concetto di «lavoro vivo» costituisce nel nostro caso il miglior passepartout a disposizione. È un concetto tutto marxiano, molto usato nei Grundrisse e poco nel Capitale dove a farla da padrone è invece la forza lavoro. Mentre quest’ultima è pensata da Marx come una merce immessa giornalmente sul mercato, col suo valore di scambio, a disposizione del capitalista che acquistandola si garantirà la produzione di plusvalore (questo rapporto è il nostro problema), il lavoro vivo non può essere ridotto semplicemente alla forza lavoro in atto. Grazie all’apporto di Deleuze e Guattari, Negri ne fa l’incarnazione della potenza della vita attraverso il lavoro che nell’epoca post fordista acquista una connotazione ben precisa6.
Una volta che il lavoro è stato caricato di un tale onere, per capire quali sono queste peculiarità, non si può prescindere dagli attuali processi produttivi e dai nuovi modi di produrre. Presentano veramente contraddizioni tali da favorire un processo di liberazione? I teorici dell’onnipotenza del capitale ovviamente lo escludono. Conoscono l’armamentario in dotazione delle aziende che operano nei settori più disparati, hanno analizzato a fondo il sistema dei Computer Business Systems (CBS) che a loro dire è capace di inglobare al suo interno tutti i fattori del ciclo produttivo, lavoro compreso7. La bassa conflittualità cui assistiamo è per costoro la logica conseguenza di uno stato di cose di fatto inattaccabile perché – sostengono – una lotta di classe che si ferma all’empiria, che non è capace di produrre una diversa razionalità a partire dalla concretezza in cui è immersa, è destinata alla sconfitta.
Ma per Negri le macchine, come per il suo maestro Deleuze, non spiegano proprio nulla8.
Negri scioglie questo nodo gordiano che sembra stringere in modo inestricabile il lavoro vivo alle nuove macchine (la marxiana sussunzione reale) ipotizzando l’appropriazione del capitale fisso da parte del lavoro vivo9; sono i corpi e le menti dei lavoratori che si appropriano della macchina digitale. Stiamo parlando ovviamente del lavoratore cognitivo10. Nella narrazione marxiana del passaggio dalla manifattura alla grande industria l’ipotesi era già stata ventilata ma secondo Negri essa troverebbe la conferma proprio nella fase attuale segnata dalla rivoluzione digitale. Certo, non si nega che la nuova strumentazione – parliamo delle cosiddette macchine intelligenti – sia utilizzata al servizio della valorizzazione capitalista e chiamata a produrre soggettività obbedienti ma questo fatto del capitale fisso integrato nei corpi e nei cervelli dei lavoratori, diventato la loro seconda natura, ci obbliga a ripensare proprio il problema della produzione di soggettività sotto una luce diversa, a partire questa volta non dalla supposta potenza del capitale ma dalle capacità produttive dei nativi digitali, come da qualche parte Negri chiama il lavoro vivo postfordista11.
Sono in tanti a non tener conto di questa rivoluzione antropologica di cui non si può a tutt’oggi vedere la fine semplicemente perché la sua storia è appena cominciata. Se poi se ne parla, è per riproporla magari come l’ultima propaggine del Moderno di cui bisogna saper intendere il destino. Dopo quello ormai datato di Heidegger, il monito ci viene questa volta da Tronti12: inutile cercarne le tracce nel corpo vivo delle donne e degli uomini messi al lavoro, perfettamente inutile questa ripartenza, ogni volta, dalla composizione di classe. La rude razza pagana non è stata capace di fare la rivoluzione e averlo solo pensato è stato un errore imperdonabile perché qui, in questione, non è l’alternativa al Moderno che abbiamo chiamato comunismo, bensì l’inveramento o meno del suo destino. Insomma, a questo Moderno non c’è alternativa soprattutto da quando si è “indissolubilmente identificato con la storia del capitale”13. Da allora (siamo alla seconda metà dell’Ottocento) anche il racconto che aveva accompagnato la sua irresistibile ascesa – quello di una nuova epoca in cui tutto si trasforma, compreso l’uomo e la sua vita, nel segno della ragione, dell’autonomia e dell’autocoscienza – ha perso il suo fascino14. Il Novecento è stato da questo punto di vista il secolo del disincanto e infatti ad averci aperto gli occhi è stato l’esito cui è approdato la rivoluzione che l’ha inaugurato. Per Tronti si è trattato di un evento dal carattere del kathéchon, di una reazione “all’invasione del Moderno da parte dei barbarici spiriti animali del capitalismo”15. Dunque difesa del Moderno e del suo originario progetto, difesa di quella tradizione sicché la fine del comunismo ha reso visibile anche il fallimento di quel progetto.
I bolscevichi russi hanno sbagliato affidandone la realizzazione al socialismo che non a caso in quegli anni riprendeva il filo del vecchio racconto ottocentesco fantasticando di “società alternativa, (…) [di] differenze antropologiche, di un altro modo di stare insieme nel rapporto sociale di persone umane”16. La risposta “socialista” si rivelerà sbagliata perché pensata per l’appunto nei termini di una sfida da vincere combattuta all’insegna del progresso economico e dell’innovazione tecnologica. Su questo terreno invece non si può essere più moderni del capitalismo. Sull’altro terreno, quello dei valori e della produzione culturale, la situazione non è stata certamente migliore. Il decennio che ha preceduto la fine del socialismo reale è stato di logoramento e di spossatezza, insomma un deserto con nessuna idea di società, di politica, di cultura, nessuna idea di mondo e di vita. Il capitalismo ha vinto, anzi stravinto, senza aver fatto prigionieri e senza concedere a chicchessia neppure l’onore delle armi. È il caso del Movimento Operaio, quello organizzato nel partito e nel sindacato, il solo soggetto storico collettivo degno secondo Tronti di questo nome, entrato negli anni settanta “nella sua grande crisi: crisi di soggetto e crisi di struttura, di potenza geopolitica e di forza produttiva, tutto insieme, contemporaneamente”17.
Così il Moderno occupato dal capitalismo ha finito per trasformare la nostra società in un universo concentrazionario abitato da “liberti, schiavi liberati per poter meglio servire”18. Nessun cenno però alle forme assunte dal nuovo lavoro servile e alle logiche che governano oggi lo sfruttamento del lavoro vivo. Di questa eredità del primo operaismo – l’unica forse a farne ancora oggi una scuola di formazione radicalmente antagonista – non c’è traccia in questo ultimo Tronti.
Diventa allora curioso verificare come viene affrontato e risolto il nostro problema. Alla prima domanda – chi produce, e come, la servitù volontaria – si risponde tirando in ballo la massa, un tema caro al pensiero della crisi durante la breve vita di Weimar19, oppure la doppia critica e alla democrazia realizzata, avanzata dal pensiero conservatore in quegli stessi anni, e alla comunicazione-informazione diffusa attraverso la rete. In questa caso l’aria che tira è quella francofortese. Alla seconda domanda – quale la strategia del liberto per guadagnarsi la libertà – si risponde col ricorso al giovane Hegel e al Luporini emulo dell’esistenzialismo sartiano20. Tronti qui è chiaro: “il sovvertimento – dice – va lucidamente introdotto nel punto opaco della resistenza a un modo veramente libero di pensare, che non è il punto dei rapporti reali, sociali e politici [corsivo nostro], quanto il punto dei livelli di coscienza, o di incoscienza, da essi prodotti”. Si nasce in catene anche in una società che sul piano formale vuole tutti liberi perché la libertà “non è quella che ci è data, ma quella autonomamente scelta; non è quella iscritta nelle leggi, ma quella maturata nella coscienza”. Che ne è del comunismo? “Se ha un senso, o se è ancora capace di conquistarsi un senso, la parola comunismo è questo: la possibilità data a tutti di coltivare la propria libertà in interiore nomine”21.
Nomine, non homine: è il momento di Sant’Agostino con la sua idea di linguaggio come segno e testimonianza di una presenza spirituale, “come libertà dello spirito”22. Dal vescovo di Ippona al poeta Hölderlin e al suo comunismo degli spiriti23 senza dimenticare il giovane Hegel di Libertà e destino. È sempre stato, questo, lo stile del discorso di Tronti: procedere “per frammenti e aggiunte e accostamenti e rimandi, fino a che…”24.
Ma la via maestra è quella indicata dagli esistenziali: scelgo e divengo; la decisione in primo luogo (scelgo il mio futuro togliendomi via dalla routine dell’esistenza finita) seguita dalla sua messa in atto (divengo questa scelta). A lasciare il segno è indubbiamente il sottinteso «io». Coniugati alla prima persona, l’effetto è immediato: io, proprio io sono chiamato dalla situazione a scegliere; io, proprio io, devo rispondere della fedeltà cui la decisione in un qualche modo mi obbliga. Io, solamente io, non altri…
Tronti dedica a questo problema due paginette dal titolo emblematico Libertà in situazione25. L’espressione è utilizzata da Sartre oltre che in L’être et le néant (1943), in un saggio sulla questione ebraica (fine del 1944)26. Vi si affronta il tema della produzione di soggettività: perché il francese medio è antisemita? Perché l’ebreo francese si vuole ebreo? La spiegazione che per molti aspetti ricorda la dialettica hegeliana del servo e del padrone, parte dal presupposto che l’uomo 1) è “ciò che si fa” e 2) è sempre “una «libertà in situazione»”27, il che permette a Sartre di distinguere la libertà in autentica e non autentica. La prima è la più difficile a farsi per via delle responsabilità e dei rischi che comporta e del coraggio che richiede ma soprattutto perché esige “una coscienza lucida e veridica della situazione”28. Tronti da parte sua distingue la libertà in negativa e positiva; quest’ultima si esercita nel“ duro compito di strappare con il pensiero la libertà dai « limiti» che dentro la società la imprigionano”29. Oppure (ma si tratta della stessa cosa): “Se la situazione ci sovrasta, l’unica scelta è, con il pensiero, rompere il cerchio chiuso della sua forza di determinazione nei nostri confronti”30.
Tronti non è mai stato un filosofo dell’ontologia anche quando tifava per la rude razza pagana. La sconfitta della classe operaia fordista è stata politica (ed è questo che veramente conta per lui), identificandosi con quella del Movimento Operaio Organizzato mentre la ristrutturazione produttiva e la finanziarizzazione dell’economia sono viste come una “deriva modernizzatrice” il cui prodotto è l’uomo che noi siamo, “non libero, che aderisce a una situazione, con la falsa coscienza, di fatto con la reale incoscienza, della propria libertà”31. Non una nuova composizione di classe – la si chiami come si vuole – ma individui in solitudine, riconducibili alla figura antropologicamente determinata dell’homo oeconomicus + homo democraticus. Al concetto marxiano di rapporto sociale Tronti preferisce quello sartiano di situazione con tutto quello che ne consegue, a partire dalla scomparsa dell’antagonismo di classe sostituito dal primato assegnato alla coscienza individuale il cui ruolo nella produzione di soggettività risulta fondamentale. Inutile anche l’accostamento tra i due concetti avendo il secondo una valenza a-storica (l’uomo è infatti sempre in situazione) e una funzione trascendentale, nell’accezione kantiana del termine. La situazione infatti non è qualcosa di estrinseco, ma è costitutiva della libertà; quest’ultima è inseparabile dalla situazione. Solo assumendola, l’uomo afferma la propria libertà di spirito libero, come a Tronti piace chiamarlo civettando con il Nietzsche di Umano, troppo umano32.
Considerando la nobile vetustà del tema, come intendere questa espressione? Per noi l’interrogazione filosofica si fa interessante quando apre a una prospettiva politica il che accade raramente e sempre in situazioni storiche particolari. Così è accaduto a Hegel con la dialettica servo-padrone nel momento in cui la classe borghese cominciava la sua irresistibile ascesa; così, e qui il problema si fa ancora più interessante, è accaduto durante gli anni cinquanta a contatto diretto con le lotte anticoloniali. Ci si interrogò allora – pensiamo a Fanon di Pelle nera, maschere bianche – sulle ragioni che spinsero i colonizzati a combattere l’inautenticità di una vita vissuta in un contesto che non li riconosceva come soggetti. Così è accaduto più di recente con il femminismo italiano (Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel). In entrambi i casi ci si è riferiti a soggettività escluse perché altre, prodotte nel primo caso dal razzismo dei bianchi, nel secondo dal sessismo degli uomini. Il tema torna d’attualità oggi con la controrivoluzione neoliberista degli ultimi trent’ anni. Così per Negri si tratta di produrre in questo nuovo contesto una “soggettività resistente, che consiste precisamente nel produrre se stessi liberamente, per eccedenza, nonostante quella libertà non possa essere astratta da una situazione che è quella del rapporto di forza” in P. Macherey, Il soggetto produttivo, ombre corte, Verona 2013, p. 89. ↩
P. Dardot e C. Laval, La nuova ragione del mondo, Derive Approdi, Roma 2013. ↩
Last but not least, il saggio di F. Chicchi, E. Leonardi, S. Lucarelli, Logiche dello sfruttamento, ombre corte, Verona 2016. Anche in questo caso si tratta della disamina di una nuova forma di produzione di soggettività e di sfruttamento nota come imprinting la cui logica è centrata “sull’apparente paradosso di un controllo sociale che si esprime attraverso la produzione di libertà, di un dispositivo di governo che organizza la produzione sociale incitando all’autonomia soggettiva” (ivi, p. 32). ↩
Citato in W. Montefusco e M. Sersante, Dall’operaio sociale alla moltitudine, Derive Approdi, Roma 2016, p. 25. ↩
Qui soccorre Spinoza per il quale l’ottimismo è proprio della cupiditas, vale a dire della potenza di agire degli operai e dei proletari di cui le lotte dell’ultimo decennio sono state la testimonianza più diretta. ↩
Ricordiamoci della sostanza spinoziana: essa è infinita potenza di esistere e agire. Volendo giocare con la terminologia dell’Etica, questo ruolo è assegnato da Negri al lavoro vivo mentre la moltitudine ne è il modo d’essere contemporaneo come ieri lo sono stati l’operaio massa e l’operaio professionale. ↩
È grazie ad esso che una multinazionale come Amazon può monitorare ogni spostamento del lavoratore a cui viene applicato un navigatore satellitare grazie al quale i suoi superiori hanno accesso in tempo reale alla sua posizione e possono stabilire se è in linea con gli obiettivi di giornata. Un distillato di taylorismo à la Huxley che non rimane confinato nei magazzini o ai supermercati, ma si estende anche nei settori più avanzati del terziario come l’università! ↩
“Ad ogni tipo di società, evidentemente, si può far corrispondere un tipo di macchina: le macchine semplici o dinamiche per le società di sovranità, le macchine energetiche per quelle disciplinari, le cibernetiche e i computer per la società di controllo. Ma le macchine non spiegano nulla, si devono invece analizzare i concatenamenti collettivi di cui le macchine non sono che un aspetto”, G. Deleuze, Controllo e divenire. ↩
In verità il tema era stato sollevato già nelle pagine della rivista «Luogo comune» (nov. 1990) con la ripresa del classico frammento marxiano centrato sul concetto di general intellect, di un intelletto generale depositato nel capitale fisso, inferrato, come dice Virno, nel sistema delle macchine; ora esso viene cercato nei soggetti viventi. ↩
Così Christian Marazzi, un economista assai vicino alle posizioni negriane: “Dalla fine del fordismo in poi, la scienza incorporata nel capitale, le tecnologie e di conseguenza anche le tecniche che ne sono l’articolazione, si sono spostate sempre più dalle macchine (capitale fisso) ai corpi vivi. […] Sempre più abbiamo dentro di noi le formule, i saperi, le teorie, i linguaggi e i modelli che in passato erano racchiusi nel capitale fisso, nella macchina” in Che cos’è il plusvalore?, Edizioni Casagrande, Bellinzona 2017, p. 23. ↩
T. Negri, Appropriazione di capitale fisso: una metafora?, in Euronomade, qui. ↩
M. Tronti, Dello spirito libero, Il Saggiatore, Milano 2015. ↩
Ivi p. 20. ↩
Sul tema di T. Nipperdey, Come la borghesia ha inventato il moderno, Donzelli editore, Roma 1994. ↩
Dello spirito libero, cit., p. 23. ↩
Ivi p. 24. ↩
Ivi pp. 17-18. ↩
Ivi p. 93. ↩
E. Canetti, Massa e potere, Adelphi Edizioni, Milano 1981. ↩
Dello spirito libero, cit., § 7 e § 10. ↩
Ivi p. 56. ↩
Ivi. ↩
D. Carosso, Il comunismo degli spiriti. Forma e Storia in un frammento di Hölderlin, Donzelli Editore, Roma 1995. ↩
Dello spirito libero, cit., p. 29. ↩
Ivi pp. 47-48. ↩
J. P. Sartre, L’antisemitismo, SE, Milano 2015. ↩
Ivi p. 62 e p. 91. ↩
Ivi p. 62. ↩
Dello spirito libero, cit., p. 57. ↩
Ivi p. 48. ↩
Ivi p. 41. ↩
F. Nietzsche, Umano, troppo umano, Adelphi, Milano 1965. ↩