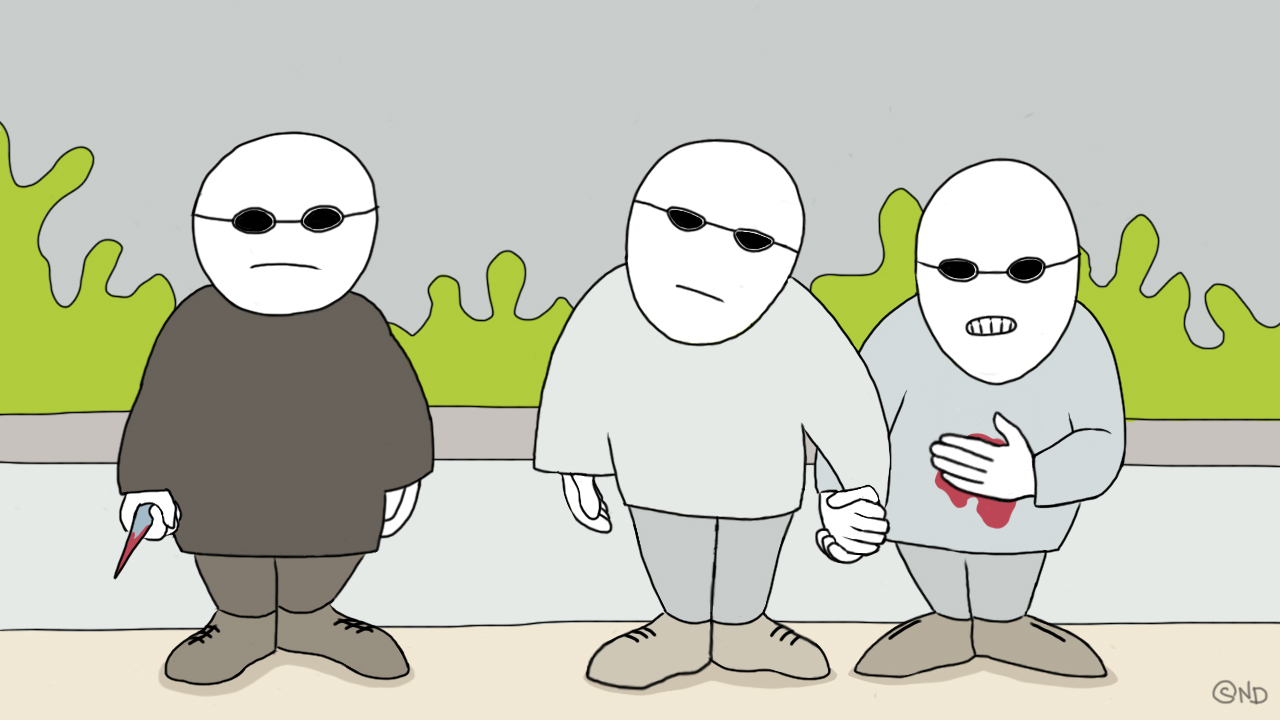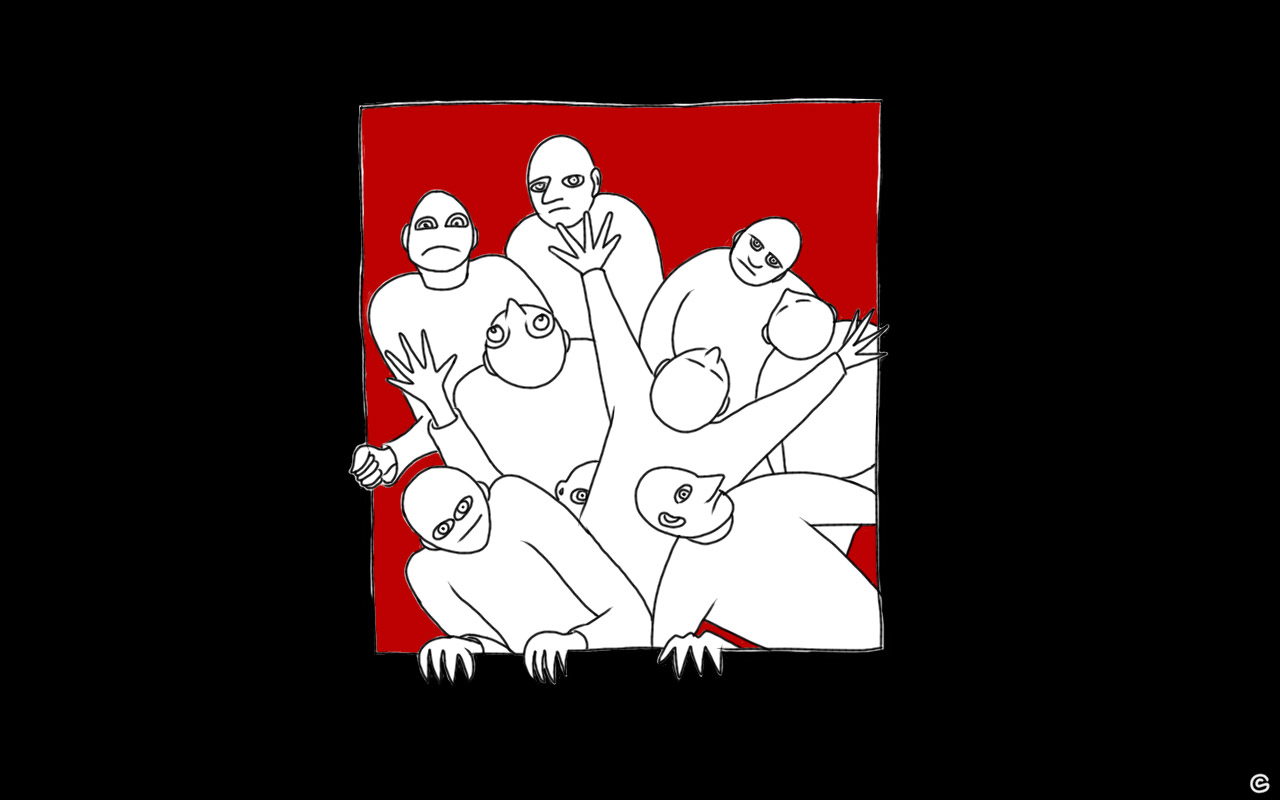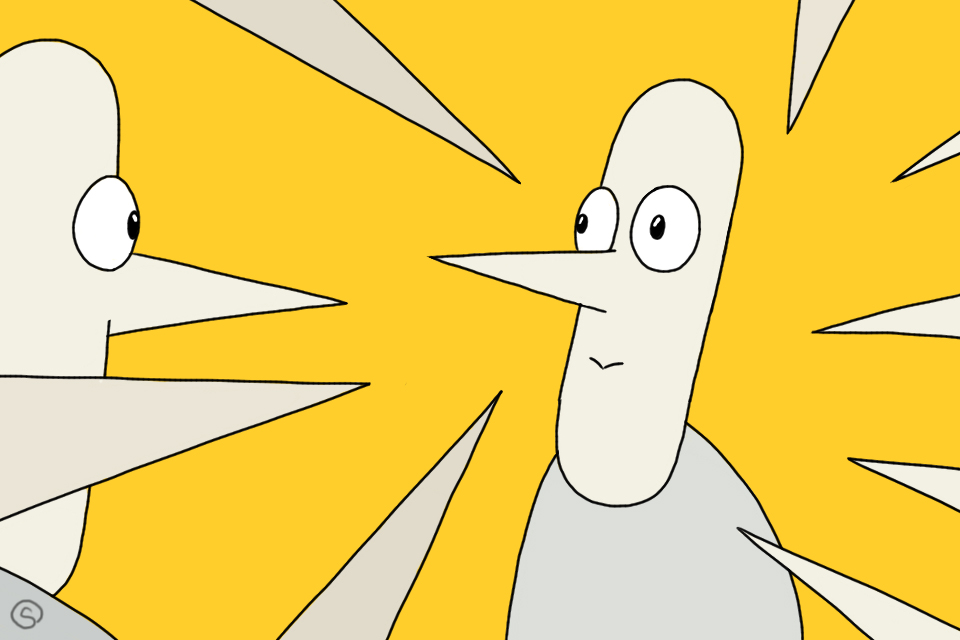di BIAGIO QUATTROCCHI.
Recentemente Sandro Mezzadra e Toni Negri hanno aperto, per il collettivo Euronomade, una riflessione sulla concatenazione dell’imminente appuntamento elettorale in Grecia e su quello successivo, che si terrà in Spagna verso la fine dell’anno. La posta in gioco di questo doppio passaggio elettorale, senza nessuna retorica e senza alcuna particolare ingenua illusione, resta elevata. Non è in discussione né la rottura lineare del regime neoliberale europeo, né, nel tempo immediato, la definizione di un progetto compiutamente post-liberista su scala continentale. Ma si potrebbe trattare pur sempre di una rilevante rottura politica, qualora le più rosee previsioni elettorali per le due “nuove formazioni di sinistra” – Syriza e Podemos – dovessero essere confermate. Per cui, come scrivono gli autori: «questo non ci impedisce di cogliere la rilevanza che specifiche elezioni possono avere dal punto di vista della lotta di classe». Per noi, che pratichiamo la politica a partire dalla centralità delle lotte sociali, è in discussione innanzitutto la relazione tra queste lotte e la “verticalità” del soggetto politico. O, ancor più in là, il rapporto tra queste ultime due dimensioni dell’azione politica, quella istituzionale del governo e l’apertura di un terreno costituente per l’auto-organizzazione del Comune.
La rilevanza e l’urgenza di questo dibattito, è data dalle condizioni materiali che si sono concretamente determinate in questi due paesi. Il punto non è quello di discutere su un piano di trascendenza se le relazioni poc’anzi accennate possono essere in assoluto pensate o agite. Qui, si tratta di comprendere che in questi due paesi, nella violenza dell’attuale crisi, le lotte sociali in qualche caso hanno spinto, in altri hanno direttamente assunto su di sé, questo nuovo e inedito piano dell’agire politico. Eludere queste questioni sarebbe come giocare a mosca cieca. Al contempo, eludere il rischio di un “riassorbimento” delle stesse lotte sul piano istituzionale sarebbe da stupidi.
Syriza e Podemos sono due diverse forze politiche. Diverso è il rapporto con i movimenti. Diverso è il modello organizzativo interno. Altrettanto diverso è il loro richiamo alla “tradizione” politica e culturale della sinistra socialista (o comunista). La prima organizzazione rivendica un terreno di internità e di maggiore continuità con la storia. La seconda opera una rottura, aprendosi al populismo nella accezione di Laclau. In entrambi i casi, però, tali organizzazioni sembrano lavorare per un rinnovamento del “laboratorio socialdemocratico” in Europa ed è questo il nodo insieme rilevante e problematico su voglio concentrarmi.
Dal programma di Syriza, si legge della volontà (trovate le condizioni per l’eventuale formazione del governo) di riaprire una contesa con le istituzioni europee ed internazionali (Commissione, BCE e FMI) per la «rinegoziazione del debito pubblico» e, contestualmente, per la rottura della spirale dell’austerity attraverso un programma espansivo di politica fiscale. Lo scopo è minare alla base alcuni dei principi ordoliberali contenuti nei regolamenti e nella disciplina di bilancio dell’unione monetaria. Benché non esaustive, dal punto di vista della fine – o solo dell’ammorbidimento – degli effetti sociali della crisi, le due questioni sono certamente rilevanti, in sé e nel porre il problema sulla scala europea, aprendo alla possibilità di rompere gli equilibri interni al management della crisi, senza necessariamente chiudere ai movimenti la possibilità di riarticolare uno spazio di azione nella geografia dell’Europa. In più, cosa di non poco conto nella fase attuale, si tratta di un piano discorsivo che sembra sottrarsi all’ordine del discorso “uscita dall’euro vs sostegno alla moneta unica così com’è”. Lasciando, invece, aperta la possibilità ad una critica radicale dell’attuale sistema istituzionale del “circuito della moneta” europeo.
A ben vedere, così come è stato già sottolineato da altri, si tratta di un programma che punta a recuperare (o almeno si mostra coerente con) un piano di politica economica post-keynesiano. Centralità della domanda effettiva, rottura dell’indipendenza della BCE dal Tesoro, coordinamento con la politica fiscale, (presunto) recupero dello Stato come agente capace di “programmare” indipendentemente dalla razionalità del mercato. Ma come spesso accade all’interno dello stesso dibattito teorico post-keynesiano, i due corni dell’economia politica finiscono per perdere forza e la dimensione politica finisce per non mordere. Riemerge quell’incrollabile «naturalismo» politico dei post-keynesiani, che magari pensando che il neoliberismo sia stato nient’altro che una riedizione del laissez-faire tendono a pensare che sia sufficiente, come si fa per i morti, riesumare dall’oltretomba lo Stato liberale keynesiano.
Abbiamo imparato che la questione del “keynesismo storico” (o “reale”), sul piano politico, è stata una vicenda assai più complessa di quanto ce la raccontano per lo più, ancora oggi, gli stessi post-keynesiani. Per sir John Maynard Keynes i fatti erano strettamente integrati tra loro, o almeno così lo sono stati nel “keynesismo reale”. Lo Stato-piano controllava attraverso la domanda effettiva la stabilità del ciclo economico, programmando l’apertura di mercati. Definendo talvolta cosa e come produrre. Contestualmente il controllo della domanda effettiva rifletteva, sul piano politico, il tentativo di «democratizzazione del ciclo economico». Al centro di questa costruzione figurava il partito-massa, innestato saldamente nella struttura istituzionale della rappresentanza. E ancora più a fondo, la forza del movimento operaio, che attraverso le lotte salariali è stato capace di imprimere una dinamica espansiva tenendo insieme crescita economica, occupazione, miglioramento delle condizioni riproduttive e democrazia. Fino a minacciare, nei punti alti delle lotte, la compatibilità interna di questa costruzione, aprendo inediti spazi di liberazione. Ma la storia del keynesismo, le sue profonde contraddizioni, le sue forme di comando sulla forza-lavoro, sui corpi, le abbiamo più volte discusse, e non vale la pena di continuare a farlo qui.
Abbiamo anche imparato da Foucault che nel tempo presente le molteplici forme-Stato del neoliberalismo, oltre ad introiettare dentro di sé la razionalità del mercato – facendo quindi dello Stato un agente che opera per il mercato – hanno prodotto una separazione sempre più rilevante tra intervento statuale e democrazia. E’ lo Stato, non certamente scomparso nel lungo ciclo neoliberale, che ha continuato e continua a governare insieme alle altre istituzioni i violenti meccanismi “estrattivi” del capitale finanziario. La democrazia, quindi, ha perso la sua forza espansiva e della crisi della rappresentanza istituzionale mi sembra che oramai neppure più l’establishment ne faccia mistero.
Per giunta, se si svolgesse fino in fondo il discorso post-keynesiano, così come viene fuori dai suoi laboratori accademici più intelligenti, come il Levy Economics Institute di New York, si troverebbe la loro quasi costante insistenza sul recupero della “sovranità nazionale”. E’ l’altra faccia del discorso che “in una certa sinistra” si fa sulla rottura della moneta unica, e principalmente sul ritorno alle monete nazionali. Come si fa a non capire che “sovranità nazionale”, in assenza dei contropoteri a cui prima facevamo riferimento, oggi sarebbe solo una terribile tragedia? Come fare a non vedere, per esempio dopo i tragici fatti di Parigi, che il tema della sovranità nazionale è già tutto occupato dalle “consorterie neoconservatrici” e dai fascismi?
Uso un’espressione ancora provvisoria, ma che mi aiuta a puntare i piedi dritti su una questione. E’ possibile, alla luce dell’azzardo di Syriza e di Podemos, «rompere il dispositivo politico keynesiano»? O, se preferite: è possibile fare un «uso politico non-keynesiano del keynesismo»?
Si tratta di immaginare e di praticare nuove forme di congiunzione tra lotta economica e lotta politica, capaci di riaprire spazi di democrazia.
E’ stato correttamente osservato da Christian Marazzi che nel passato la relazione salariale, e quindi la lotta sul salario, ha avuto la forza di «comprendere la vita nella sua interezza». Perché oltre a riguardare il momento diretto della produzione (quindi il potere interno ai luoghi di produzione), gli aumenti salariali, attraverso il welfare beveridgiano, assicuravano la formazione, il pensionamento e così diversi altri momenti della vita. La rottura di questi legami, di queste «consequenzialità», deve suggerire una nuova articolazione delle lotte.
La riapertura di un programma di politica fiscale espansivo, dicevamo, deve incontrare la pressione della lotta sociale sul terreno del reddito di base incondizionato, allo scopo di favorire nello spazio sociale riproduttivo quanto c’è di comune nelle relazioni sociali. Allo stesso tempo, questa rottura dall’alto relativa alla spesa pubblica deve incontrare la sperimentazione di modelli di auto-organizzazione di servizi mutualistici nel campo del welfare del comune. Sarebbe, quest’ultimo, un terreno concreto di espansione e consolidamento di nuove istituzioni sociali, capaci di riaprire contropoteri diffusi ed esperienze di democrazia diretta. E potrebbe, per giunta, fare leva su prototipi che già si stanno dando in Grecia come quelli della rete Solidarity for all, oppure in Spagna, nelle diverse esperienze mutualistiche germinate dal 15-M. E’ in questo senso che intendo, provvisoriamente, «rottura del dispositivo politico keynesiano». E se non fosse ancora chiaro, la questione è quella di affinare nella concretezza di questa fase storica le armi della critica dell’economia politica.