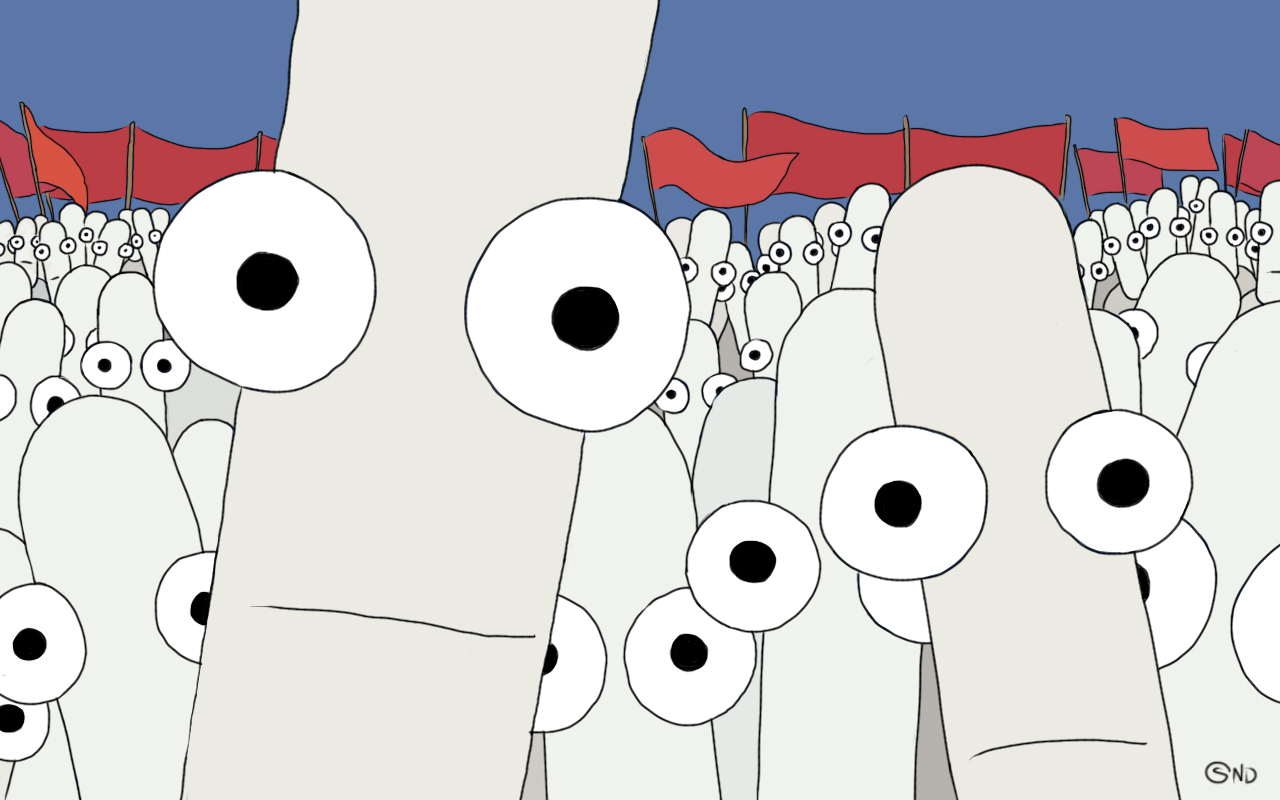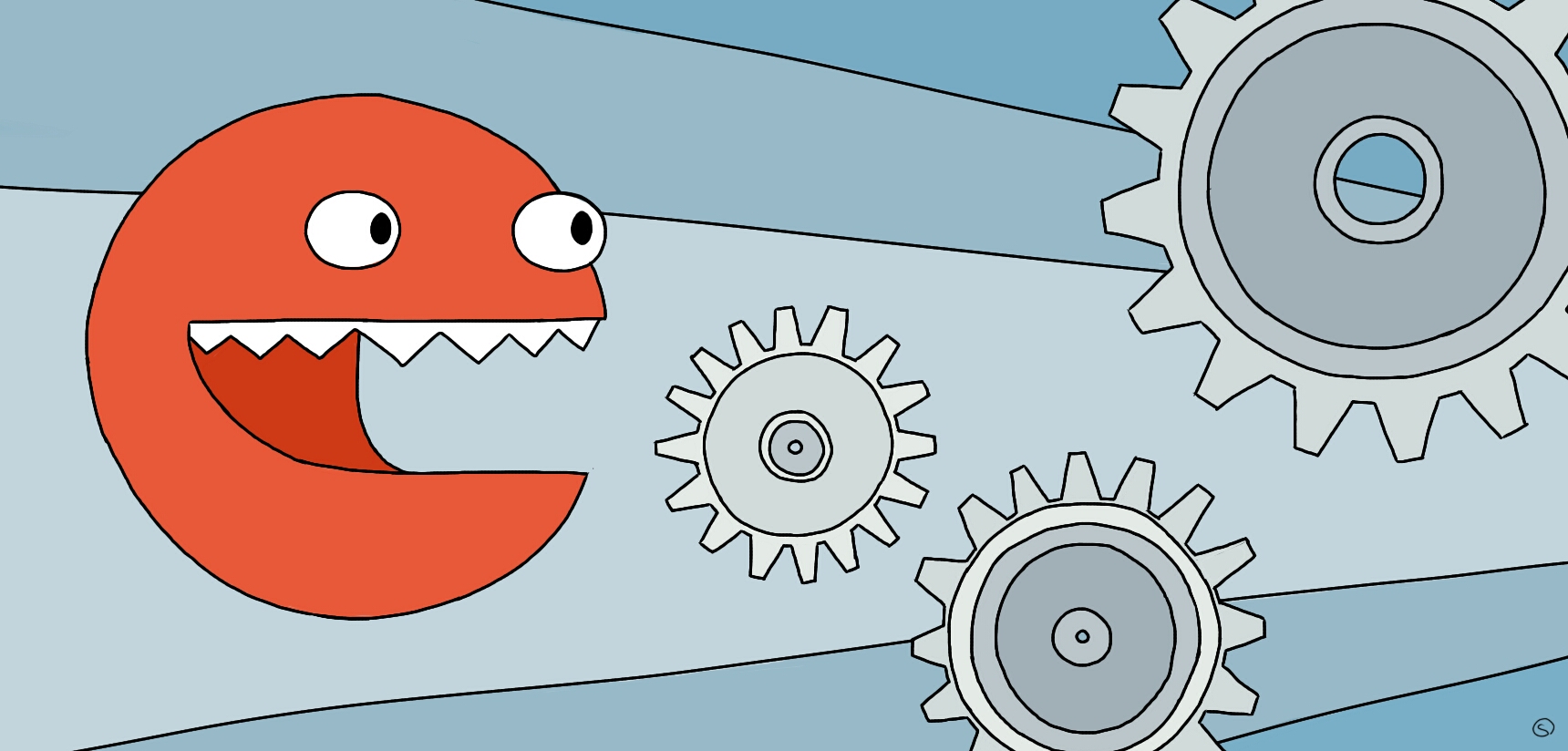di MARCO BASCETTA.
Alla vigilia di ogni legge di stabilità il dibattito sulla pressione fiscale ritrova un suo asfittico momento di vita. Difficilmente si spinge però oltre una materia buona per demagoghi e commercialisti. Un pensiero forte sulla fiscalità sembra fermo da decenni e, soprattutto, saldamente ancorato a una destra che sa bene quello che vuole. Gli si oppone da sinistra, con spirito egualitario e scarso ascolto politico, la denuncia della «regressività» del sistema fiscale e la proposta di un suo rivoluzionamento portate avanti da Landais, Piketty e Saez1.
Sul fronte opposto, per quanto detestabili, i nipotini di Hayek, hanno saputo dimostrare un certo rigore e insediarsi stabilmente nell’orientamento di politiche governative impegnate nella competizione per la migliore offerta di vantaggi fiscali. Il loro totem, la celebre «curva di Laffer» nella quale si dimostra che oltre un certo limite di imposizione fiscale il gettito decresce perché decrescerebbe l’imponibile più rapidamente dell’aumento dell’imposta, sta ancora in piedi, sia pure in virtù di brutali rapporti di forza. Anche se l’ipotesi paradossale da cui muove, secondo cui una imposizione del 100% corrisponderebbe alla disincentivazione di qualsiasi attività è banalmente incontrovertibile, almeno in una economia di mercato.
Da qui discende, per vie non proprio limpide, l’avversione per qualsivoglia progressività fiscale, la difesa dei patrimoni e delle rendite, il dirottamento dell’imposizione verso i consumi, il concetto che il welfare se lo devono pagare soprattutto quelli che ne usufruiscono (e dunque non i più ricchi).
Insomma la destra, sul fisco, ha le idee assai chiare.
Del resto non pochi governi di sinistra hanno fatto ricorso, in forma più o meno mitigata, a queste stesse ricette. Circostanza che acuisce la necessità delle sinistre di governo, quando non integralmente convertite al liberismo, di distinguersi in qualche modo dalle politiche fiscali della destra, sostenendo il valore, per l’evoluzione della società in generale, di un’alta imposizione fiscale. Almeno fin dove il consenso non ne risulti troppo minacciato.
Su la Repubblica l’ex ministro Vincenzo Visco2 tentava qualche tempo fa di elencare gli elementi discriminanti: la promozione del welfare e la sua gestione statale che garantirebbe attraverso la riduzione dei rischi individuali maggiore efficienza e produttività, oltre alla riduzione delle diseguaglianze. Alla quale dovrebbe provvedere anche una politica di progressività fiscale. A questo insomma «servono le tasse».
Fatto sta che né della progressività fiscale e men che meno della riduzione delle diseguaglianze, che al contrario sono cresciute a dismisura, si è vista traccia alcuna nel crepuscolo «migliorista» delle socialdemocrazie.
Sulle colonne di questo giornale, il 29 settembre, Roberto Romano3 sottolineava la relazione diretta tra diritti e prelievo fiscale: «Dove esiste un’adeguata pressione fiscale si osserva un adeguato stato sociale e tassi di crescita mediamente più alti». E, certamente, per buona parte del Novecento in diverse economie avanzate questo nesso è stato ben visibile (lo è ancora in alcune economie forti del nord) e il rapporto tra welfare e prelievo fiscale effettivo.
Ma le tasse servono ancora così prioritariamente a questo scopo?
A giudicare dalla vicenda greca e dalle prescrizioni fiscali della Troika, fondate sull’assunto che i cittadini greci avevano vissuto «al di sopra dei propri mezzi», converrebbe dubitarne. Dopo i processi di finanziarizzazione che hanno ridisegnato l’economia globale e assegnato nuovi compiti agli stati nazionali si può ancora descrivere la fiscalità in questi termini?
La faccenda è tutt’altro che semplice. Ma intanto ci si deve porre una domanda: perché mai l’aumento della pressione fiscale non è stato accompagnato da un rafforzamento del welfare, ma, al contrario, dal suo ridimensionamento, da una raffica di privatizzazioni e spending review, da una riduzione costante dei diritti del lavoro?
Per attenerci alla sola serie storica italiana, la pressione fiscale è passata dal 30 al 45% tra il 1980 e il 2014 e certo non si può dire che le diseguaglianze siano diminuite e i diritti aumentati in questa stessa misura. Piuttosto, all’aumento delle imposte si è accompagnato negli ultimi anni l’impoverimento dei ceti medio-bassi.
Se si mettesse a confronto la storia del welfare e quella della fiscalità in diversi paesi europei c’è da scommettere che il nesso tra questi due elementi risulterebbe tutt’altro che lineare. Perché, come è apparso evidente con la crisi dei debiti sovrani e con l’enorme flusso di denaro destinato a ricapitalizzare sistemi bancari dediti al gioco d’azzardo, la fiscalità è diventata uno strumento decisivo di garanzia e continuità della rendita finanziaria.
Il fabbisogno degli stati non è certo riducibile al mantenimento del welfare. Corruzione, clientele, caste, sprechi , evasione, certamente incidono, ma non costituiscono affatto una spiegazione esauriente. Il fisco, e soprattutto la tassazione indiretta, è infatti anche un tramite, sempre più importante, nel trasferire parte della ricchezza socialmente prodotta (fuori dai rapporti salariali, dai mercati controllabili e spesso da ogni forma di retribuzione) nel circuito finanziario e nei canali di una redistribuzione delle risorse indirizzata verso l’alto: la «regressività fiscale» di cui scrive Piketty, ossia la protezione degli alti redditi e dei grandi patrimoni.
I difensori dei profitti e delle rendite, ricondotti alla categoria del «risparmio», supposto disponibile a trasformarsi in «investimento», giustificano la loro avversità alla tassazione progressiva con l’argomento dell’occupazione: se il tornaconto dei datori di lavoro dovesse peggiorare, la domanda di lavoro ne soffrirebbe. Ma il costo del lavoro è decisamente sopravvalutato, per ragioni in parte ideologiche, tra i fattori di quella riduzione dell’occupazione strutturalmente incardinata nelle trasformazioni del modo di produzione stesso. Nessun imprenditore, se il mercato non «tira», sarà disposto a impiegare lavoro, sia pure fortemente «detassato». E se lo sconto non finirà anche, significativamente (altro che 80 euro), nelle tasche dei lavoratori, i consumi, già bersaglio prediletto dell’ideologia fiscale liberista, languiranno e il mercato in conseguenza.
Il problema non sembra preoccupare le sinistre di governo, impegnate nel festeggiare rumorosamente modesti quanto effimeri incrementi del tasso di occupazione a fronte di vantaggi e poteri sempre maggiori concessi agli imprenditori. Inoltre, se il bacino del lavoro salariato si contrae, bisognerà trovare altre fonti di introito fiscale. La persecuzione del lavoro autonomo e precario di massa, privo di ogni tutela, è una di queste. L’altra è quella piccola proprietà (abitazioni, auto), in larga parte ipotecata da banche e finanziarie che, non essendo fonte di rendita (quella catastale è una pura espressione metafisica) è di fatto indistinguibile dal consumo, puro e semplice valore d’uso.
Con il che ritorniamo al principio ultraliberista secondo cui non il possesso o il risparmio (valore di scambio) devono essere tassati ma, appunto, l’uso. Per dirla con una formula è probabilmente la «tassazione della vita», nel suo svolgersi individuale e collettivo, una nuova importante leva dell’estrazione di valore. Cosicché la disputa se debba essere detassata la prima casa o il lavoro è di assai scarso interesse.
Le domande decisive sono tutt’altre. Che cosa davvero alimentiamo con le nostre tasse? Che ruolo svolge oggi il prelievo fiscale nel processo di accumulazione? Si deve continuare a ritenere lo stato il protagonista principale della spesa pubblica o conquistare spazi crescenti di autogestione delle risorse? E, infine, esiste ancora, e in quali forme, una possibilità di controllo democratico sull’imposizione e la spesa? Ha senso continuare a ignorare, magari nell’illusione di poterli contrapporre, il rapporto tra capitale finanziario e sovranità statali?
Per come stanno oggi le cose, le ragioni di Masaniello e di tutte le classi popolari che per secoli si sono rivoltate contro dazi e gabelle, destinati a ripianare i debiti contratti dalle corti con i banchieri dell’epoca per finanziare i propri sfarzi e le proprie guerre, non sembrano affatto superate.
Le forme cambiano, ma l’espropriazione resta.
*pubblicato su il Manifesto del 6 ottobre 2015.