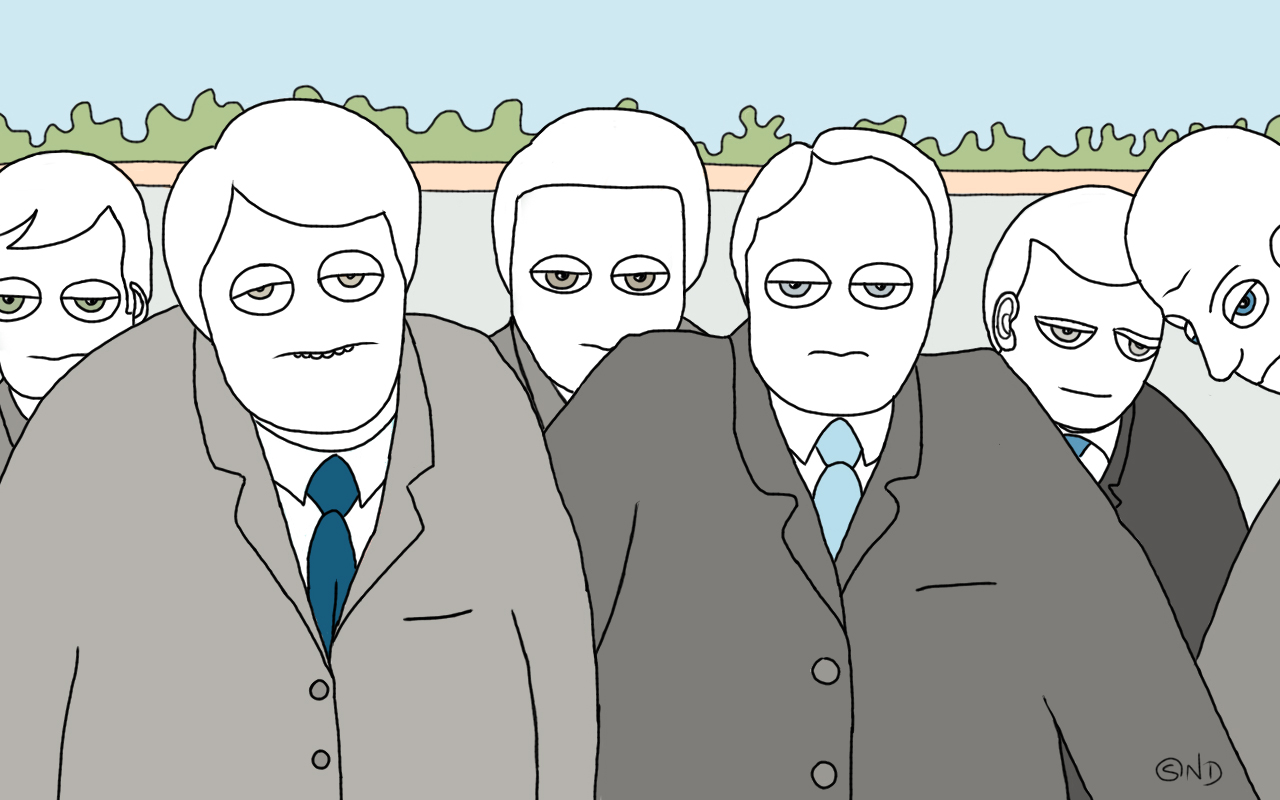Di ASSEMBLEA IL MONDO CHE VERRÀ
Non possiamo permettercelo. È la frase che sta caratterizzando, come un ritornello insistente, tutta la seconda ondata. Davanti alla prima, il blocco complessivo della produzione mondiale aveva permesso, quasi per la forza stessa delle cose, che una parte dei governi occidentali si schierasse, almeno nelle intenzioni, dalla parte della tutela della salute pubblica, per la protezione delle persone, a cominciare da quelle più esposte. Le punte avanzate del neoliberalismo più reazionario, Trump, Johnson, Bolsonaro, fecero un’esplicita scelta per la selezione naturale, l’accettazione della morte, gli imperativi della proprietà contro la società, e la chiamarono immunità di gregge: ammalatevi tutte e tutti, faremo a meno di chi non è adatto a sopravvivere. I governi europei scelsero, almeno ufficialmente un’altra strada: misure severe e lockdown nazionali. Ci accorgemmo presto che quelle scelte nascondevano, in realtà, la forza persistente degli interessi, in primo luogo, della produzione industriale. La Lombardia, Bergamo, la Val Seriana, restano scolpiti nella memoria, e ora anche nelle inchieste, come i luoghi della catastrofe imposta da quegli interessi.
In questa seconda ondata, quel cinismo di fondo, che sembrava cacciato dalla porta, è rientrato dalla finestra. La parola d’ordine generalizzata è stata governare la curva, contemperare economia e salute: perché altro, evidentemente, in questa seconda fase, non ci potevamo permettere. Il che, apparentemente, è ragionevole. Una ragionevolezza, però, che nasconde una, non proclamata, implicita, accettazione della morte, di cui è amara testimonianza il numero di decessi, che tende ad eguagliare, se non a superare, quelli della prima ondata. Misure parcellizzate, modulari, “colorate”: evidentemente, una strategia di mitigazione anche efficace, se però si accetta di far passare per naturale e inevitabile il suo durissimo costo, umano e sociale.
Il campo di lotta politico, in questa seconda ondata, è proprio questo. Respingere l’idea che le condizioni che hanno reso queste scelte di governo le uniche apparentemente ragionevoli e praticabili, siano presupposti dati, vincoli da accettare supinamente.
Non era destino trovarsi impreparati sul fronte del controllo attivo della pandemia, a cominciare dalle attività di tracciamento. La condizione dei dipartimenti di prevenzione delle Asl ha una lunga storia: è lo specchio dell’abbandono della salute come politica pubblica, della destrutturazione decennale della sorveglianza epidemiologica, come della medicina ambientale e del lavoro. La situazione del monitoraggio, la mancanza persino della minima omogeneità nei sistemi regionali di raccolta delle informazioni, ha riproposto la questione del trattamento e della disponibilità pubblica dei dati come questione democratica fondamentale, oltre che come presupposto della stessa efficacia della prevenzione. Si poteva e si doveva invertire la marcia. Davvero non potevamo permettercelo? Sul fronte della medicina di base e territoriale, a partire dalla tardiva e in molte regioni ancora aleatoria organizzazione delle unità speciali di continuità assistenziale, le USCA, la seconda ondata ci ha colto in una situazione non troppo lontana dalla prima, lasciando l’ospedalizzazione come unica frontiera di intervento. Davvero non potevamo permetterci altro che il rimpallo istituzionale tra governo centrale e regioni su posti letto, terapie intensive, strutture pubbliche per le quarantene? Davvero non potevamo permetterci altro che mantenere tutti i blocchi che caratterizzano le vite degli specializzandi in medicina, a partire dai numeri chiusi (dall’imbuto formativo fino ad arrivare ai vergognosi continui rinvii per quel che riguarda le assegnazioni delle borse di specializzazione per l’anno 2020), nonostante una mobilitazione capillare e costante ci avesse sbattuto sotto il naso, durante tutta la prima ondata, i nodi e le carenze strutturali del sistema? Davvero potevamo permetterci solo l’incessante retorica sull’eroismo degli angeli della sanità, mentre continuavano a mancare adeguati sistemi di screening e protezione che ne tutelassero adeguatamente la salute? Allo stesso modo, davvero potevamo permetterci solo protocolli di assunzione e formazione con una durata di pochi mesi basati su contratti co.co.co. (di collaborazione coordinata e continuativa) o contratti in libera professione, per sopperire alle carenze strutturali che sono emerse nella loro drammaticità nell’evolversi della pandemia?
Il fallimento sul fronte della difesa dell’istruzione e delle scuole – epocale, e lì sì, in un panorama di generale impreparazione occidentale alla seconda ondata, particolarmente e vergognosamente accentuato in Italia – racconta la stessa storia. Davvero non potevamo permetterci altro che la prosecuzione indecente di un concorso in piena pandemia, per mantenere il dogma tutto ideologico di una meritocrazia che passa sopra le vite, l’impegno effettivo, le competenze di generazioni precarie? È giustificabile come effetto di un destino non aver saputo ricostruire – neanche tendenzialmente, neanche come accenno – quel rapporto storico tra scuola e sanità territoriale, che pure era stato uno dei punti di forza dei nostri sistemi scolastico e sanitario? Davvero non potevamo permetterci soluzioni alternative alla DAD, o almeno di rendere il gap tecnologico meno violento di quanto si è dimostrato anche nella seconda ondata?
Anticipare le misure di intervento, come ha chiesto tutto il mondo della medicina, mentre le curve epidemiologiche già salivano in modo esponenziale, non è stato possibile. Sarebbe stato socialmente insostenibile, è stato risposto. E sicuramente è, nelle condizioni date, un’affermazione realistica. Come ha risposto Merkel a un giornalista, con la sincerità brutale che il punto più saldamente sviluppato in Europa del governo neoliberale può permettersi, è evidente che si poteva e doveva intervenire prima e meglio. Ma non sarebbe stato sostenibile, «non avremmo avuto il consenso». Occorreva aspettare insomma, quel tanto affinché le curve salissero. Questo è un realismo che conosciamo bene, da lungo tempo: è il realismo capitalista del non c’è alternativa. Ma la fragilità sociale che ha impedito l’intervento, mentre l’epidemia travolgeva le già malmesse prime linee del controllo, non è un dato. È il prodotto della fragilità degli interventi di welfare, della loro frammentarietà, del loro condizionamento e della loro provvisorietà. Proprio questa provvisorietà, nella seconda ondata, quanto più si predica dovunque che la tenuta sociale è a rischio, tanto più è stata assunta come norma fondamentale, indirizzo di governo esplicitamente proclamato. Consenso unanime dagli industriali sino all’Europa, per bocca di Gentiloni: possiamo e dobbiamo intervenire, anche con abbondanti iniezioni di liquidità per superare la crisi, ma la “cura” sociale va assunta rigorosamente come provvisoria, a termine, condizionata. Altro che reddito di base, insomma: frammentazione, selezione, temporaneità sono le parole d’ordine. Definitive e a lunga durata restano solo le ragioni delle imprese e del sistema finanziario. La società può essere aiutata (o “difesa”), ma non dovrà essere altro che una parentesi, come impone il mantenimento del governo del debito (un mantenimento d’altra parte difficile e contraddittorio con le trasformazioni delle strategie europee). Se così stanno le cose, la battaglia sulle risorse del piano Next Generation EU non potrà che essere durissima. E il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” presentato dal governo, indipendentemente dai conflitti attorno alla sua gestione, ne è un’evidente conferma sia per la suddivisione delle risorse che prospetta sia per la filosofia d’insieme che lo ispira.
Per noi questo tempo è tutt’altro che una parentesi. Del resto, anche la ricerca, la produzione e la distribuzione del vaccino, che dovrebbe chiudere la presunta parentesi e riportarci alla normalità, ci parlano non di una vittoriosa discesa del deus ex machina, che arriva finalmente a ristabilire le condizioni della nostra esistenza, ma di un campo di lotta profondamente segnato dalle logiche dell’accumulazione finanziaria e della proprietà. In molte e molti, in modi diversi ed eterogenei, abbiamo ripreso in questa seconda ondata gli spazi pubblici, le piazze e le strade, per quanto è stato possibile in queste difficilissime condizioni. Vogliamo dirlo con molta forza: in tutto il mondo di comitati, di assemblee, di manifestazioni e rivendicazioni che continua a emergere nelle città, c’è generosità, e c’è forza di intelligenza nel connettere le lotte che si moltiplicano nei settori fondamentali della riproduzione della vita, dalla sanità all’istruzione, al reddito, al salario. Sta emergendo, potenzialmente, una coalizione di tipo nuovo, capace di ripensare benessere e salute sia come istituzioni del comune sia, ancor più radicalmente, come trasformazione femminista ed ecologista delle relazioni e della stessa nostra modalità di stare al mondo. Con il volantone che avete sotto gli occhi e con le sei tesi che seguono, noi vogliamo provare a dare il nostro contributo, ovviamente parziale, perché la fondamentale consapevolezza della centralità della cura, del welfare e della lotta per la trasformazione delle sue strutture di base, si rafforzi e trovi il modo di andare all’attacco. Per rompere la logica dell’accettazione dell’inevitabile, delle condizionalità indiscutibili, del compromesso tra le ragioni di un sistema produttivo fondato sullo sfruttamento della forza-lavoro e della natura, e le ragioni della vita e della riproduzione sociale.
Possiamo, in fondo, anche darvi ragione: forse state governando la pandemia al vostro meglio. Ma è questo vostro “miglior governo possibile” che ha clamorosamente e dolorosamente fallito. La prosecuzione di questa logica, di questo governo dell’equilibrio precario tra vita e morte, tra produzione e riproduzione, è esattamente quel che davvero, è il caso di dire, non possiamo più permetterci. Anzi: non possiamo permettervelo.
Prima tesi. È in Europa che si gioca la battaglia decisiva per definire le linee fondamentali per l’uscita dalla crisi pandemica in ciascun Paese del continente. Nelle tumultuose trasformazioni che investono l’ordine e il disordine mondiale la dimensione europea non può che essere cruciale per la stessa azione dei movimenti e delle forze che si battono per la libertà e l’uguaglianza.
C’è una peculiarità europea nella gestione della pandemia. La si può cogliere per contrasto con il modo in cui è stata affrontata la crisi del 2007-2008. La violenza dell’austerity, così evidente nella crisi greca del 2015, aveva prolungato gli effetti di decenni di politiche neoliberali, con un’impronta duramente disciplinare e punitiva. Occorre tuttavia dirlo con chiarezza: a dispetto della sofferenza e del dolore che inflisse a intere popolazioni, quella gestione della crisi non ha funzionato in ultima istanza neppure dal punto di vista capitalistico. In molti Paesi europei la pandemia si è innestata su società impoverite e su economie stagnanti, in cui gli effetti della crisi del 2007-2008 continuavano a circolare. È stata la forza delle cose a imporre un atteggiamento diverso di fronte alla crisi pandemica da parte delle istituzioni europee. La sospensione del patto di stabilità, la copertura della spesa in deficit da parte delle politiche monetarie espansive della Banca Centrale Europea, la tendenziale mutualizzazione del debito configurano un approfondimento del processo di integrazione e un significativo scostamento dai dogmi neoliberali.
È bene intendersi. Stiamo parlando di tendenze contrastate, che andranno verificate sia all’interno di uno scenario mondiale anch’esso terremotato dalla crisi pandemica (per quel che riguarda l’approfondimento del processo di integrazione) sia rispetto a un capitalismo che anche in Europa uscirà dalla crisi con una intensificazione delle diseguaglianze e con tratti di inedita brutalità e violenza nei rapporti di lavoro e nella gestione della povertà (per quanto riguarda lo scostamento dai dogmi neoliberali). Decisivo, nei prossimi mesi, sarà in ogni caso il destino del Recovery Fund (Next Generation EU). E sappiamo bene che il neoliberalismo, pur indebolito dal punto di vista macroeconomico, può riemergere nel definire i criteri e le logiche di erogazione e di gestione delle risorse, a livello tanto europeo quanto nazionale (concorrenza, partenariati pubblico-privato, razionalità di impresa, etc.). Ma intanto non possiamo che registrare uno spostamento essenziale del terreno di scontro: non più lotte contro i tagli alla spesa pubblica ma contesa sulla quantità e sulla qualità degli investimenti, lotte per l’appropriazione di quote rilevanti di ricchezza sociale. Dobbiamo attrezzarci per questo scontro. E se appare decisiva l’azione dei movimenti sul piano europeo, la stessa lotta a livello “nazionale” ricade oggi immediatamente su quel piano. Spesa pubblica e welfare sono necessariamente al centro dello scontro.
Seconda tesi. Nella crisi pandemica lo Stato sociale torna a essere al centro dello scontro politico. Le lotte sulla salute e sull’istruzione anticipano e qualificano questa centralità. In questione non è il “ritorno” al Welfare State della seconda metà del Novecento, ma piuttosto l’invenzione di politiche sociali e istituzioni all’altezza dei bisogni di una nuova composizione del lavoro vivo.
La pandemia ha messo in evidenza anche in Italia la totale inadeguatezza di sistemi sanitari riorganizzati attorno alle logiche neoliberali ad affrontare un’emergenza sanitaria che era pur stata annunciata dalle organizzazioni internazionali e che nessuno può escludere possa ripresentarsi nel prossimo futuro (considerato in particolare il nesso tra la pandemia e gli squilibri ambientali). Questa inadeguatezza è stata denunciata fin dallo scorso mese di marzo da un insieme di mobilitazioni sul tema della sanità, che insieme a quelle sul tema dell’istruzione hanno prefigurato una mobilitazione generale sul welfare. Il compito che abbiamo oggi di fronte è lavorare per consolidare ed estendere questa mobilitazione anche ad altri ambiti di azione, a partire dal variegato campo della cultura e del lavoro culturale. Non abbiamo alcuna nostalgia per lo Stato sociale che si affermò in Europa occidentale (con diverse varianti) dopo la Seconda guerra mondiale. Sappiamo che quello Stato fu al tempo stesso una forma di riconoscimento e un dispositivo di contenimento della forza delle lotte operaie nel tempo dell’industrializzazione di massa. Dipendeva comunque da presupposti materiali da tempo scomparsi. E non dimentichiamo le molteplici esclusioni su cui si fondava, i suoi caratteri disciplinari, familisti e patriarcali, che un insieme di movimenti attaccò con efficacia negli anni Sessanta e Settanta. In ogni caso: quello Stato sociale non c’è più e non ritornerà. L’occasione che abbiamo oggi è quella di reinventare il Welfare State, di forgiare dall’interno delle lotte e sulla spinta dei movimenti (quello transfemminista, quello ecologista, quello dei migranti, in primo luogo) nuove politiche sociali, le forme di organizzazione che le rendono possibili e le istituzioni che ne possono sostenere la realizzazione.
Abbiamo imparato dal femminismo che parlare di welfare significa parlare di riproduzione sociale. È questo un punto di vista fondamentale, che ci consente di ripensare complessivamente lo stesso universo della produzione all’interno di una rinnovata critica dell’economia politica del welfare. Se lo Stato sociale della seconda metà del Novecento gestiva attraverso la spesa pubblica e l’erogazione di “salario indiretto” l’equilibrio complessivo della massa salariale garantendo la sua compatibilità con la crescita dei profitti, oggi al centro delle politiche sociali è la dimensione cooperativa del lavoro (il suo essere appunto partecipe della riproduzione sociale). Questa dimensione cooperativa può essere amministrata in termini residuali, puramente individuali e disciplinari (come avviene nei sistemi neoliberali di workfare), oppure può essere pienamente riconosciuta, attraverso sistemi di tutela che riconoscano le molteplici differenze di cui si compone oggi il lavoro vivo ma ne esaltino al tempo stesso la produttività e la potenza. È questo l’orizzonte al cui interno dobbiamo collocare le lotte sul welfare oggi, in Italia e in Europa.
Terza tesi. La lotta sul terreno del welfare non è una lotta “settoriale”. La produzione non si oppone alla riproduzione, così come il salario non si oppone al reddito. I movimenti più importanti di questi anni danno un contributo fondamentale alla reinvenzione del welfare. Una politica della coalizione è possibile e necessaria.
Dovrebbe essere chiaro che per noi parlare di welfare non significa parlare di un ambito “specialistico” (per quanto riconosciamo l’importanza delle competenze specifiche che caratterizzano il lavoro nella sanità e nell’istruzione). Il welfare, per noi, non è in particolare separato dalla sfera della produzione. Al contrario. Le lotte sul lavoro sono un aspetto fondamentale delle lotte sul welfare. Mentre riteniamo che il reddito di base universale non possa che essere un elemento costitutivo di nuove politiche sociali, attorno alle lotte per il salario continuano a giocarsi partite fondamentali. È attraverso queste lotte che gli sfruttati conquistano potere sociale, e la crescita di questo potere sociale degli sfruttati è l’antidoto essenziale alla deriva meramente assistenziale e residuale del welfare – nonché a una sua deriva corporativa e alla frammentazione delle politiche di welfare su base aziendale. La contrattazione collettiva può tornare a giocare un ruolo importante, ma è necessario che si accompagni all’introduzione di un minimo salariale alto e universale, che funzioni da base per la stessa contrattazione collettiva e tuteli lavoratori e lavoratrici che a quest’ultima non hanno accesso. In ogni caso, il mercato del lavoro costituisce un terreno essenziale di intervento, sulla base di un’attenzione meticolosa alle nuove figure che al suo interno si muovono. Negli ultimi mesi, le lotte e le mobilitazioni dei rider hanno dato indicazioni fondamentali in questo senso.
Attorno al welfare è necessario immaginare oggi una nuova politica della coalizione. Le grandi mobilitazioni degli ultimi mesi negli Stati Uniti per le “vite nere” e contro il “razzismo sistemico” hanno mostrato la potenza di un movimento che attorno all’insorgenza afroamericana ha registrato la convergenza di un insieme eterogeneo di soggetti– dai latinx al movimento femminista, dalle dissidenze sessuali a “centri di comunità” e sezioni sindacali. La specificità di ciascuno di questi soggetti non si è annullata nella convergenza, ha piuttosto rappresentato una leva per la moltiplicazione della sua potenza. Analogamente, quando immaginiamo una politica della coalizione sul terreno del welfare, siamo ben lungi dal ridurre a questo tema l’azione dei movimenti che pensiamo debbano esserne parte. Sottolineiamo piuttosto come in particolare il movimento femminista, il movimento ecologista e quello dei migranti abbiano un contributo essenziale da offrire alla reinvenzione del welfare. Abbiamo già menzionato l’importanza delle elaborazioni femministe attorno alla riproduzione sociale. Queste elaborazioni sono nutrite da una lunga storia di lotte contro i caratteri patriarcali e familisti delle politiche sociali: l’azione del movimento femminista su questi temi continua a essere essenziale oggi. Su un diverso piano, analogo discorso può essere fatto per il movimento ecologista, che pone la questione fondamentale della qualità dello sviluppo collegato al welfare (e che al tempo stesso ci sfida a ripensare in particolare il problema del rapporto tra salute e territorio). Il movimento dei migranti, per parte sua, politicizza il rapporto tra welfare e cittadinanza, contestando i confini di quest’ultima nel Mediterraneo così come su altri confini esterni dell’Europa e battendosi quotidianamente contro il razzismo tanto nella società quanto nel lavoro. Si vede bene, insomma, come il tema del welfare, lungi dall’essere “settoriale”, possa essere articolato all’interno di una più generale politica della coalizione, capace di includere eterogenei movimenti e lotte sociali.
Quarta tesi. Il Welfare State è anche un settore del lavoro, nel quale, da almeno tre decenni, si sono estesi a dismisura precarietà contrattuale e salari da fame. Combattere per il Welfare State significa oggi, più che mai, pretendere un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario nella sanità e nell’istruzione, nella pubblica amministrazione in generale, nonché il potenziamento degli organici.
Sono noti, in Italia e non solo, gli inesauribili bacini di lavoro precario nella sanità e nella scuola. È meno noto ai più che, spesso e volentieri, il personale che si incontra in una scuola o in un ospedale pubblici, non è dipendente pubblico. La neoliberalizzazione del Welfare State, infatti, ha portato con sé un incessante processo di esternalizzazione del lavoro. Gli strumenti sono tanti e diversi, ma primeggiano le cooperative sociali. La giungla degli appalti e dei subappalti, pensate alle mense o alle pulizie, favoriscono una segmentazione contrattuale e salariale che indebolisce la contrattazione collettiva. Nella sanità, tra l’altro, il fenomeno si estende anche al personale qualificato (dai medici agli infermieri, dal personale della riabilitazione agli psicologi) che, quando non è “fintamente” autonomo, ovvero ha rapporti di lavoro formalmente libero-professionali ma sostanzialmente subordinati, è dipendente precario di cooperative sociali. Il dispositivo delle scatole cinesi, dal punto di vista delle aziende, e della frammentazione, dal punto di vista contrattuale e dunque salariale, polverizza la capacità negoziale, riduce pesantemente il costo del lavoro e i diritti.
Fenomeni analoghi riguardano la pubblica amministrazione in generale, in particolare la consulenza tecnica ai ministeri. Già da diversi decenni, ma con maggiore forza a partire dal 2008, il turn over nella pubblica amministrazione è bloccato. Proliferano invece le società in house dei diversi ministeri e non solo: aziende private secondo la governance e la forma giuridica, pubbliche per quel che riguarda il capitale e i servizi erogati. Enti strumentali dei ministeri, nei quali abbonda personale altamente qualificato, spesso e volentieri precario, spesso sotto-inquadrato, ricattato da una farraginosa sequela di prove selettive e valutazioni. È evidente che le società in house non riducono la spesa pubblica, semplicemente segmentano la forza-lavoro e la contrattazione collettiva, fomentano il clientelarismo che dicono di combattere, alimentano ideologie meritocratiche e competizione tra lavoratori, rinnovano incessantemente divisioni tra garantiti e non garantiti. Pretendere estensione e rafforzamento del welfare vuol dire dunque rivendicare un piano straordinario di a) stabilizzazioni del personale precario, b) assunzione semplificata del personale illecitamente esternalizzato. In entrambi i casi prima analizzati, le aziende svolgono, non sempre ma con frequenza, intermediazione illecita di manodopera; non troppo diversamente da quella che investe altri strategici settori produttivi, quali la logistica per esempio. Invertire la tendenza significa potenziare gli organici – con essi la qualità del servizio – di sanità, istruzione, pubblica amministrazione. Ciò vuol dire anche prendere di petto la disoccupazione (strutturale) e la sotto-occupazione che opprime la forza-lavoro qualificata e giovanile.
Quinta tesi. Non c’è difesa e rafforzamento del Welfare State che non passi per la radicale ridefinizione del fisco. Ciò vuol dire in primo luogo, però, eliminare il dumping fiscale europeo e introdurre omogenee e rilevanti imposte sui grandi patrimoni.
Quando si parla di tasse, l’opinione comune non ha dubbi: sono troppe e troppo care. Ciò, in Italia, è spesso una litania che mette assieme ricchi e poveri. La verità, invece, è che a partire dalla metà degli anni Settanta, in Italia e in Europa, il fisco ha smesso di essere progressivo, ovvero di seguire la regola che paga di più chi ha di più. Politiche fiscali di segno opposto, ovvero regressive, sono state in primo luogo una risposta al potere operaio e sociale degli anni Sessanta e Settanta. La crescita del salario diretto e di quello indiretto è stata combattuta – anche – con l’estensione a dismisura dell’evasione fiscale, soprattutto con una persistente detassazione dei capitali. Fenomeni ai quali ha fatto seguito l’indebitamento sui mercati finanziari degli Stati nazionali. Sappiamo che il debito pubblico – al pari dei contratti di lavoro temporanei, tra l’altro – è un ricatto costante che viene imposto alle fasce povere della popolazione. Attraverso la vigenza dell’enunciato “non ce n’è per tutti”, si impone lo stato di natura della concorrenza generalizzata e dell’individuo competitivo.
Mentre internet diviene sempre più terreno di nuova accumulazione e sempre meno spazio democratico si fa sempre più evidente l’assenza di vincolo tra Stato nazionale e capitale globale. Proprio per questo l’esempio spagnolo, ovvero l’introduzione di una tassa patrimoniale, va generalizzato all’intera UE. Non solo, infatti, non è più tollerabile che nei vari Stati il fisco sia regressivo; non è in alcun modo tollerabile che Olanda o Irlanda siano veri e propri paradisi fiscali per le grandi corporation multinazionali. La mutualizzazione del debito pubblico che sta mettendo in campo l’Europa, per far fronte alla pandemia e alla catastrofe economica, non può che essere accompagnata da una uniformazione dei regimi fiscali. Sarebbe una mossa decisiva per uniformare anche i sistemi di welfare, gli ammortizzatori sociali, il reddito di cittadinanza (che in particolare nel contesto italiano deve essere ampliato in direzione di un reddito di base incondizionato e universale). Lottare per una rinnovata progressività fiscale vuol dire pure combattere le misure economiche che intendono curare il «cataclisma occupazionale» attraverso la decontribuzione e una spropositata moltiplicazione delle agevolazioni fiscali per le imprese. Non è vero, lo dimostrano i numeri, che il sostegno alle aziende, agito anche attraverso i prestiti a fondo perduto garantiti dalle casse pubbliche, favoriscono la ripresa dell’occupazione. È vero invece che, senza universali misure di sostegno al reddito, la povertà dilaga; è vero che gli ammortizzatori sociali esistenti sono frammentati e particolaristici, e favoriscono spesso più le imprese che lavoratrici e lavoratori. Contro tutto ciò, fisco e patrimoniale continentali sono lo strumento per combattere disuguaglianza e povertà; più in generale, affinché ci siano risorse utili per finanziare adeguatamente il Welfare State e le misure di sostegno al reddito. È possibile quindi, attorno al tema della patrimoniale, sperimentare convergenze sociali e politiche in grado di contendere, nello scenario attuale fortemente caratterizzato dalle retoriche liberali e dalle pressioni delle organizzazioni datoriali, il segno delle politiche redistributive.
Sesta tesi. Il welfare così come è, anche se rifinanziato e con gli organici potenziati, non basta. Serve democratizzarlo, radicalmente. Nello stesso tempo, occorre rivendicare risorse per il welfare urbano e autogestito.
A partire dagli anni Novanta, l’Europa contagiata dal New Labour di Blair ha impoverito e aziendalizzato il welfare pubblico, combinandolo sempre di più con quello privato. Il welfare mix è la formula che riassume questo processo. Se pensiamo per esempio alla sanità italiana, vediamo che, sempre più, le Regioni favoriscono i soggetti privati i quali, attraverso il meccanismo dell’accreditamento, forniscono servizi essenziali pagati dalle casse pubbliche ma i cui utili sono tutto tranne che pubblici. Le prestazioni, infatti, vengono dallo Stato pagate alla stessa maniera, ma quelle erogate dalle aziende private costano meno dal punto di vista del lavoro. Nelle aziende private accreditate prevalgono infatti finto lavoro autonomo, esternalizzazioni a mezzo di cooperative sociali, in sintesi massima precarietà delle condizioni di lavoro, tra l’altro favorite da un contratto collettivo dissimile da quello applicato nel pubblico impiego. La sanità privata è diventata dunque un affare tra i migliori, spesso combinato – non casualmente – con la speculazione finanziaria e in alcuni casi, addirittura, con l’economia criminale. Così avviene anche con le altre istituzioni del welfare. Il welfare mix si è poi accompagnato, negli anni, al New Public Management: la corporate governance si è fatta legge anche per le istituzioni pubbliche, con Amministratori e Presidenti super pagati, l’uso in abbondanza di dispositivi meritocratici che alimentano la concorrenza tra lavoratrici e lavoratori, dipendenti stabili e precari, personale pubblico e quello esternalizzato. Alla neoliberalizzazione, contrariamente a quanto affermato dalla vulgata, non hanno smesso di accompagnarsi meccanismi nepotistici e feudali, nel reclutamento del personale e nella definizione dei poteri. Nell’erogazione dei servizi, poi, non hanno smesso di prevalere logiche patriarcali e familistiche.
Non basta dunque difendere il Welfare State e rafforzarlo, serve un vero processo di riappropriazione democratica dello stesso. La democratizzazione delle istituzioni pubbliche, poi, deve essere combinata alla proliferazione di istituzioni solidali, e del lavoro vivo, autogestite. Il welfare indipendente non può essere marginale, deve invece accedere alle ingenti risorse europee che saranno messe in circolazione dal Recovery Fund. Si tratta dunque di imporre un nuovo mix, non più quello pubblico-privato, ma quello pubblico-comune. In questa direzione, e non da poco tempo, vanno le esperienze di lotta femministe, i nuovi esperimenti sindacali, il mutualismo radicato negli spazi sociali autogestiti. Tutto ciò può e deve rafforzare i nessi organizzativi, in senso federalista e orizzontale, e conquistare così la forza e la forma di un vero e proprio contropotere sociale e politico.
#ilmondocheverrà