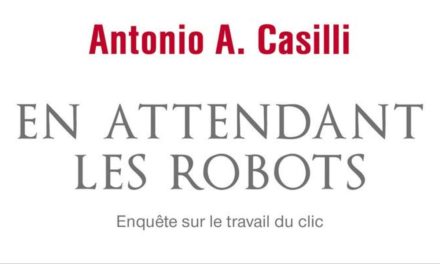Di ROBERTO CICCARELLI.
La precarietà nel lavoro digitale oggi è quotata in borsa e vale 43 dollari ad azione, tre in meno rispetto ai 45 stabiliti dall’offerta pubblica iniziale per quotarsi per la prima volta sul mercato finanziario. Questo è il prezzo di Uber stabilito dalla borsa di New York (Nyse) al termine di una giornata che ha visto l’azienda di trasporto privato che connette passeggeri e autisti attraverso una «app» su smartphone assumere il valore di poco più di 77 miliardi di dollari, contro gli 82,4 annunciati. Cifre in ogni caso molto lontane dal valore di 120 miliardi stimati l’anno scorso. Dopo la quotazione di Facebook nel 2012 e quella di Alibaba, l’analogo cinese di Amazon nel 2014, la borsa americana non aveva più visto un evento di questa ampiezza mediatica.
L’AZIENDA INSTALLATA a Wall Street è un paradigma della produzione, organizzazione del lavoro e della società definito «Uberizzazione». Con questo concetto si intende, in tutto il mondo, il rovescio delle promesse falsamente umanistiche dell’«economia della condivisione». Questo modello implica la declassificazione degli autisti da lavoratori dipendenti eterodiretti da un algoritmo in lavoratori autonomi o «collaboratori» che devono sostenere, tra l’altro, le spese di manutenzione dell’auto, senza contare quelle assicurative e previdenziali.
L’OPERAZIONE è stata accompagnata da uno sciopero globale degli autisti (3,9 milioni registrati sulla piattaforma il 31 dicembre 2018) da Los Angeles a New York, dall’Australia al Brasile, dalla Nigeria a Londra, lo sciopero ha avuto il sostegno di Bernie Sanders e un certo risalto su Twitter. Uber si è sempre opposta ai tentativi di sindacalizzazione dei suoi autisti, a Seattle o a New York. «Vogliamo migliorare la loro situazione» ha detto Dara Khosrowshahi, il nuovo amministratore delegato di origini iraniane, senza precisare come.
A DIFFERENZA di altre aziende come Apple che hanno una base nell’economia manifatturiera, ibridata con quella digitale, Uber incarna il mistero della cosiddetta «app economy». Non produce cellulari, né laptop, non organizza le grandi filiere della logistica collegandole con l’e-commerce come Amazon. Uber è «solo» una piattaforma digitale governata da un algoritmo la cui segretezza è pari alla sua redditività. Simbolo dell’immaterialità più produttiva, questo dispositivo è alla base di una gigantesca economia dei dati, della reputazione e dell’apprendimento automatico degli algoritmi che ha fatto le fortune dei suoi co-fondatori sin dal 2009, Garret Camp e il rissoso Travis Kalanick, licenziato dal ruolo di amministratore delegato nel giugno 2017, ma tra i maggiori azionisti dell’unicorno di San Francisco, insieme con Khosrowshahi che lo ha sostituito.
«UBERIZZAZIONE» è, infine, il sinonimo di un’economia finanziaria alimentata dalla potente propaganda digitale che ha reso un modello un’azienda che brucia un miliardo di dollari (891 milioni di euro) all’anno e ha margini di profitti ancora misteriosi in futuro. Questo aspetto può risultare incomprensibile dal punto di vista di un’impresa capitalistica «classica», ma in realtà è quasi la norma in quella digitale. Colossali aziende ipervalutate raccolgono enormi capitali di ventura da fondi di investimento con la promessa di una diversificazione, articolazione e redditività. Nel caso di Uber parliamo tra gli altri del fondo di investimento giapponese SoftBank, del fondo sovrano Saudi Arabia, il «venture capital» Benchmark Capital. La volatilità di questa economia grava sulle aspettative dell’azienda che ha scatenato in tutto il mondo reazioni giuridiche e fiscali da parte di istituzioni e tribunali, oltre che 10 anni di proteste. Negli ultimi mesi Khosrowshahi ha cercato di modificare l’immagine di una compagnia travolta da casi di molestie e violenze sessuali che hanno portato al licenziamento di più di 20 persone e al pagamento di 1,9 milioni di dollari, oltre che al versamento di 11 mila dollari per una class action per 485 casi di discriminazione.
ORA L’OBIETTIVO è sviluppare le attività dai taxi all’affitto degli scooter e bici elettriche, il «taxi volante», l’auto a guida autonoma e la consegna di cibo a domicilio (UberEats). Il tentativo è diventare l’«Amazon» dei trasporti, senza essere però Amazon che ha ibridato l’infrastruttura logistica degli hub e dei magazzini, con i servizi cloud, il trasporto con il microlavoro digitale e la produzione di immaginario.
Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto l’11 maggio 2019.
Per approfondire sullo sciopero Uber segnaliamo:
Uber Drivers’ Day of Strikes Circles the Globe Before the Company’s I.P.O.
Uber Strikes Could Be the Start of Something Bigger