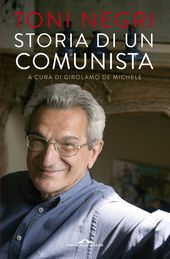Di GIROLAMO DE MICHELE
Più che un testo organico quelle che seguono sono parole a margine di alcuni ottimi testi prodotti in queste settimane (e ne presuppongono la condivisione): Dentro e contro la crisi pandemica di Sandro Mezzadra, e Combattere nella grande frattura dello stesso Mezzadra con Francesco Raparelli; cui aggiungerei l’analisi di Christian Marazzi Economia della dismisura.
Il tema comune è costituito dalle politiche che, sul lato del comando e del capitale, si mettono in campo sotto la pressione della crisi implementata oltremisura dalla pandemia: «Tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, la politica monetaria ha fatto un salto di qualità, e nei fatti sta coprendo e rendendo possibile la spesa in deficit degli Stati – ovvero quel deficit spending che il dogma neoliberale del pareggio di bilancio ha sempre inteso scongiurare». In concreto, la sospensione dei parametri di Maastricht, l’annunciata presa di congedo della FED dall’inflazione al 2% come riferimento per le politiche monetarie, il “Recovery Fund” europeo (“NextGenerationEU”), «che mobilita risorse ingenti per la digitalizzazione e la transizione ecologica, ma anche – lo ha ribadito Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo “stato dell’Unione 2020” – per il potenziamento dei sistemi sanitari e formativi».
Senza essere assertivi (e un po’ arroganti) come i Baustelle, è possibile pensare che il liberismo ha i giorni contati (forse). Nondimeno, per citare a memoria le parole di un Paolo Virno d’annata (mi pare fosse il 1993), che prendendo le distanze da chi ipotizzava una “felice eutanasia” del capitale, ammoniva che al contrario le asperità e gli aculei del capitale erano (e sono) alla loro acme: non è banale ricordare che una eventuale morte pandemica del capitale non produrrà in modo naturale una società migliore o più giusta. Ci sono anzi concrete possibilità che a lasciar fare all’ordine delle cose si aprano scenari peggiori. Se, insomma, il capitalismo non è destinato a morire di morte naturale, è fondamentale il modo, e la mano, di chi provocherà la sua morte: perché è in queste modalità che si determinerà la genesi di quel nuovo che, nell’attuale interregno, ancora non si vede.
Il terreno del welfare appare, credo a giusta ragione, come il terreno privilegiato tanto delle politiche che proveranno a invertire il ciclo della crisi, quanto delle lotte. Lo si vede bene nella fase finale della campagna elettorale statunitense, dove sempre più centrale diventa il futuro del Recovery Act, cioè delle politiche sanitarie che saranno determinate tanto dal nuovo presidente, quanto dalla composizione della Corte Suprema.
Un terreno, quello del welfare, tutt’altro che liscio o pacificato, anzi scabroso, nel quale sono presenti pericoli autoritari: basti pensare, di nuovo, al presidente Trump, che se per un verso tuona contro nuove tasse (tradotto: l’implementazione del Recovery Act, che è formalmente una tassa), dall’altro, come ci ricorda Marazzi, ha attuato lui stesso politiche di intervento in direzione del reddito di base (l’erogazione del sussidio di disoccupazione di 600 dollari per chi svolge dei bullshit job). Terreno che presenta a noi l’irrisolto rompicapo del convergere dei conflitti, sul quale ci rompiamo la testa da anni senza venirne, per ora, a capo; ma senza che i conflitti cessino di spuntare da un lato quando sembrano cessare dall’altro: problema al tempo stesso tattico e strategico, al quale dovremo dedicare le nostre intelligenze, e per il quale alcune indicazioni di metodo provenienti dalle lotte in corso (penso alla scuola e alla sua Priorità, in prima battuta) possono essere estese e sperimentate in altri segmenti sociali. Così come la crescente riflessione sul lavoro di cura, un terreno che va senz’altro assunto in modo critico, ma che nel rivelare la natura di cura delle prestazioni lavorative manifesta un comune che sottende le differenze empiriche delle modalità di genesi/estrazione del valore. Ho l’impressione che questa tonalità si moltiplicherà, con l’acuirsi della crisi e dei suoi aculei: credo che le pratiche, e la loro necessità, di cura reciproca e solidaristica cresceranno con l’accrescersi della crisi economica, che ancora non ha mostrato tutta la sua gravità. Nei giorni dell’emergenza più acuta abbiamo sperimentato, anche attivamente e direttamente, pratiche di mutualismo e solidarismo; a giusta ragione le abbiamo rivendicate come prefigurazione del mondo che vogliamo, contro il facile moralismo di chi ci ricordava che la solidarietà senza conflitto è “roba da cattolici” (grazie, lo sapevamo: qualche volta anche i cattolici fanno cose buone). E contro la povertà di chi ci faceva la morale dicendo che non bisogna fare la spesa agli anziani senza essere pagati, ma di portare gli anziani a fare la spesa senza pagarla: non essendo, questi Catoni, abbastanza comunisti da fare la prima cosa, né abbastanza rivoluzionari per organizzare la seconda. Questo disprezzo per le pratiche solidaristiche, o per i più tragici aspetti umani della pandemia, dimostra peraltro quanto la “cultura dello scarto” sia penetrata in profondità: non per caso, alcuni di questi disprezzatori si erano in precedenza segnalati per le loro alzate di sopracciglio a fronte delle pratiche si soccorso militante dei migranti.
E questo mi porta al cuore delle mie riflessioni. Condividere la proposta di fare del welfare un terreno di lotte anche dure, anche radicali pone un problema di immaginario che vada oltre il conflitto sociale, e si proponga come punto d’arrivo – né noumenico né kantiano – il superamento del capitalismo e l’attualità del comunismo. Il terreno del welfare resta, con tutta la radicalità con cui possiamo attraversarlo, un terreno riformista: il che non vuol dire rigettare una concreta possibilità di lotta in nome di un radicalismo più o meno utopistico, e rifugiarci in collina a coltivare grano e uve in attesa del Messia.
L’orizzonte comunista è un vasto programma senz’altro, ma che deve ridiventare attuale: se non ora, quando?, diceva un comunista torinese poco incline a messianismi e utopie. È probabile che da qui a un anno ci toccherà vedere e attraversare esperienze già note a chi ha rapporti con l’America Latina (ma anche certi quartieri meridiani d’Italia): mercatini del libero scambio di beni primari, rudimentali forme di autoproduzione e autogestione, organizzazioni nei quartieri dei servizi minimi (comprese salute ed educazione). L’attualità del comunismo è non solo nell’evidenza di queste pratiche, ma anche nella consapevolezza, che la crisi ci sbatte in faccia, dell’assurdità e dell’invivibilità dell’organizzazione della società – della salute pubblica, del lavoro, dell’istruzione, pesino dello sport e della pratica del tempo libero: in una parola, della vita in sé, che non è mai nuda, ma sempre piena di possibilità e materialità. Il comunismo non è solo il movimento reale che distrugge lo stato di cose presente – che dunque si realizza non all’indomani di una transizione, ma nel farsi stesso di una transizione che si attua giorno per giorno. Comunismo è l’orizzonte che dà senso al mondo che vogliamo: e non può darlo se non torniamo a pensarlo come qualcosa di reale, qui e ora – il movimento reale, per l’appunto. Che realizza un altro mondo, dopo la fine del mondo.
La fine del mondo è il problema che la crisi pandemica e la crisi ambientale ci pongono davanti: l’intreccio della consapevolezza che il mondo come lo intendiamo noi, nel quale abitiamo, può finire; e il desiderio che, per realizzarne uno migliore, questo mondo debba finire. Come ha sottolineato in un bell’intervento Veronica Pecile, richiamando gli studi di Ernesto De Martino, siamo in presenza di una acuta percezione di una crisi della presenza, cioè di quelle pratiche abitudinarie il cui compito è mantenere coesa una comunità:
Durante la pandemia – un evento totale che ci impone cambiamenti socio-economici di portata sistemica – ci troviamo ad affrontare una crisi della presenza, una paura radicale di non esserci. La totalità dell’evento è in grado di occludere un duplice orizzonte: quello spaziale (l’impossibilità di muoversi) e quello temporale (l’impossibilità di pianificare). Se la precarizzazione delle nostre vite ci aveva in sostanza già imposto la seconda incapacità – la rinuncia al tempo, al futuro – con il venir meno della libertà di muoversi nello spazio anche il presente si è annullato.
De Martino racconta l’esperienza di un contadino calabrese che, salito sulla sua auto, ebbe una crisi (che costrinse l’etnologo a riportarlo indietro) quando il campanile del paese (Marcellinara) scomparve dal suo quadro visivo: dietro la perdita, esperita probabilmente per la prima volta, di un punto di riferimento abituale (il campanile) si manifestava una più radicale paura di non esserci più. È probabile – bisognerebbe lavorare su questo – che la follia negazionista e/o complottista cui si assiste, dietro le solo in apparenza grottesche prese di parola di chi ha preso la laurea breve in immunologia su facebook o studia medicina farmaceutica sui tweet di Trump, sia l’espressione di questa crisi radicale di una struttura epistemica della mente. Una crisi che, di per sé, può generare immaginari sostitutivi in presenza dei quali ci sarebbe da temere il peggio; si veda l’esemplare, in ogni senso, invettiva fascisteggiante di Marcello Veneziani contro la (secondo lui) riduzione, nell’enciclica Tutti fratelli, della Trinità alla sola figura del Cristo a scapito della supremazia del Padre: «È il Padre a garantire l’unità dei fratelli prima che il reciproco riconoscimento, è la Madre a soccorrerli prima che intervenga il diritto di cittadinanza; e dal Padre al figlio scorre il filo d’oro della Tradizione» (Recalcati, si potrebbe dire, je spiccia casa).
Si tratta di essere all’altezza della sfida posta dalla concreta possibilità della distruzione della vita e dell’ambiente, e al tempo stesso della potenzialità di liberazione dalla miseria e dal servaggio insite entrambe nell’attuale modello di organizzazione della vita, del sapere, delle merci e del valore. La prefigurazione di un mondo nel quale la vita biologica non sia assoggettata a condizioni, processi e istituzioni che la mettono a repentaglio ci impone di interrogarci su quali lotte ambientali che vadano oltre la povertà del Green New Deal (che non fuoriesce dal campi dell’immaginario dominante) possiamo attraversare, implementare, al limite accendere.
Qui (lo dico solo come paragone, senza entrare nel merito e nel ginepraio di polemiche che potrei suscitare) dovremmo prestare più attenzione non ai contenuti, ma al metodo delle prese di parola di papa Francesco: che, al di là di ciò che possiamo o meno condividere del suo programma, si muove da tempo (col vantaggio di avere già un orizzonte escatologico) sul piano del simbolico, per modificare l’immaginario del suo “popolo”. Spesso si sente dire che Bergoglio dica più di quanto non faccia: una critica che mostra una scarsa comprensione della dimensione del simbolico, che è per la Chiesa prioritaria e prevalente. Un terreno, quello simbolico, sul quale il pensiero critico mi sembra da tempo assente, fatte salve le riflessioni femministe e qualche isolato tentativo, apprezzabile e misterioso, di curvare la retta di Lacan.
In sintesi: o l’assurdità di un mondo nel quale si muore senza cure, senza un letto d’ospedale e senza un perché si rovescia nella critica radicale, e nella creazione (che è un processo di soggettivazione) di questo senso nel concreto, o il mondo esperito piomba nell’assurdo, o nella tana del bianconiglio. De Martino esprimeva questa esigenza parlando della fondazione di un nuovo ethos culturale «non più adeguato al campanile di Marcellinara», che a lui sembrava essere il problema centrale del mondo di oggi:
Nella misura in cui questo nuovo ethos si renderà realmente operante e unificante, raccogliendo in una consapevole ecumenicità di valori comuni la originaria dispersione e divisione delle genti e delle culture, il mondo che “non deve” finire uscirà vittorioso dalla ricorrente tentazione del mondo che “può” finire, e la fine di “un mondo” non significherà la fine “del mondo” ma, semplicemente, “il mondo di domani”.