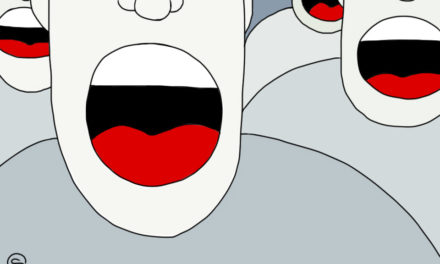di MARCO BASCETTA.
Una costante sensazione di vuoto e di astrattezza ha aleggiato sulla lunga trattativa seguita alle elezioni del 4 di marzo e su tutte le formule che nel suo corso sono state evocate. Formule, appunto, arbitrariamente applicate a una realtà sociale che rimane sostanzialmente ignota. Nella loro apparente concretezza “le cose da fare” rimangono parole più adatte a suggestionare che a significare. Se la flat tax e il cosiddetto reddito di cittadinanza fossero davvero qualcosa si troverebbero nello stesso rapporto che contrappone Robin Hood allo sceriffo di Sherwood. Ma poiché non sono nulla possono serenamente convivere in uno stesso programma di governo. Queste “cose”, nella loro materiale concretezza, altro non sono, infatti, che rapporti sociali e modi di vita in una fase di trasformazione tanto caotica quanto colpevolmente incompresa. Non l’oggetto di quella bulimia legislativa che ha accompagnato le convulsioni della crisi aggravandone peraltro gli effetti. La recente esperienza ci dice che meglio converrebbe stabilire “le cose da non fare”.
Non sbaglia Massimo Cacciari su L’Espresso quando ricorda che l’intero assetto politico e culturale del dopoguerra è andato in pezzi senza che nessuna “nuova Repubblica” riesca a progettarne uno diverso. Ed è andato in pezzi perché i modi di vivere e di produrre, gli equilibri planetari, le relazioni internazionali si sono trasformati così radicalmente da generare “un altro mondo impossibile”. Questo esito letteralmente catastrofico che si trascina in una condizione di crisi permanente porrebbe delle domande talmente radicali che nessuno osa nemmeno pronunciarle. Come all’indomani di una guerra ci troveremmo nella condizione di dover rifondare tutto. Ma non siamo nel 1946 e la guerra, quella che il neoliberalismo ha condotto contro il compromesso sociale postbellico e le sue possibili riformulazioni non è ancora conclusa. Non tanto perché il capitale non abbia stravinto sui suoi antagonisti, quanto per l’aggressività che gli è connaturata alla quale deve perennemente dare sfogo e perché l’estensione senza limiti del processo di accumulazione produce continui paradossi, inevitabili fenomeni di rigetto e soggettività che sfuggono al controllo.
Quanto di tutto questo la politica, e naturalmente non solo quella nostrana affetta da un surplus di narcisismo provinciale, abbia saputo davvero mettere a fuoco ce lo dice l’avvitarsi feroce e inconcludente della crisi. Nel caso italiano non manca solo il tema strategico di quale sbocco dare alle nuove contraddizioni che attraversano il corpo sociale e di come fare fronte agli squilibri globali, ma perfino la cognizione della crisi nelle sue manifestazioni contingenti. Qualcuno si pone forse, continuando a sbandierare il “primato nazionale”, la questione di dove possa condurre la guerra dei dazi, e di quanto questa abbia a che vedere con la guerra persiana che Trump conduce anche contro l’Europa? E, in questo frangente, quale senso abbia lavorare all’indebolimento di una Unione già sufficientemente disorientata e divisa? Si deve insomma ammirare ed emulare l’“America first” del miliardario newyorkese o combattere i danni che questa politica ci infligge e i rischi a cui ci espone?
C’è da scommettere che nel “contratto di governo” tra Lega e 5stelle non troveremo risposte a queste domande tanto elementari quanto decisive. Come non troveremo alcuna comprensione reale di un fenomeno storico come quello delle migrazioni se non varianti colorite dell’ipocrisia e del cinismo già esibiti dall’ex ministro degli interni, il democratico Minniti. La catastrofe in corso viene percepita, o spacciata, come una occasione di rinnovamento nascondendosi l’imminenza del drammatico punto di rottura che ci costringerà ad attraversare.
In questo magma indistinto un elemento è però certo: la scomparsa della sinistra, di tutta la sinistra, quella ex socialdemocratica come quella detta, chissà perché, radicale. Entrambe, non disponendo più di una lingua comune con le figure sociali emergenti e nemmeno con le nuove condizioni in cui versano quelle tradizionali, hanno incominciato a parlare la lingua delle controparti. Le sinistre “moderate” quella del neoliberismo, della competitività, del calcolo costi-benefici (Schroeder, Blair, Hollande, il Pd) entrando così in quell’ordine di sparizione che ha falcidiato socialisti tedeschi, francesi, italiani, greci, austriaci per cominciare.
Le sinistre “radicali” la lingua del nazionalismo di ritorno (la vera sostanza di ciò che viene denominato populismo) fondata sull’astrazione di un popolo che esiste solo nell’autolegittimazione di chi pretende di incarnarne la volontà. Di proprio, le une e le altre, hanno conservato brandelli di una lingua morta che ruota attorno alla figura e al ruolo dello Stato sulla cui natura contemporanea, e sul cui rapporto col Mercato nessuno sente più il bisogno di interrogarsi. Così, nel susseguirsi ininterrotto delle sconfitte, le sinistre finiscono col replicare, attraverso il mantra della rifondazione, quella stessa astrazione mascherata da concretezza che governa l’agire politico di chi ha oggi conquistato il centro della scena.
Questa rincorsa parallela del mondo “senza alternative” sostenuto dal neoliberismo e della “sovranità popolare” imbandita dai redivivi nazionalismi ha il suo denominatore comune nella concezione di una società non attraversata da conflitti, nella quale gli interessi degli uni e quelli degli altri possono sempre conciliarsi quando non coincidano direttamente. E’ questo il significato di espressioni come “partito della nazione”, “prima gli italiani”, “contratto di governo”, le quali altro non fanno che prescrivere l’adeguamento dei comportamenti sociali a un quadro ideologico semplificato all’estremo.
E che non sembra contemplare altro conflitto, all’interno della compagine sociale, che quello tra onesti e corrotti, tra legalità e illegalità. Laddove ciascuna di queste polarità assume di volta in volta contorni e significati diversi a seconda dei rapporti di potere e delle convenienze. Proprio in Italia, del resto, abbiamo avuto l’esempio più illuminante della fine ingloriosa toccata alla prima forza politica che aveva innalzato questa bandiera: L’Italia dei valori di Antonio di Pietro. Ed è proprio sulla dominanza di questa contrapposizione, che esprime in realtà il punto di vista della conservazione e il fondamento possibile di uno stato di polizia, che la Lega e il Movimento 5 stelle mostrano essenzialmente di convergere e sulla quale finiranno anche con l’accapigliarsi.
Le politiche che questa destra postmoderna si accinge a mettere in atto non incontreranno probabilmente ostacoli insormontabili nei mercati, che trovano sempre il proprio tornaconto, né nell’Europa che già sopporta Orban e il governo polacco, men che meno negli ultimi vapori in cui va dissolvendosi la sinistra. Se vi è qualcuno che finirà col mettersi di traverso saranno proprio quelle soggettività e quelle figure sociali che, ignorate dalla sinistra, hanno permesso l’affermazione del “cattivo nuovo”, ma che dalla sua falsa coscienza difficilmente accetteranno di essere disciplinate.
questo articolo è stato pubblicato sul manifesto del 18 maggio 2018