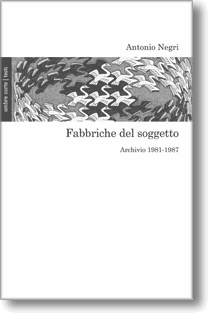di GIROLAMO DE MICHELE.
Nei giorni scorsi, Alberto Asor Rosa ha scritto un breve, ma denso elzeviro sullo stato presente del sistema scolastico, il cui titolo è inequivoco: “La scuola nelle mani dei barbari”.
Dopo aver stigmatizzato nel merito e nelle motivazioni la sperimentazione del “liceo breve” che prende l’avvio in questi giorni – «la riprova che siamo nelle mani dei barbari. Anzi, più esattamente, di barbari incolti» –, ricordato che «la spesa d’investimento nella cultura e nella formazione è drammaticamente sempre più bassa in Italia», e sottolineato come sia incongruo il presupposto che l’accorciamento del percorso scolastico troverebbe giustificazione in un raccordo col mercato del lavoro, Asor Rosa va al cuore del problema, chiedendosi a cosa serve la scuola media superiore.
Dopo anni nei quali prima si ridimensionava la scuola, e poi la si accusava di non riuscire a svolgere il proprio compito – ragione per ulteriori ridimensionamenti punitivi, in un circolo vizioso nel quale non distingui più ministro e governo “di destra” e “di sinistra” – è rinfrescante, quantomeno per la mente, vedere che qualcuno è ancora capace di rimettere il problema sui propri piedi, e questi su un suolo saldo. La risposta di Asor è chiara: «orientare con tutti gli strumenti disciplinari necessari all’esercizio di una professione e/o alla scelta consapevole di una facoltà universitaria; ed egualmente – o forse soprattutto – formare nei giovani una cultura sufficientemente approfondita e consapevole, sia scientifica che umanistica, ripeto, che consenta loro di affrontare in maniera (discretamente) matura i mille problemi della società contemporanea». Da qui la necessità di accendere un faro sullo studio del Novecento, dal momento che «i centoventi anni che ormai ci separano dall’inizio del secolo che convenzionalmente definiamo Novecento non sono ancora entrati a pieno titolo – anzi spesso non sono entrati per niente! – nei programmi scolastici». In una battuta, «il problema va rovesciato rispetto a come viene attualmente posto: invece di diminuire i corsi di un anno, si tratta di far entrare un secolo in più nei programmi», riformulando i programmi in modo da attribuire «all’ultimo anno il compito pressoché esclusivo d’investigare questi ultimi cento anni, decisivi per far capire ai giovani chi siamo e con cosa abbiamo a che fare».
Asor è persona intelligente, anche quando – come in quel libretto sulle due società ch’infiniti addusse lutti a chi si batteva per rovesciare, e non per conservare, lo stato di cose presente – le sue tesi non sono condivisibili. In questo caso, il suo elzeviro ha il merito di porre i problemi – che è cosa fondamentale –, anche se con qualche limite. Diciamo subito che due appaiono evidenti: una conoscenza “dall’esterno” del mondo scolastico, e la sua riduzione di fatto alla sola dimensione liceale (benché le intenzioni appaiano diverse: è l’inconscio, che spesso si manifesta in chi riconduce la scuola alla propria esperienza vissuta), sorvolando sugli specifici problemi dell’istruzione tecnico-professionale.
Ma questi limiti non fanno passare in secondo piano la questione, decisiva, del Novecento: perché, se è vero che in punta di teoria i programmi scolastici già prevedono di dedicare l’ultimo anno al “secolo breve”, è altrettanto vero – Asor è un materialista, anche quando si occupa del solo in apparenza “leggero”, ma in realtà atomista e lucreziano, Calvino – che nei fatti accade che i programmi svolti si arrestino alla seconda guerra mondiale e al solo scenario europeo, e quando si arriva alla fine del secolo e al “resto del mondo”, è dovuto a un fatto soggettivo e volontaristico: bene fa il professore dal nome gentile (il suo retrogrado è il più bel fiore), a prenderne atto. Ma con questa presa d’atto i problemi, invece di chiudersi, si squadernano.
 Partiamo dal concetto di “Novecento”. Secolo breve o lungo? Già questo dilemma non è di facile soluzione – non lo si liquida certo con una battuta, come ha fatto Scalfari nella sua domenicale predica a uso di chi gli si rivolge per farsi spiegare cosa pensare. È indubbio che la caduta del Muro di Berlino (o forse: lo sciopero di Danzica del 1980) sia stata una cesura. È altrettanto indubbio che la governance capitalistica statunitense costituisce un elemento di continuità fra ‘900 e Anni Zero – a maggior ragione, per il vanificarsi, quantomeno finora, delle previsioni di un ciclo economico post-americano. Ma ancora: è parimenti indubbio che questa governance, fattasi globale e finanziarizzatasi, si esprime in forme nuove, ma radicate in processi già avviati negli anni ’70 (fine della parità dollaro-oro – «uno Schopenhauer per l’economia», è stato detto; creazione del petroldollaro per inserire il rublo nel circuito finanziario mondiale, ecc.). Ed è, di nuovo, indubbio che il tentativo di sovradeterminare i flussi economici del capitale – di riterritorializzare sul terreno della politica i flussi deterritorializzati di denaro, merce ed esseri umani – da parte dei governi statunitensi si esprime in forme nuove: nella forma tendenziale dell’Impero, piuttosto che in quella otto-novecentesca dell’imperialismo. La stessa globalizzazione dei flussi finanziari e produttivi, con tutte le conseguenze che comporta, ha le sue radici nella risposta capitalistica alle lotte non solo operaie, ma anche politiche e sociali a partire dalla metà degli anni Settanta – della quale la stessa governance neo-liberale, accompagnata da profondi processi di decostituzionalizzazione, è parte integrante.
Partiamo dal concetto di “Novecento”. Secolo breve o lungo? Già questo dilemma non è di facile soluzione – non lo si liquida certo con una battuta, come ha fatto Scalfari nella sua domenicale predica a uso di chi gli si rivolge per farsi spiegare cosa pensare. È indubbio che la caduta del Muro di Berlino (o forse: lo sciopero di Danzica del 1980) sia stata una cesura. È altrettanto indubbio che la governance capitalistica statunitense costituisce un elemento di continuità fra ‘900 e Anni Zero – a maggior ragione, per il vanificarsi, quantomeno finora, delle previsioni di un ciclo economico post-americano. Ma ancora: è parimenti indubbio che questa governance, fattasi globale e finanziarizzatasi, si esprime in forme nuove, ma radicate in processi già avviati negli anni ’70 (fine della parità dollaro-oro – «uno Schopenhauer per l’economia», è stato detto; creazione del petroldollaro per inserire il rublo nel circuito finanziario mondiale, ecc.). Ed è, di nuovo, indubbio che il tentativo di sovradeterminare i flussi economici del capitale – di riterritorializzare sul terreno della politica i flussi deterritorializzati di denaro, merce ed esseri umani – da parte dei governi statunitensi si esprime in forme nuove: nella forma tendenziale dell’Impero, piuttosto che in quella otto-novecentesca dell’imperialismo. La stessa globalizzazione dei flussi finanziari e produttivi, con tutte le conseguenze che comporta, ha le sue radici nella risposta capitalistica alle lotte non solo operaie, ma anche politiche e sociali a partire dalla metà degli anni Settanta – della quale la stessa governance neo-liberale, accompagnata da profondi processi di decostituzionalizzazione, è parte integrante.
Il Novecento, insomma, mentre finiva, aveva in gestazione il Secolo nuovo; ma come un personaggio beckettiano, non smette di finire, mentre il nuovo si manifesta in forme talmente oscure da non lasciarsi interpretare. Ecco la prima difficoltà: narrare il Novecento richiede una visuale strabica, che spieghi al tempo stesso le continuità e le sue soluzioni fra vecchio e nuovo secolo.
Secondo problema: di cosa parliamo, quando vogliamo parlare del Novecento, per non ricadere nel paradosso borgesiano della mappa dell’imperatore? Appare evidente che alcune questioni sono prevalenti: la migrazione epocale, che coinvolge quasi un terzo dell’umanità; l’irruzione dei processi cognitivi nella produzione delle merci, con una radicale trasformazione del soggetto storico della classe operaia, che non cessa di essere tale pur essendo del tutto differente dalla classe delle tute blu e delle chiavi inglesi di chapliniana memoria; e la correlata finanziarizzazione dell’economia, con la smaterializzazione dei flussi economici che determinano lo stato di crisi permanente nel quale versa l’economia globale più o meno dell’inizio del nuovo secolo (da qualche mese prima dell’11 settembre, vale la pena di precisare); infine, la questione ambientale, che si manifesta ormai nella duplice forma (prefigurata da Gregory Bateson già alla fine degli anni ’60) della catastrofe ambientale, e della crisi dell’ecologia della mente. Esiste una singola disciplina che possa racchiudere questi ambiti? In tutta evidenza, no: non per caso Bateson proponeva un approccio ecologico, ben sapendo che l’ecologia non è una disciplina, ma un insieme di conoscenze e competenze pluridisciplinari. E allora, come lo insegniamo il breve/lungo Novecento, se non con la pluridisciplinarietà?
Ma del resto – lascio in sospeso il quesito precedente – com’è pensabile che una singola disciplina possa affrontare temi e autori del Novecento senza mescolare le acque? È pensabile, per rimanere agli ambiti cari ad Asor Rosa, che la letteratura possa ignorare la straordinaria molteplicità delle produzioni artistiche e intellettuali della modernità (post- o meno che sia)? Per rimanere a un solo autore: è pensabile che si possa studiare Pasolini solo come romanziere e poeta, ignorando la sua semiotica e la sua produzione filmica? Il Nobel a Bob Dylan non ha il significato di abbattere una barriera che persino gli avanguardisti del gruppo 63 cercarono di difendere come la Fortezza Bastiani (chi non ricorda la malcelata soddisfazione di Sanguineti quando Bob Dylan attaccò la spina alla chitarra, e dunque, come si disse – ahi professor Sanguineti, dov’era finito il tuo marxismo – “si vendette al mercato”?)? È pensabile che si possa trattare di letteratura angloamericana – e non solo – ignorando Dylan, Neil Young, Patti Smith, Leonard Cohen? Davvero c’è chi crede che si possa ignorare, in una scuola che insegna il Tasso, la figura e la poetica di Ian Curtis? Che si possa insegnare il linguistic turn in filosofia fingendo di ignorare David Foster Wallace, come un tempo si faceva (e forse si fa ancora) con Dostoevskij e Kafka rispetto a Nietzsche, Freud e Sartre? Che la distinzione (libresca) fra generi comico e tragico possa rimanere, un po’ come le etichette sui barattoli ormai vuoti delle conserve, ignara del cinema di Kusturica e Terry Gilliam, di Gelsomina e Zampanò? Che si possa uscire da un liceo non avendo visto un film di Antonioni, e non avendolo accostato a un quadro di Rothko? Che si possa ignorare, nell’insegnare la complessa rete di narrazioni che costituiscono l’Orlando Furioso, la mutata percezione della complessità narrativa operata nell’immaginario dalle serie televisive, che già a suo tempo ci illustrò Altman nel suo film tratto dai racconti di Carver?
In verità sì, si può: se ci si vuole versare nel mastrocolismo, nel lodolismo, nel citatismo – queste cattive figure dello spirito scolastico che, come in un cattivo infinito, si prolungano e vengono prolungate nel cattivo spirito di insegnanti in cerca di autori consolatori, che aggiornano quel programma gramsciano enunciato nella rubrica “I nipotini di padre Bresciani” (quei “cretini d’Italia”, come Arbasino, quando ancora segnalava l’ora esatta 24/24 e non solo due volte al giorno, propose di chiamarli).
Volendo invece avere il coraggio del sapere: come praticare la pluridisciplinarietà? Ben sapendo che la complessità del Novecento retroagisce sulle classificazioni e le gerarchie precedenti – una fra tutte: non è l’estrema percezione delle questioni del tardo Novecento ad aver spinto Foucault a leggere stoici e cinici in un modo del tutto nuovo, che manda a carte ’48 le polverose sintesi di Hegel e De Ruggero (che tutt’ora la fanno da padrone sui manuali)?
Ma qui il professor Asor Rosa ci lascia senza risposta: nel senso che la sua proposta di puntare tutto sull’aggiornamento dei docenti di buona volontà cade nell’idealismo delle buone intenzioni, che ignora la concreta materialità dei fatti. Le controriforme scolastiche degli Anni Zero si possono riassumere nell’antifrastico slogan gelminiano “meno ore, più approfondimenti”, cui tutti i successori si sono nei fatti inchinati. Ovvero, meno (a volte fino allo zero) ore di storia, diritto, musica, informatica, scienze, materie tecniche e professionali (si entra nel terzo millennio conoscendo l’avantreno meccanico del camion, ma non quello elettronico, per fare un esempio). E le soggettività dell’interazione didattica sono sempre più tarate dalla distruzione del miglior sistema d’istruzione di base, e dalla catastrofe della scuola media (e la materia che più ne risente è probabilmente la storia, che dovrebbe essere il perno dello studio del Novecento).
E qualcosa bisognerebbe pure dire sulla manualistica, che ha conosciuto momenti di grande sperimentazione sul finire del ‘900: per limitarci a un solo esempio, cosa ne è stato di quel gioiello d’interdisciplinarietà che era Il materiale e l’immaginario? Come Cesare in Senato, è stato pugnalato fino a morirne: e alcune delle mani che impugnavano la lama sono quelle dei più reputati critici letterari, che non si sono fatti scrupolo di riproporre il più tradizionale e conservatore schema manualistico-disciplinare – ma questa, direbbe l’indimenticabile Moustache, è un’altra storia (o forse no).
E oggi: meno ore di scuola, più lavoro nero mascherato da alternanza scuola-lavoro, che insegna che il lavoro è un favore che ti viene concesso, e non un diritto (come credeva il povero Fantozzi, prima di incontrare Folagra e Marx). Meno istruzione, più Google.
 Si prenda come caso esemplare il “dibattito”, se così può esser detto, suscitato dallo scellerato decreto-Lorenzin: dove la legittima protesta contro un’idea di medicina che criminalizza il paziente, e reintroduce una distinzione disciplinare sano-malato che era stata superata non si dice da Basaglia, ma addirittura da Xavier Bichat (della quale le scuole sono chiamate a essere gendarmi), e l’altrettanto legittima aspirazione a un’idea di medicina come processo partecipativo di paziente e curante, di accesso alle informazioni e alle ermeneutiche mediche – un una battuta: dall’empowerment, dall’implementazione, dall’aumento della potenza di essere – del “paziente”, è annegata in un oceano di baggianate; di riproposizione di leggende metropolitane; di asserzioni pseudo-scientifiche; di testi citati a sproposito contro il loro stesso contenuto; di teorie del complotto propalate da facilitatori da web abili a saltare come scimmie da una liana all’altra – dal piano Kalergi al complotto giudeo-pluto-bolscevico-palindromo orchestrato da Soros, dal ritorno al sovranismo a concezioni così elementari del capitalismo da far rivoltare nella tomba il povero Adorno. Quale rappresentazione più evidente del pericolo in cui incorre una società nella quale la conoscenza scientifica è sostituita dal googlemento fai-da-te, e la logica, la retorica e la semiotica (in una parola: il lógos) dall’arte di alzare la voce e dar aria alle gengive – spesso, con una buona dose di odio performante on line?
Si prenda come caso esemplare il “dibattito”, se così può esser detto, suscitato dallo scellerato decreto-Lorenzin: dove la legittima protesta contro un’idea di medicina che criminalizza il paziente, e reintroduce una distinzione disciplinare sano-malato che era stata superata non si dice da Basaglia, ma addirittura da Xavier Bichat (della quale le scuole sono chiamate a essere gendarmi), e l’altrettanto legittima aspirazione a un’idea di medicina come processo partecipativo di paziente e curante, di accesso alle informazioni e alle ermeneutiche mediche – un una battuta: dall’empowerment, dall’implementazione, dall’aumento della potenza di essere – del “paziente”, è annegata in un oceano di baggianate; di riproposizione di leggende metropolitane; di asserzioni pseudo-scientifiche; di testi citati a sproposito contro il loro stesso contenuto; di teorie del complotto propalate da facilitatori da web abili a saltare come scimmie da una liana all’altra – dal piano Kalergi al complotto giudeo-pluto-bolscevico-palindromo orchestrato da Soros, dal ritorno al sovranismo a concezioni così elementari del capitalismo da far rivoltare nella tomba il povero Adorno. Quale rappresentazione più evidente del pericolo in cui incorre una società nella quale la conoscenza scientifica è sostituita dal googlemento fai-da-te, e la logica, la retorica e la semiotica (in una parola: il lógos) dall’arte di alzare la voce e dar aria alle gengive – spesso, con una buona dose di odio performante on line?
È del tutto evidente che solo una profonda rivoluzione del sistema-istruzione può dar seguito a quest’abbozzo di cahier de doléances: una rivoluzione che trasformi quel luogo di lavoro nel quale gli insegnanti vagano, ognuno col suo viaggio ognuno perso per i fatti suoi, chiedendosi come tanti piccoli Shylock se il collega accanto non abbia versato una goccia di sangue o un grammo di carne in più per ottenere uno o due ducati in più, in una scuola del comune e per il comune; e su questo punto, come non ricordare con amarezza che Asor Rosa ha partecipato, in qualità di “padre nobile”, a una tavola rotonda sull’unità della sinistra promossa dal manifesto, nella quale non una parola è stata detta sulla scuola?
Ma accanto alle “condizioni di sistema”, è necessario un secondo pilone, in luogo del fragile ed effimero appello all’aggiornamento: quello dell’etica di una scuola militante. Dove per “militante” non si intende, come fanno taluni grunf grunf, il richiamo a una mistica stakanoviana della militanza, ma a quel dovere fondato sul vivere e agire nella verità, producendo verità, liberi da qualsivoglia direttore della coscienza estrinseco: sulla concatenazione fra il Beruf weberiano e la parrhesía stoico-cinica.
Nella società neo-liberale i processi di segmentazione sono uno strumento potente di governance: la disuguaglianza sociale viene messa a valore, e fatta fruttare allo stesso tempo dal capitale neo-liberale, e da quelle forze politiche rozzamente razzistiche e populistiche che si insinuano nelle divisioni fra ultimi e penultimi – fra migranti e working poors, in particolare. Rispetto a questo scenario la scuola è posta davanti a due alternative non eludibili: o diviene strumento di allargamento della disuguaglianza, della segmentazione sociale, dello sfruttamento bestiale dell’uomo sull’uomo; o assume il compito etico di mettersi in mezzo fra i segmenti che la attraversano, per produrre connessione del comune, nella consapevolezza che la contraddizione fondamentale non fra garantiti e non (dove mai ci sono stati garantiti?), ma fra l’1% e il 99% dell’umanità non è aggirabile né ricucibile. Lo scenario delle migrazioni è un caso esemplare: non si possono studiare i flussi di uomini che sfuggono alla morte – non importa se per guerra, terrore o carestia, come vorrebbe l’infame distinzione fra migranti “economici” e “politici” – come fossero movimenti di carrarmatini sulla plancia del Risiko. O ci si fa complici del genocidio dell’ammazziamoli a casa loro, o si ha la consapevolezza che l’alternativa a un mondo diverso è una guerra civile globale, nella quale prima o poi i dannati della terra troveranno il loro Alarico.
Una scuola militante è una scuola di donne e uomini, insegnanti, student@ e genitor@, che non ricercano il consenso o l’agire maggioritario, ma attraversano come militanza etica i campi del sapere, per produrre verità nel comune, con chi è disposto ad agire per il comune e nel vero. Nella consapevolezza che senza rivoluzionare la scuola non è possibile rovesciare questa società dell’ingiustizia. Ma anche: che non può esserci alcuna rivoluzione del sistema d’istruzione senza rovesciare lo stato di cose esistente, coniugando la calma potenza dei bisonti e la selvaggia cavalcata dei dothraki, il candore delle volpi e l’astuzia delle colombe, il calore della comunità operosa e il grande freddo del mondo presente.
Questo è il punto. Ma ars longa, vita brevis: e dunque, all’opera!
nota: il grafico sulle aree semantiche fascioracist social 2017 è tratto dalla pagina Twitter di Christo (@xho) (30 agosto)