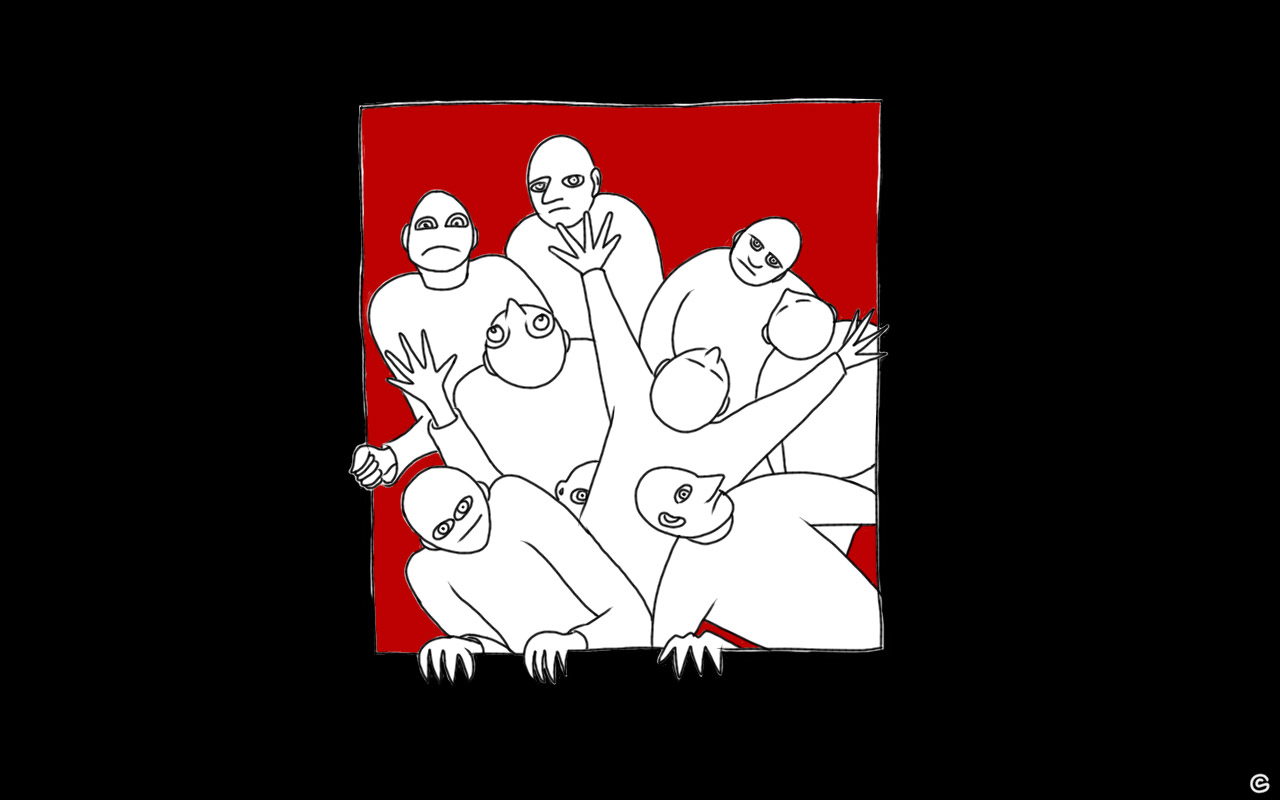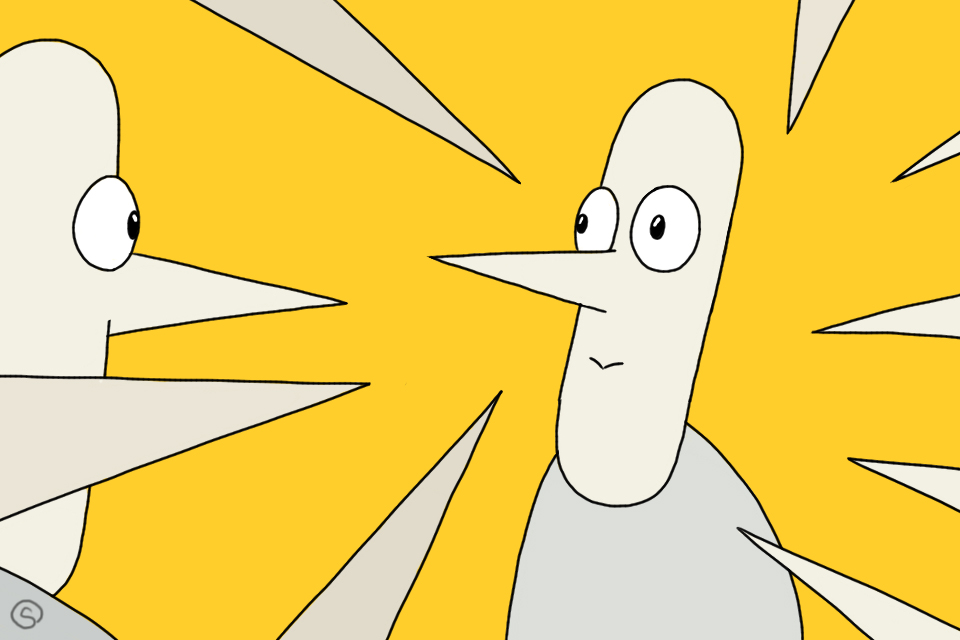di FRANCESCO FESTA.
1. Abbiamo a che fare con un modello di capitalismo a livello europeo, dove le istituzioni politiche si fondano sui principi economici del libero mercato, e dove però il mercato non esiste senza la governance europea: nella fattispecie, senza gli effetti di regolazione della Commissione Europea e di altre agenzie comunitarie. Il mercato è il principio di selezione delle leggi nazionali, ma questo è a sua volta sottoposto alla regolazione della governance europea. La CE agisce da arbitro del mercato in materia di legislazione e come driver dell’espansione e della contrazione dello stesso mercato, realizzando in questo modo una legislazione europea che si impone agli stessi poteri legislativi nazionali, in base agli indici mercantili e finanziari. E tanto dovrà elemosinare l’imbonitore Renzi al banchetto della corte prussiana, poiché poco otterrà, laddove il mercato e la finanza dettano il ritmo mentre la conduzione è a trazione tedesca. Forse riuscirà ad ottenerne qualche eccezione, quel tanto che il sovrano concede ai propri sottoposti. E parimenti, la funzione dell’elettorato, ad onta della riproduzione di figure della crisi quale quella del rappresentato e quella del rappresentante, poco è in grado di cambiare le sorti di un’Europa nata con tale ratio. Di riflesso, quei poteri sempre maggiori che in passato erano conferiti a regioni, province, comuni, municipi, con articolazione sempre più capillare sul territorio, sull’altare delle politiche di austerità – Patto di stabilità e del fiscal compact – che l’imbonitore vorrebbe mitigare, sono sottoposti a un rigido controllo dall’alto, che ne riallinea il comando alle strette decisioni verticistiche della Troika.
L’evidenza della realtà squaderna un ventaglio di domande rispetto a tattica e strategia: alla creazione di uno spazio autonomo dei movimenti, come orizzonte, e allo spazio della tattica come insieme di azioni che si avvantaggiano delle opportunità offerte dall’avversario, azioni in grado di sovvertire i rapporti di forza, producendo quindi pratiche di contropotere sul piano dell’austerity e delle politiche di povertà. Isoliamo alcune domande. Quale azione per l’attività militante nei territori o nelle articolazioni periferiche dell’Eurozona, laddove le politiche locali e nazionali sono effetto del fiscal compact della UE e delle politiche monetarie della BCE/Bundesbank? Come sottrarsi al dispositivo di ri-territorializzazione in modelli stato-nazionali, che prendono piede in diversi campi politici, ove la resistenza nazionalistica è appunto una torsione conservatrice dinanzi alla sfida di un nuovo internazionalismo proletario come rottura di classe della governance neoliberale? E poi: vi è un limite nell’accumulo lineare di conflitti, per quanto radicali essi siano, ma nondimeno estemporanei, che non sono in grado di attivare tanto pratiche di contropotere quanto processi costituenti?
2. Che l’osservazione dell’organizzazione del lavoro umano socialmente necessario alla riproduzione del capitale nello spazio e nel momento del suo maggiore sviluppo sia una prospettiva in grado di intercettare le resistenze e i comportamenti oppositivi all’interno della composizione di classe, è un metodo che varrebbe la pena di estendere anche quando ci si trova dinanzi a ridondanti concetti, discorsi, politiche che insistono su determinate questioni – a ritmo di mantra – quali modernità e progresso o – in base alla vulgata coeva – debito e crescita. Un metodo marxista che consente di capovolgere i vettori, di decostruire la formazione discorsiva e di lasciar implodere quello spazio politico dove si combina la volontà di sapere con il potere istituzionale, al fine di produrre politiche di riproduzione del dominio tanto del capitale quanto delle classi dominanti. Un metodo militante che, nel suo dispiegarsi, ci consegna molteplici forme di sviluppo, e uno spazio eterogeneo ove l’accumulazione capitalistica cattura la ricchezza del lavoro vivo e della cooperazione sociale tramite modalità di vera e propria espropriazione: dunque, cattura di risorse umane, ambientali e comunitarie. In compenso, il sapere nella retorica della solidarietà e dell’assistenzialismo si dispone come ideale contrappunto all’irresponsabilità, alla corruzione, allo sfruttamento del welfare, alla pigrizia nell’investimento nel sé quali cliché del Sud e alle rappresentazioni morali che le stesse popolazioni meridionali hanno ormai fatto proprie, incarnandole nel proprio corpo e nella propria mente come incubi atavici, aspetti consustanziali delle proprie società. Si finisce per prestare attenzione a veri strateghi del giornalismo d’assalto come i vari Travaglio, Saviano, Stella, che da “miglior agenti” del capitalismo finanziario europeo indirizzano il “senso comune” delle succitate popolazioni.
D’altronde si può dimostrare come quei concetti utilizzati come paradigmi per le pratiche di crescita economica, lungi dall’avere una qualche stabilità fondativa, siano il prodotto dello stesso discorso dello sviluppo, della modernità e della costituzione dell’Europa. Questi sono infatti forgiati attraverso meccanismi discorsivi in un atto di violenza del discorso stesso come forma dominante di sapere che cancella i modi alternativi di interpretare e di relazionarsi con la realtà. Insomma non esistono altri modelli se non quelli delle misure di austerità, delle politiche di svalutazione dei salari e di precarizzazione del lavoro. Arturo Escobar ha svelato l’intelaiatura di tali discorsi – nella fattispecie del discorso dello sviluppo – come un sistema di rappresentazione e di potere che “colonizza l’immaginazione”. Allo stesso modo l’antropologo David Graeber è giunto, nella sua interpretazione del fenomeno concreto e del concetto di debito, ad identificarlo per un verso con un concetto accidioso, che costituisce una sorta di educazione sentimentale, definita come “esperienza di confusione morale”, che accomuna le classi subalterne meridionali, legittimando culturalmente e stabilizzando emotivamente un sentimento di auto-disprezzo, che è anche storia assai tarda a morire, anche perché stratificatasi nelle mentalità delle popolazioni meridionali e mediterranee. E prima ancora, come ebbe a mostrare Edward Said, il concetto di alterità è il prodotto egemonico di un pensiero alla ricerca di una propria identità. Per analogia, abbiamo un’Europa che necessita del proprio negativo per riconoscersi; lo stesso costrutto rappresentativo che si serve dell’alterità – del meridione – come concetto rispetto al quale specchiarsi. Avremo un Sud che sarà un Nord “senza”, un’Europa meridionale che sarà un’Europa “senza”. Che questo discorso abbia prodotto il Sud è indubbio, ma in compenso esso ha prodotto anche il Nord, consentendo proprio a quest’ultimo di plasmarsi come centro del governo economico, politico, culturale e giuridico degli spazi periferici dell’Europa. Parimenti lo stesso sviluppo ha prodotto il sottosviluppo come realtà sulla quale agire, mentre il dominio di tale discorso ha impedito di immaginare una diversa realtà per i territori “sottosviluppati”.
In virtù di queste riflessioni tenteremo di interpretare la politica regionale comunitaria dell’UE degli ultimi vent’anni. Articolata in Fondi Strutturali, fu voluta dal Commissario Jacques Delors alla fine degli anni Ottanta con l’intento di dinamizzare la competizione fra le regioni europee. Le regioni svantaggiate dell’Europa meridionale sono state le principali destinatarie dei “Fondi europei per lo sviluppo regionale”; come ha rammentato Ugo Rossi, questi sono stati utilizzati “per sostenere principalmente il circuito secondario del capitale (investimenti nell’ambiente fisico e in infrastrutture) e quello terziario (investimenti nell’economia della conoscenza)”, ma con l’obiettivo di quotarsi nel mosaico di regioni capaci di competere autonomamente nel mercato comune europeo. Dunque, non vi era alcun riequilibrio economico tra regioni ricche e regioni svantaggiate, bensì il mantenimento dello iato per l’iscrizione dell’Europa meridionale nel paradigma sviluppista, introducendola in una transizione improbabile – da economia sottosviluppata a economia sviluppata – poiché viziata è la tempistica dello sviluppo quanto quella del discorso che la sorregge. In realtà il sottosviluppo è servito a dare struttura al discorso, consolidando le tecnologie di governo della Commissione europea nelle articolazioni periferiche dell’UE: quest’ultima ha infatti istituito una vera e propria governance nelle regioni meridionali per mezzo di meccanismi sempre più sofisticati e standardizzati di valutazione dell’azione di governo degli enti locali; di conseguenza, ha formato un ceto locale di amministratori e tecnocrati specializzati – di qualità per lo più mediocre e controllato da una classe politica e intellettuale locale agente per fini clientelari –, garantendo la riproduzione in sede periferica dell’egemonia del discorso “europeista”. Viceversa, la composizione del lavoro vivo nelle regioni meridionali si è scarsamente avvantaggiata di questo processo: ha ricevuto forme di sostegno al reddito – per lo più in strumentazione e apparati infrastrutturali per l’auto-imprenditorialità – ma ben poco in termini di partecipazione attiva o persino di costruzione di una soggettività pienamente europea. In realtà quei Fondi hanno permesso un contenimento della forza lavoro, garantendo una subalternità al discorso egemone, mentre le articolazioni della governance mettevano radici nelle istituzioni periferiche, affermando il loro dominio in uno contesto precario e in movimento. Insomma è la costruzione di quell’Europa post-coloniale situata sul paradigma binario (centro/periferia, sviluppo/sottosviluppo, modernità/arretratezza) che ripercorre corsi e ricorsi della modernità europea, dove le relazioni centro/periferia sono tutt’altro che scontate e vanno continuamente affermate in uno scenario instabile.
Per concludere, il ventennio trascorso di politica regionale enuclea appunto quelle che Balibar definisce le “determinazioni costitutive della cittadinanza”, vale a dire quei discrimini di una “frontiera” che funziona da territorializzazione, appartenenza, protezione della comunità, quindi di “esclusione interna” o – per dirla foucaultianamente – degli “spazi altri, eterotopie che vengono a disturbare l’omogeneità dello spazio comunitario”. Ecco, la politica regionale ha ricoperto la funzione di istituire e di organizzare tramite enti e amministrazioni periferiche l’estrazione di plusvalore della cooperazione sociale nelle regioni meridionali e, allo stesso modo, di fondare una cittadinanza neoliberale, che per mezzo di misure reddituali ha riprodotto tanto il discorso del “meridionalismo classico”, quanto il dispositivo della subalternità ai ceti politici locali.
3. Rispetto ai precedenti governi, il governo Renzi-Padoan si è fin qui contraddistinto per aver stroncato un ceppo della mente, cancellando la retorica di quei ministeri che traggono profitto dal presupposto della povertà endemica del Sud e dalla necessità dell’intervento pubblico esterno. Si badi, dicasteri per il Mezzogiorno ricoperti da quel ceto politico meridionale di cui Gramsci ha tracciato il profilo, che non è per nulla cambiato: “Abito di ipocrisia raffinata e una raffinatissima arte di ingannare e addomesticare le masse contadine, il suo unico scopo è di conservare lo statu quo. Nel suo interno non esiste nessuna luce intellettuale, nessun programma, nessuna spinta a miglioramenti e progressi”. Questo ceto ha sempre reclamato, quasi fosse un rito propiziatorio, che sia ogni anno confermata ufficialmente la condizione di povertà per le regioni meridionali, perché è proprio la povertà la “gallina dalle uova d’oro” che dà loro da vivere, tanto dal punto di vista della retorica quanto da quella dell’ascesa sociale.
Al momento, il famoso Jobs Act non fa alcun riferimento ai “mali oscuri” delle regioni meridionali. Ma, nondimeno, la prima sortita pubblica dell’imbonitore Renzi è stata la Sicilia, a conferma che nel sud si annida il consenso e si produce il “senso comune”, che tanto incide in quella dimensione evanescente eppur determinante che è l’ “opinione pubblica”; del resto, la prima uscita di Papa Francesco, che ne capisce un po’ di marketing e senso comune, è avvenuta appunto in un luogo simbolo dell’Europa e del Mediterraneo, l’Isola di Lampedusa. Altro dato della sortita renziana: le regioni meridionali sono luoghi da anestetizzare, nei quali calmierare le tensioni, neutralizzando la polveriera che cova sotto i dati su disoccupazione, povertà, qualità della vita, lavoro nero e giovani Neet nell’attuale fase recessiva, indici che fanno ben sperare da questa parte della barricata, mentre dall’altra parte fanno tremare i polsi.
Va da sé che i mille euro in più all’anno (80 euro netti al mese) per chi guadagna meno di 25 mila euro con un contratto di lavoro stabile non modificheranno la redistribuzione della ricchezza, né agevoleranno ulteriori assunzioni, ma più grave ancora è l’effetto di incentivazione al lavoro nero, sottopagato, ricattato, se non addirittura la diffusione di “lavoretti” che troveranno più vantaggioso l’anonimato rispetto alla visibilità dinanzi al fisco statale. Dopotutto, quale vantaggio avrebbe un proletario a far riconoscere il proprio lavoro dallo Stato laddove la parabola della sua vita sia contrassegnata da lavori precari e indecenti, dal bisogno di lavoro senza soluzione di continuità? A questo punto non è assai più vantaggioso restare nell’illegalità e trattenere qualche margine di euro in più piuttosto che destinarlo al fisco? E ancora: al di là della natura lavorista, a chi gioverà la Naspi (il sussidio di lavoro selettivo), applicabile ad ex lavoratori con contratto? Nelle regioni meridionali, quanti potranno accedervi grazie a un precedente “lavoro regolare con un contratto”?
Il divario della cittadinanza europea è riflesso e baricentro della lotta di classe: da una parte, il “club” dove agire una cittadinanza a misura neoliberale; dall’altra, gli esclusi, i poveri e i subalterni cui verrà via via sottratto il terreno dei diritti e del welfare, anche solo di quelle forme dal palese contenuto filantropico per contenere il tasso di povertà e i fenomeni negativi ad esso connessi. Una tendenza nell’Europa è quella descritta da Partha Chatterjee in merito al concetto di cittadinanza liberale, vale a dire la presenza di due insiemi di relazioni concettuali: la “società civile”, lo spazio di chi ha accesso ai diritti di cittadinanza e può esercitarne i poteri; la “società politica”, lo spazio degli esclusi ma anche lo spazio del conflitto e della negoziazione, della produzione di soggettività e dell’azione dei subalterni. E tuttavia quest’ultima porzione di società deve essere oggetto di politiche di sicurezza, altrimenti il rischio dell’autonomia della subalternità diventerebbe un costo troppo alto per la governance europea. La richiesta di sforare di qualche decimale la soglia del 3% (deficit/PIL), tanto elemosinata da Renzi, mira proprio a rilanciare il discorso dello sviluppo nelle regioni svantaggiate, a patto che queste vengano mantenute in uno stato di subalternità; il che probabilmente sarà concesso dalla BCE/Bundesbank poiché ipotizziamo che lo stato di subalternità richiesto dalla Germania è quella condizione di generale precarizzazione, anzitutto in termini di abbassamento salariale nei paesi periferici dell’Eurozona, come contropartita del minor rigore dei vincoli se non addirittura di una rivisitazione degli stessi; in questo modo il mercato europeo potrebbe garantire una propria omogeneità a fronte del rischio di delocalizzazione nei mercati dell’Europa dell’Est.
4. La crisi è uno stato normale della politica e dell’economia, grazie al quale il paradigma neoliberale si rimodula all’interno dei singoli paesi per riformare gli stati e i soggetti, tanto le azioni pubbliche quanto le condotte private, in base al dispositivo della razionalità e dell’individualismo imprenditoriali. Ma è indispensabile neutralizzare o abolire preventivamente l’antagonismo sociopolitico. Da parte nostra, vale la pena di recuperare quel “materialismo geografico” attraverso il quale leggere le dinamiche che la nuova fase della governance europea andrà inaugurando: una prossima stagione di riforma dell’accumulazione interna, alimentata dall’evocata ripresa, che avrà come vettore la riapertura di arsenali di neo-industrialismo e neo-sviluppismo per le regioni meridionali.
In questo modo si chiuderebbe l’opera inaugurata da (re) Giorgio Napolitano. Si badi che egli è l’ultimo epigono della tradizione meridionalistica della scuola togliattiana, che sul decollo industriale abortito, diagnosticato come male oscuro della questione meridionale, ha finito col costituirsi come la principale sorgente che produce e riproduce la stessa questione e che richiede l’intervento del capitale industriale. Napolitano ha esercitato a livello nazionale un ruolo indispensabile nel dispiegamento di quella “rivoluzione passiva” delle élite politiche e delle lobby finanziarie europee: in altri termini, ha prodotto un dispositivo politico e culturale in grado di dare una “forma eccezionale” allo “Stato capitalistico che, diversamente dal fascismo classico, ha lasciato al loro posto la maggior parte delle istituzioni rappresentative formali, e allo stesso tempo è stato capace di creare intorno a sé un attivo consenso popolare”. Questa citazione è da Stuart Hall, Il grande spettacolo dello spostamento a destra del 1979, un saggio dal titolo evocativo, pensato e costruito come reazione al disfacimento di un compromesso storico tra capitale e lavoro che in Inghilterra, dagli anni Quaranta in poi, era stato tacitamente accettato da tutti i governi, tanto di sinistra quanto di destra. Mutatis mutandis, re Giorgio pare abbia, da una parte, blindato il patto tra lo Stato e la Troika e, dall’altra, reso stabile il paradigma eccezionale dell’accumulazione capitalistica tramite la ripresa di una retorica sviluppista (per il momento solo evocata!) a favore delle regioni meridionali, e la precarizzazione del lavoro (lavoro indecente, sottopagato e senza diritti) nei termini dell’impossibilità di recedere dalla condizione precaria perché sottoposti al ricatto del bisogno e per l’alto costo della ricerca di un lavoro stabile. E poi, vale la pena di ribadirlo, nelle regioni meridionali alla precarietà va aggiunta la trappola del lavoro nero: per la precisione, la precarietà è la misura del ricatto del bisogno di lavoro, mentre il lavoro nero è una condizione fisiologica, alimentata dai vantaggi che offre al proletario.
5. Se è valido il metodo del situarsi là dove il capitale intensifica i processi di accumulazione, seppur in regime finanziario, allora giocoforza il campo di lotta non può che essere quello dei territori situati in uno spazio europeo. La sfida però è diversa e ambiziosa: si tratta di “divenire-europei”, nel senso di immaginarsi i nostri territori in divenire dentro e fuori, in modo da rafforzare le lotte sulla casa, sul reddito, sulla salute, sull’ambiente. Significa riprendere e aggiornare l’internazionalismo proletario attraverso il quale tradurre dai territori al campo di battaglia trans-nazionale le lotte autonome e le parole d’ordine. Significa anche avviare un processo di trasformazione delle nostre forme di militanza in una dimensione internazionalista. Per dirla con Sandro Chignola: “significa decentrarci dalla norma per la quale siamo militant* italian*, di un certo territorio, di una certa tendenza, deterritorializzare la nostra posizione e le nostre battaglie, agire come una macchina da guerra in grado di risignificare continuamente i nostri territori e quindi lo spazio europeo.” E ancora: “si tratta di produrre contropoteri fissati in una territorialità altra: non semplicemente trans-nazionale, ma effettivamente debordante i confini e le identità, radicata nella materialità delle lotte e del comune, contrapposta, come incitamento costante e come limite invalicabile per esso, al potere della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale.” A ciò vale aggiungere, però, che il “divenire europei” ha da sbaragliare una zavorra dei movimenti: la miseria della rappresentanza politica e l’affare elettorale, sia interno che esterno, tanto per i movimenti che per coloro che ne scelgono la strada. Sia chiaro: nell’Europa costruita sulla razionalità neoliberale non vi è spazio per qualsiasi concezione di democrazia che non sia quella sottoposta all’ordine della concorrenza e dell’individualismo; e tuttavia, immaginare di invertire la rotta tornando nell’alveo stato-nazionalistico, è soltanto una direzione reazionaria. Sia l’una che l’altra sono opzioni che ci farebbero precipitare in quella notte in cui tutte le vacche sono nere trascurando le origini ordoliberali della costruzione europea e, quindi, l’irraggiungibilità di alcuna modifica che sia in senso neo-keynesiano quando non di controllo degli apparati finanziari ed economici. In compenso, “divenire europei” significa incalzare gli organi della governance a livello locale, quanto a livello europeo, far sì che le classi dominanti e le lobby finanziarie paghino gli effetti della crisi.
Superando quel rimorso insito nella subalternità, per il quale la sua azione è riflesso delle politiche delle classi dominanti, occorre produrre azioni autonome e lanciare processi politici capaci di modificare i rapporti di potere nella composizione del lavoro vivo; significa agire sul piano dell’egemonia e del consenso, piano su cui il capitale agisce il proprio dominio, curvandone i rapporti di potere. Le lotte per il diritto all’abitare, al reddito, in difesa del lavoro, contro la disoccupazione e la povertà, le reti sorte contro l’estrazione di plusvalore dall’ambiente e le pratiche di riappropriazione hanno prodotto delle dinamiche in controtendenza e ricompositive. Nei grandi appuntamenti italiani, in particolare la manifestazione del 19 ottobre 2013, si è respirata un’aria che prelude ad una consapevolezza nel mantenere ferma la bussola sull’autonomia, praticando percorsi ricompositivi, nel tentativo di inventare nuove istituzioni che obbediscano ad altre logiche, effettivamente quelle che attraversano le pratiche di riappropriazione: autonomia, democrazia diretta e vita in comune. In tal senso, lascia ben sperare la giornata di mobilitazione in Spagna del 22 marzo 2014 convocata col nome di “Marcia per la dignità”, che ha riscosso una partecipazione altissima portando in piazza a Madrid una composizione sociale variegata intorno a una programma comune e molto radicale: contro le ricette neoliberali della Troika, le politiche di austerità del governo Rajoy e dei suoi predecessori; per il reddito garantito, la difesa del lavoro, la gratuità dei servizi pubblici, dell’università e della sanità. Un programma che potrebbe divenire terreno di lotta comune dei movimenti europei, rintracciandovi dei primi segnali di ricomposizione di un precariato europeo.
Vale la pena, qui, di buttare lo sguardo oltre questi tentativi, anche in vista dei prossimi appuntamenti nazionali ed europei: scommettere sulla costruzione di percorsi che connettano le lotte per il welfare e quelle per il lavoro, e che facciano dell’azione nei luoghi un’interfaccia della più ampia lotta contro le istituzioni finanziarie europee, dalla BCE alle misure territoriali di fiscal compact e spending review. Un fattore generalizzante in grado di contenere le divisioni e le forme di gerarchizzazione è quello del reddito d’esistenza, una misura che deve diventare terreno di conflitto della cooperazione dei movimenti europei come contrasto alla disoccupazione di massa, affiancato al sostegno salariale per contrastare le forme di ricatto e la diffusione del lavoro nero. Le esperienze di scrittura della “Carta per l’Europa” e della “Carta di Lampedusa” sono da immergere in questi percorsi per riportarne la sintesi in una dimensione trans-nazionale; esse interpretano quella capacità di sperimentazione di istituzioni autonome in cui immaginare e costruire nuove forme di internazionalismo proletario.
Tutto ciò a patto che rimanga centrale dell’azione politica il rapporto tra subordinazione e autonomia. Gramsci ha rilevato che le classi subalterne sono soggette all’attività dei gruppi dominanti, anche quando si ribellano e insorgono. Quindi, com’è possibile produrre una politica autonoma dei subalterni? E dov’è il discrimine tra una condizione di subordinazione ed eterodirezione e una di autonomia e di azione politica? Rispondere a questa domanda vuol dire, innanzitutto, rompere quella condizione di assuefazione alla rappresentanza politica, all’incapacità di immaginare un’azione politica autonoma e all’interiorizzazione della subalternità. Il che si traduce nel riporre il nuovo in una nuda ripetizione che riduce la differenza e la rottura alla copia del già noto e alla somiglianza.