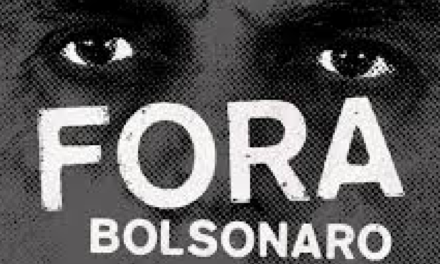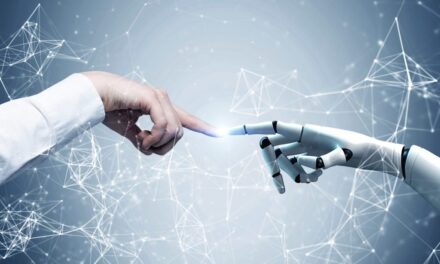di MARCO CODEBÒ.
Sergio Marchionne, il defunto amministratore delegato della Fiat Chrysler, si svegliava alle 3 e mezza del mattino e andava a letto alle dieci di sera. Negli ultimi dieci anni, ha scritto Mario Calabresi su Repubblica, si è preso un solo fine settimana di vacanza. Quanto ha lavorato in tutto? Provo a immaginare: le 22 meno le 3 e mezza fanno 18 ore e mezza. Togliendo i pasti, un minimo di tempo per gli affetti e una doccia (non per andare in bagno nell’altro senso perché stando seduto poteva smanettare su tastiere varie, ricevere rapporti e mandare email), facciamo una novantina di minuti in tutto, restano sedici ore. Se adesso moltiplichiamo questa cifra per 365 (i giorni in un anno solare) e poi per 10 (gli anni) vengono fuori 58.400 ore. Anche sottraendo, per amor di precisione, le 48 ore del suo unico fine settimana di vacanza la cifra rimane ragguardevole: 58.352. Un suo dipendente che lavorasse 40 anni, a 40 ore la settimana per 48 settimane all’anno (52 meno 4 di ferie), metterebbe insieme 76.800 ore: ai suoi ritmi, Marchionne se le sarebbe mangiate all’incirca in tredici anni.
Nell’ultima settimana ho cercato invano qualcuno (giornalista, comico o influencer) che a mezzo stampa, rete o TV dicesse che chi fa una vita così è pazzo furioso, visto che il rispetto per i morti impedisce di dire che era scemo completo. L’elenco di quel che si perde in un’esistenza del genere strappa il cuore: tempo coi figli, eros, gite in montagna, pisolini pomeridiani, leggere romanzi e fumetti. In pratica ogni gioia. E quanti veleni, tabacco, caffè, medicamenti vari, acidi da cattive digestioni, deve essersi inoculato uno così per arrivare ogni volta a fine giornata! Senza contare i danni che uno stile di vita simile, di quel volare avanti e indietro sopra l’Atlantico per poi saltare in macchina sempre assistiti da una nuvola di computer accesi notte e giorno, causa all’ambiente in termini di inquinamento e vaporizzazione di energia. Davvero, roba da matti.
Tutto giusto se non fosse che il Marchionne che ci crediamo di conoscere – nome proprio Sergio, nato il 27 giugno 1952 a Chieti da Concezio e Maria Zuccon, professione manager industriale – non è responsabile di tutto questo. Quello che noi chiamiamo Marchionne e che ha compiuto le gesta di cui sopra non è un individuo registrato all’anagrafe ma un collettivo (prendo a prestito questo termine da un saggio di Michel Callon e John Law [Agency and the Hybrid Collectif] del 1995). Per vedere come funziona dobbiamo immaginarci due cerchi affiancati, più o meno come in un paio di occhiali a lenti tonde, uniti da un ponticello. Il ponticello è lui, il tizio col maglione. Il primo cerchio è quello della sussistenza: cuochi/e, domestici/domestiche, sarti/e, autisti/e, personale medico, piloti, assistenti di volo, maggiordomi e governanti. Il secondo è quello delle macchine: computer, tablet, cellulari, software, modem, rete elettrica, schermi vari, microfoni e auricolari. Innestati su queste macchine, in posizioni e con responsabilità diverse, si trovano altri esseri umani, alcuni dei quali conoscono il tizio col maglione, altri sanno chi è ma non l’hanno mai visto e altri ancora non hanno la minima idea di chi sia né di lavorare con lui. La somma di tutti gli attori, umani e non, compresi nei due cerchi, più il signore col maglione, forma il collettivo Marchionne.
L’uomo dentro il maglione da una parte schiavizza, ma non troppo perché è un bravo cristo che è stato emigrante, il personale addetto alla sussistenza e dall’altra traduce in linguaggio comprensibile agli umani i dati che gli arrivano dal circolo macchinico. In realtà passa il tempo a rincorrere le macchine. Terminale del possente collettivo Marchionne, l’uomo immaglionato conduce una vita 24/7, altra idea che prendo in prestito, questa volta dall’omonimo libro di Jonathan Crary del 2013 [24/7. Il capitalismo all’assalto del sonno]. Vivere una vita 24/7 vuol dire non smettere mai di lavorare. Sotto la pressione degli algoritmi alla guida delle macchine in cui si trova incistato, colui che vive 24/7 vede il comando capitalista invadergli tutti gli spazi che una volta erano risparmiati dal dovere della prestazione lavorativa: riposo, sonno, vecchiaia. Non può nemmeno morire, nel senso di prendersi il tempo necessario per accomiatarsi dalla vita; gli è solo permesso di finire di vivere, cioè di lavorare.
Il punto è che lo stile di vita 24/7 è, tendenzialmente, quello di tutti noi. Fatto coerente con lo spirito del capitalismo, che da una parte colonizza ogni spazio del globo terrestre, mentre dall’altra fagocita qualsiasi frazione di tempo, sia nell’arco della giornata sia nella parabola dell’esistenza, che gli umani cerchino di proteggere dal lavoro. A passare il tempo a rispondere a email lavorative, leggere o compilare tabelle di dati, infilarsi in videoconferenze, manipolare e gestire dati online non sono solo i supermanager ma un enorme numero di prestatori d’opera, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi. Ma questo non è tutto. Oggi la materia prima di cui il capitale di punta ha fame sono i dati. I cosiddetti GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) sono imprese dedite alla manipolazione di dati; che tutti noi produciamo andando in rete a fare acquisti, incontrare amici, prenotare stanze d’affitto o leggere giornali. E tutto questo, sia dal punto di vista della nostra attività vera e propria sia da quello delle sollecitazioni che ci arrivano dalla rete, non conosce sosta. Non esiste più un momento della giornata in cui non sia possibile (o non si debba?) comprare, vendere, fare o subire pubblicità, ricevere o inviare messaggi. Poiché essere coinvolti in ognuna di queste operazioni significa produrre dati, cioè preziosa materia prima, in pratica nessuno smette mai di lavorare. Marchionne insomma è uno di noi e per questo nessuno ha scritto che era scemo.
Se stiamo tutti morendo di lavoro, però, qual è la differenza fra Marchionne e gli altri, ovvero tutti quelli che, a parte un’élite di supermanager come lui, pur vivendo anche loro 24/7 (ma senza i suoi colpevoli eccessi) godono di redditi incomparabilmente inferiori al suo? Detto con meno giri di parole: se togliamo di mezzo i soldi, dove sta la differenza fra Marchionne e gli altri? Se più o meno tutti procediamo sotto comando algoritmico, in che cosa il lavoro di Marchionne è diverso da quello del resto del mondo? La differenza, credo, stia nella capacità di Marchionne di esercitare agenzia (orribile traduzione letterale dall’inglese agency), cioè di essere un agente e non un paziente, di agire e non di subire durante le varie operazioni in cui era coinvolto il suo collettivo. Tutto questo sempre, sia chiaro, all’interno di una situazione in cui agenti sono, ed eccome se lo sono, anche le macchine. Il Marchionne degli anni Cinquanta, Valletta, che lavorava di carta, penna, Olivetti e calcolatrice, godeva certo di maggiori spazi nell’esercizio della sua agenzia. Comunque è questo, l’agenzia, che dovrebbe essere, mi sembra, il fattore discriminante. Scendendo da Marchionne in giù lungo la scala del comando, di agenzia ce n’è sempre di meno. E l’agenzia, in fondo, è la vera ricompensa. Era in questo che Marchionne stava assolutamente in cima al mondo. Più in alto anche dei proprietari per cui lavorava e che, in un certo senso, lo sfruttavano. Il valore totale delle possessioni (il net worth) di John Elkann, che sicuramente per la Fiat ha fatto ben poco in confronto a Marchionne, è di 850 milioni di dollari. Quello di suo fratello Lapo, che ha combinato solo danni, è di 800. Quello di Marchionne 80.
La forza dell’insano stile di vita di Marchionne è di essere inattaccabile; per lo meno con le armi che ci ha lasciato il Novecento. Con che faccia uno gli avrebbe potuto dire “se otto ore ti sembra poche prova tu a lavorar”? Forte è il rischio che Marchionne, o uno dei quelli come lui alla testa delle grandi imprese, possa saltare su a dire “se otto ore vi sembran tante provate voi a lavorar”. Però sappiamo che questo modello è nefasto: desertifica la vita di chi lo pratica, divora il pianeta, riduce le esistenze dei senza agenzia a traiettorie prive di senso. E il primo a portarne le conseguenze, sul proprio corpo, a cui è negato persino il diritto di morire, è proprio lui, l’agente per eccellenza nel collettivo del comando. Una vita così non ha senso: questo è l’unico argomento anti-Marchionne che funzioni, almeno il solo a sembrarmi ragionevole vista la stanchezza di quelli basati su giustizia e uguaglianza.
Nel 1973, mi sembra verso febbraio, era l’una di notte in piazza De Ferrari, a Genova. Aspettavamo la prima uscita del giornale. Viene fuori con un titolo che sembrava l’avesse scritto Spriano: “La Mirafiori è bloccata”. Pronti via, il giorno dopo saliamo a Torino. Eravamo in due, naturalmente su una Fiat, una 500. Di quel viaggio ricordo una mezzaluna di pagnotta ripiena di frittata che comprammo da un commestibili vicino a Corso Traiano e poi la fabbrica occupata. C’era una fila di operai, come a una ventina metri uno dall’altro, tutti capelloni con fascia rossa stretta all’altezza della fronte, a cavalcioni del muro di cinta. Poi sul prato interno una furiosa partita di pallone, giocata con buona tecnica undici contro undici. Nessuno dei militanti fuori dai cancelli ci capiva niente. Per quel che so, da quell’occupazione non è venuto fuori nulla in termini di manifesti, proclami o piattaforme. Solo quel possesso della recinzione e la voglia di giocare a pallone.
A quell’epoca l’immagine pubblica della Fiat la rappresentava Gianni Agnelli, l’avvocato. Manager non lo era di certo. Ma se ne capiva di calcio ed era un gran viveur, con una faccia da vizioso, abbronzata in modo perenne. A metà giornata si faceva portare in elicottero al Sestriere per un’oretta di sci. Aveva un appartamento a New York, ma non ci andava certo per progettare fusioni aziendali.
Non avrei mai pensato di rivalutare Agnelli, il primo nemico politico della mia vita. Ma il suo modello (di vita e agenzia) mi sembra meno dannoso, e più battibile, di quello che ci lascia Marchionne.