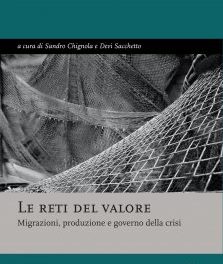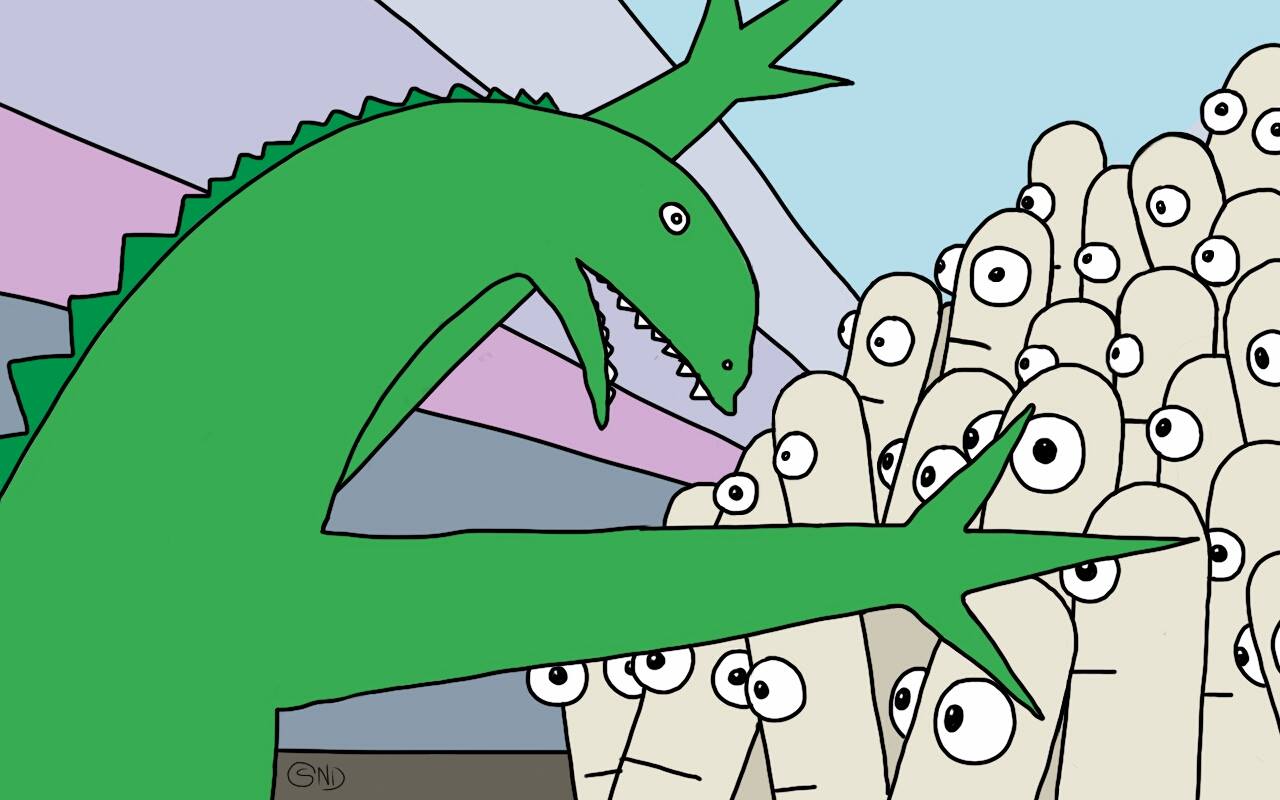di GISO AMENDOLA, GIROLAMO DE MICHELE, FRANCESCO FESTA.
No, non avevamo bisogno di origliare le intercettazioni diffuse dal “Fatto Quotidiano”. Il gioco del cosa c’è dietro, della spiata indiscreta, del “guarda cosa si dicono in privato” non è per niente attraente, e non solo per una nostra convinta e radicata repulsione per i metodi inquisitori e per le posture da pubblici ministeri. Né per una questione di stile (per quanto le questioni di stile non siano questioni da poco). Ma perché l’attenzione al nascosto, all’intimo, al chiacchiericcio è essa stessa un dispositivo, piuttosto potente, per neutralizzare i conflitti, per produrre opinione pubblica tanto risentita quanto impotente, piuttosto che movimenti capaci realmente di far male. Non ci sembra casuale che, potendo pescare nella scatola delle notizie precotte e surgelate, nessuno abbia speso due parole di approfondimento sulla figura dello scattante felino, ancorché factotum di padron Riva: che, oltre a consegnare buste contenenti, secondo gli inquirenti, mazzette, commissionava paginate di pubblicità ILVA “legali” su tutte le testate locali (ad eccezione di due, una cartacea e una on line) per condizionarne la linea editoriale; che qualche volta è intervenuto col nickname di Angelo Battista, senza che alcuno ne avesse sentore. Giusto per chiarire come funzionava il sistema-ILVA, fino a che punto arrivasse a condizionare lo spazio pubblico della discussione, e di cosa si facesse finta di nulla a qualsivoglia livello politico e sindacale.
Perciò non meraviglia che l’operazione del “Fatto Quotidiano” produca ora una catena di discussioni torbide, che trattano la parabola di Nichi Vendola come una faccenda di immoralità personali, di mancanze caratteriali, di connaturati servilismi. Tutto questo interessa poco, se non come ulteriore specchio della corruzione generalizzata della nostra “sfera pubblica”: corruzione non “morale”, non patologica, ma sempre più evidentemente costitutiva di quella stessa sfera. A meno di non voler credere alla favola populista della corruzione come anomalia, come espressione di malanimo morale, e non come strumento di estrazione della ricchezza sociale. Ma, una volta proclamato l’assoluto disinteresse per le strategie delle truppe di Travaglio e di tutti quelli che hanno un qualche interesse a buttarla in caciara, non per questo possiamo dichiarare chiusa la questione. Perché non c’è garantismo che possa eludere l’infamia che emerge dalle vicende dell’Ilva: un’infamia tutta politica, e proprio per questo, e senza nessuna concessione al moralismo, un’infamia pienamente e duramente etica. E che non chiama in causa né solo la parabola di Vendola, né quella del suo partitino: ma è intessuta di scelte di campo, di blocchi culturali e politici, di incapacità radicate che coinvolgono il modo d’essere dell’intera sinistra. Che non a caso nel Sud conosce il suo più fragoroso e rovinoso fallimento; ed è ulteriore conferma dell’avvertimento gramsciano sulla funzione della “classe intellettuale meridionale”, quale “miglior agente del capitalismo industriale italiano”, ovvero amministratore del potere locale e formatore dell’“opinione pubblica” a tutto vantaggio del discorso della “classe industriale”.
E allora fuori dalle retoriche neutralizzanti dello scandalismo e delle simmetriche e altrettanto improvvise passioni “garantistiche”, sarà bene ribadire i tratti fondamentali di questo fallimento. Quelli evidenti, quelli per cui non avevamo bisogno di sbirciare dal buco della serratura, perché già dispiegati e fatti emergere dalle inchieste aperte nei territori, e nutriti dalle lotte reali che li hanno attraversati. Appare, s’è detto, l’immagine di un potere completamente “a disposizione” del padrone, che ha la necessità di ribadire la propria presenza, di dissipare anche il minimo dubbio che possa essersi, anche se per un solo attimo, “defilato”. Un potere che deve riaffermare continuamente il proprio essere impegnato nella sua opera di mediazione, anche quando mediare significa solo rimuovere gli ostacoli dalla ripresa del cammino del padrone, quando l’opera di mediazione del potere non può che significare “favorire gli investimenti” di quel padrone.
Sarà bene ricordare che il biennio 2009-2010, nel quale Vendola assurge a stella politica di prima grandezza e assume un altrimenti impensabile status di referente politico, o comunque di interlocutore bipartisan, è il biennio in cui viene scritta e varata negli uffici del ministro Prestigiacomo (era il 19 febbraio 2009), con l’assenso e la firma di padron Riva e dei dirigenti nazionali dei sindacati dei metalmeccanici, una “legge di interpretazione autentica” della legge regionale sulle emissioni inquinanti varata da appena tre mesi – la famigerata legge regionale 8/2009 – che consente, grazie al combinato delle medie aritmetiche, dei monitoraggi non più “di continuo” ma in tre soli fasi annuali, della “sottrazione dell’incertezza pari al 35 per cento per ciascuna unità di misura”, di millantare una inesistente riduzione delle emissioni; degli interventi sull’ARPA, che testardamente continuava a rilevare dati che avrebbero messo a rischio l’attività dell’ILVA; della rivendicata (e condotta a buon fine) opposizione di Vendola al referendum consultivo sulla chiusura dell’ILVA; dei rapporti preferenziali con il gruppo Marcegaglia, la cui presidente poteva dichiarare, alla presenza di Vendola e Riva: «Se le imprese perseguissero solo ed esclusivamente i criteri ambientali sparirebbero nel giro di poco tempo, ma soprattutto resterebbero aziende che non fanno il loro mestiere. Ecco perché all’Ilva va riconosciuto il merito di aver saputo coniugare ambiente e competitività. Il referendum è una follia». Era l’epoca in cui Vendola si rivolgeva così a padron Riva (era il 23 novembre 2010): «Chiesi ad Emilio Riva, nel mio primo incontro con lui, se fosse credente, perché al centro della nostra conversazione ci sarebbe stato il diritto alla vita. Credo che dalla durezza di quei primi incontri sia nata la stima reciproca che c’è oggi. La stessa che mi ha fatto scendere in campo contro il referendum per la chiusura del ‘polmone produttivo’ della Puglia» – e dietro questa comunanza di valori cristiani tra il padrone e il “governatore rosso” come non pensare all’inno cristiano per eccellenza, quella Pentecoste nel quale la Chiesa “spira de’ nostri bamboli / nell’ineffabil riso”? Ed era l’epoca nella quale il gruppo Riva aveva, con i suoi danari sporchi di sangue e diossina, fatto ingresso nel salotto buono dell’Alitalia assieme ai vari Ligresti, Passera, Benetton, Colaninno, Tronchetti Provera, Angelucci.
Ma questo singolare mix di impotenza e di arroganza, di “non temete, potete contare su di me” e di “non potete prescindere da me, solo attraverso me vi salverete”, non è altro che lo specchio della crisi di rappresentanza radicale di poteri “pubblici” che non sono più che nodi di connessione, anche piuttosto deboli e occasionali, tra flussi finanziari, territori, forme delle cooperazione sociale da captare, precarizzare, ricondurre ai ritmi e alle necessità dell’accumulazione. I movimenti sociali hanno in tutt’Europa registrato la crisi radicale degli spazi democratici e la necessità di reinvenzione radicale di spazi di decisione comuni, contro la corruzione endemica e strutturale della governance. La vera arroganza è consistita nel credere ancora mediabile quello che non poteva essere più né mediato né attraversato: tentare di attraversare la governance più o meno da “sinistra”, magari tentando la fragile carta di qualche tentativo di cooptazione di pezzi dei movimenti sociali, porta esattamente all’arroganza impotente di chi non può che farsi parte della fisiologica corruzione. E quando l’azione del potere giudiziario, che può espandere e allargare crepe nelle rappresentanze, ma che è ovviamente impotente a trovar vie di uscita alla crisi, ti mette comunque davanti all’evidenza dell’incepparsi dei meccanismi consolidati di compromesso, non puoi che ridurre l’arte di governo all’arte del buon telefonare e del proporti come amico fidato tra conoscenti di vecchia data: per una sinistra che non sa nulla della radicalità della crisi della rappresentanza, la corruzione è un esito obbligato. Inutile quindi stracciarsi più di tanto le vesti per una telefonata in cui non si capisce Vendola da che parte stia: sta dalla parte di un potere che non ha scelta, che non può far altro che lubrificare più o meno amichevolmente tutti i canali possibili di un governo che è ormai separato da tutti i classici canali di legittimazione, e che sa di avere sempre meno presa, in una crisi generale degli equilibri costituzionali. Ma il luogo di questa arroganza impotente non è altro che l’unico luogo possibile di una sinistra che non vuol sapere nulla della crisi strutturale della rappresentanza, che non riesce neanche a nominarla teoricamente, tranne inveirvi contro di tanto in tanto con l’esorcismo della “lotta al populismo”.
 L’imperativo fondamentale che costringe qualsiasi sinistra, attualmente, in questo ruolo di sempre più netta subalternità e complicità, è emerso in modo assolutamente chiaro nella questione Ilva: è l’incapacità assoluta a ragionare fuori dall’assunzione di un’idea lineare e indiscutibile di sviluppo, e di pensare a un orizzonte meridiano non più legato alla storica subalternità del meridione allo sviluppo capitalistico nazionale. La dislocazione a Taranto delle attività a caldo con libertà di ecocidio; la creazione di una catena gerarchica di comando di fatto interamente costituita da capetti importati dal bresciano e dalla bergamasca, e graziosamente alloggiati post oppidum, che non gli si dovesse sporcare il bucato della cenere rossa che tinge persino le lapidi del cimitero; il monopolio delle attività di trasporto nautico alle compagnie liguri, con ulteriore estrazione e rapina del profitto prodotto sul territorio jonico: sono esempi concreti, ma al tempo stesso simbolici, di un modello che ha usato la dialettica sviluppo/sottosviluppo come strumento di rapina, ma anche di controllo e assoggettamento dei luoghi e delle genti – e la cui critica è nel nostro DNA politico almeno dai tempi in cui ce l’hanno narrato Serafini e Ferrari Bravo. Come simbolica, ma anche performativa, è la retorica del “buon meridionale” che si sta facendo spazio attraverso l’industria cinematografica italiana – è un caso che il Salento ne sia un luogo centrale anche dal punto di vista delle dinamiche produttive? – che presenta l’arretratezza e la stereotipia meridionale come una felice opportunità tanto per i felici indigeni scampati alle brutture del progresso, quanto per la buona società nordica che la crisi costringe a cercare alternative più economiche e geograficamente prossime a Sharm El Sheik e Ibiza. Una soggezione simbolica imbastita da un’immagine dominante del Mezzogiorno italiano, quale paradiso turistico e inferno sociale, ma anche e soprattutto da una sua definizione come forma incompiuta di modelli dominanti. Da un lato, il modello ILVA e i suoi sostenitori si percepiscono come compiutezza di modelli superiori, evoluti, moderni, insomma fratelli maggiori che fanno il bene dei minori; dall’altro, e soprattutto, le popolazioni meridionali si definiscono come copia imperfetta, come fratello minore che, immaturo, non segue i ritmi e i tempi della civiltà capitalistica. Il governatore Vendola quindi intercede presso il deus ex machina con questa condizione di subalternità in mente, operando il bene del Sud, affinché esso raggiunga quella compiutezza, quella maturità. Nondimeno la filigrana del discorso appare, oggi, assai nitida: a patto che il Sud permanga in una dimensione senza storia, senza progresso, senza la luce della ragione, senza futuro, insomma senza tutte quelle conquiste dell’industrializzazione italiana, altrimenti quell’intercessione in stile vendoliano perderebbe la propria ratio.
L’imperativo fondamentale che costringe qualsiasi sinistra, attualmente, in questo ruolo di sempre più netta subalternità e complicità, è emerso in modo assolutamente chiaro nella questione Ilva: è l’incapacità assoluta a ragionare fuori dall’assunzione di un’idea lineare e indiscutibile di sviluppo, e di pensare a un orizzonte meridiano non più legato alla storica subalternità del meridione allo sviluppo capitalistico nazionale. La dislocazione a Taranto delle attività a caldo con libertà di ecocidio; la creazione di una catena gerarchica di comando di fatto interamente costituita da capetti importati dal bresciano e dalla bergamasca, e graziosamente alloggiati post oppidum, che non gli si dovesse sporcare il bucato della cenere rossa che tinge persino le lapidi del cimitero; il monopolio delle attività di trasporto nautico alle compagnie liguri, con ulteriore estrazione e rapina del profitto prodotto sul territorio jonico: sono esempi concreti, ma al tempo stesso simbolici, di un modello che ha usato la dialettica sviluppo/sottosviluppo come strumento di rapina, ma anche di controllo e assoggettamento dei luoghi e delle genti – e la cui critica è nel nostro DNA politico almeno dai tempi in cui ce l’hanno narrato Serafini e Ferrari Bravo. Come simbolica, ma anche performativa, è la retorica del “buon meridionale” che si sta facendo spazio attraverso l’industria cinematografica italiana – è un caso che il Salento ne sia un luogo centrale anche dal punto di vista delle dinamiche produttive? – che presenta l’arretratezza e la stereotipia meridionale come una felice opportunità tanto per i felici indigeni scampati alle brutture del progresso, quanto per la buona società nordica che la crisi costringe a cercare alternative più economiche e geograficamente prossime a Sharm El Sheik e Ibiza. Una soggezione simbolica imbastita da un’immagine dominante del Mezzogiorno italiano, quale paradiso turistico e inferno sociale, ma anche e soprattutto da una sua definizione come forma incompiuta di modelli dominanti. Da un lato, il modello ILVA e i suoi sostenitori si percepiscono come compiutezza di modelli superiori, evoluti, moderni, insomma fratelli maggiori che fanno il bene dei minori; dall’altro, e soprattutto, le popolazioni meridionali si definiscono come copia imperfetta, come fratello minore che, immaturo, non segue i ritmi e i tempi della civiltà capitalistica. Il governatore Vendola quindi intercede presso il deus ex machina con questa condizione di subalternità in mente, operando il bene del Sud, affinché esso raggiunga quella compiutezza, quella maturità. Nondimeno la filigrana del discorso appare, oggi, assai nitida: a patto che il Sud permanga in una dimensione senza storia, senza progresso, senza la luce della ragione, senza futuro, insomma senza tutte quelle conquiste dell’industrializzazione italiana, altrimenti quell’intercessione in stile vendoliano perderebbe la propria ratio.
Davvero la parabola del governatore della Puglia qui è chiarissima: dopo aver tentato, invano, di tenere insieme una (non più che retorica) preoccupazione ecologista con l’imperativo di salvare la fabbrica, almeno dalla vicenda della legge sulle emissioni in poi, il suo agire è stato necessariamente improntato all’unica necessità di creare condizioni per la ripresa degli investimenti padronali. Il mantenimento non dei livelli di reddito, ma del lavoro dentro la fabbrica, è diventato l’unico possibile orizzonte: anche quando era evidente l’insostenibilità di quella produzione, quando era chiaro che lo sfruttamento in fabbrica coincideva completamente con l’attacco generalizzato e diretto alla vita nell’intera area, si è continuato a sostenere come scelta obbligata, come strada senza alternative, la conservazione di quella produzione. A quel punto, il consegnarsi mani e piedi alla speranza della buona volontà – e alle attese di profitto – di Riva & C. era solo l’esito obbligato – e, appunto, infame – dell’intera vicenda. Eppure, le lotte dei comitati avevano fatto emergere, sia pure tra evidenti tensioni e contraddizioni, in una situazione fortemente drammatica, direzioni del tutto diverse: in quelle lotte, si era affermato – nel conflitto con la rappresentanza sindacale ufficiale, letta e vissuta a buona ragione come subalterna al padrone – un nodo strettissimo tra lavoro, precarietà diffusa, disoccupazione, e salute. La giustamente memorabile incursione del treruote dell’estate del 2012 (qui e qui) aveva aperto un spazio per un discorso non assoggettato al ricatto lavorista: emergevano lotte che cominciavano ad articolare un discorso di resistenza e di alternativa sul crinale vita/lavoro, uscendo dalla fabbrica e coniugando vita e produzione sociale, reddito e ambiente, in chiara contrapposizione alle forze sindacali. Non dovevamo aspettare l’intercettazione per sapere che la scelta di Vendola – ma la questione interroga, ripetiamolo, l’intera sinistra, politica e sindacale – fu allora di ignorare completamente quanto si apriva di nuovo e di contraddittorio con la difesa fuori tempo di uno sviluppo già battuto in breccia dai processi di deindustrializzazione: e, al contrario, di ricordare ai Riva – con quale suicida e significativa coerenza! – che avrebbero trovato in “quelli della Fiom” i migliori alleati! Non capire nulla di quanto emergeva dalle lotte autonome dei comitati, non volerle vedere, per farsi mezzano dell’alleanza di fatto tra il sindacato e il padronato in nome dell’impensabilità di qualsiasi alternativa allo sviluppo siderurgico: è questo non poter e non voler evadere dalla logica della impossibile ricerca di una giusta misura dello sfruttamento, anche quando risulta chiaro che ogni misura è saltata, l’infamia di fondo di una sinistra che non è riuscita a impersonare altro che la conservazione degli antichi equilibri e la mediazione – via via divenuta impossibile, e trasformatasi in sudditanza – tra gli antichi soggetti.
Lo stesso – lo diciamo con chiarezza – vale per quell’ecologismo borghese che crede nell’esistenza di un capitalismo green o smart con cui sostituire pacificamente quello “brutto, sporco e cattivo”, così come crede di risolvere la devastazione etica e sociale sostituendo cozze e pecorini con tofu e semi di lino, e magari Vendola con Grillo: che crede di trovare soluzioni e alternative all’interno del modello capitalistico, non avendo compreso (o avendolo compreso fin troppo bene) che produzione e circolazione delle merci e dei profitti significa anche e soprattutto produzione di comando e circolazione degli strumenti di governo e assoggettamento della vita.
In questo momento, allora, la parabola di Vendola risulta davvero significativa: perché quelle potenzialità che nella vicenda Ilva emersero, quelle nuove lotte e quella nuova dignità dei corpi oltre il lavoro e lo sfruttamento, stanno animando ora, a Sud ma non solo, nuovi movimenti territoriali, che mostrano d’essere molto più che lotte “ambientali”. Sono comitati che si muovono per la restituzione delle ricchezze saccheggiate e devastate dalle logiche dello sviluppo industriale, che pongono con forza – vedi la questione delle bonifiche in Campania – la questione della riappropriazione democratica sul senso, sui ritmi e sulle finalità dello sviluppo. Lotte che si muovono proprio su quel crinale indisgiungibile vita/salute/lavoro/welfare che era già emerso a Taranto e che Vendola aveva scelto di ignorare per farsi triste mediatore, in nome dell’imperativo della produttività industriale, tra esigenze del padrone e richieste di un sindacato subalterno. Sul terreno tracciato da queste lotte, e dalla cooperazione sociale che in esse si esprime, è possibile riarticolare ora un discorso diffuso di dignità, di resistenza e di produzione di spazi alternativi di decisione: al contrario, la strada delle piccole sinistre “socialiste” – quale Sel è stata – del “realismo” della difesa della rappresentanza, degli imperativi dello sviluppo imposto, e della centralità assoluta della difesa del lavoro salariato a qualsiasi costo, è solo la storia triste di una subalternità caparbiamente perseguita.