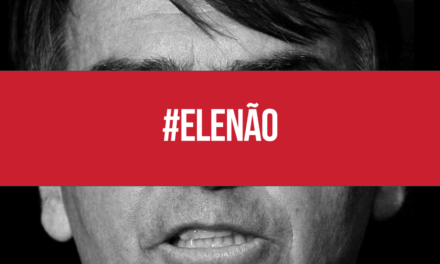di PABLO STEFANONI. (Español)
Il Venezuela sta vivendo un tentativo di golpe simile a quello che nel 2002 ha temporaneamente allontanato Chávez dal potere? È quello che dice il governo di Nicolás Maduro e che ripetono alcuni media bolivariani. Tuttavia la situazione è differente da molteplici punti di vista e presenta varie pieghe sovrapposte che parlano di un esaurimento – che significa necessariamente la fine di un ciclo immediato – del modello chavista di gestione – politica ed economica – dello Stato.
Chávez è arrivato al potere nel 1999 dopo aver guidato un golpe fallito nel 1992, quando ha lanciato la sua profetica frase Per ora non abbiamo potuto… In quegli anni risuonava ancora l’eco della violentissima repressione del Caracazo del 1992 che, con le sue centinaia di morti (non ci sono cifre attendibili), ha sporcato di sangue l’elogiata democrazia venezuelana sopravvissuta al contesto golpista degli anni settanta e che ha accolto numerosi esiliati del Cono Sud. Alla fine Chávez ha vinto le elezioni con un progetto nazionalista moderato che aveva tra i suoi assessori il nazionalista di destra argentino Norberto Ceresole. Ma la sfiducia con cui Chávez era visto dalla sinistra latinoamericana riunita nel Foro Social Mundial è venuta rapidamente meno e il bolivarismo ha cominciato ad acquisire un’identità di sinistra antimperialista, molto vicina a Cuba e sintetizzata nella formula del socialismo del XXI secolo.
Sono molti i bilanci che si possono fare del chavismo in questi 14 anni. All’attivo: l’inclusione di ampie masse di esclusi – tanto economicamente quanto simbolicamente – e le cifre positive in termini di riduzione della povertà e della diseguaglianza, sommate a una leadership di Chávez che ha potenziato l’integrazione regionale in chiave antimperialista. Ma anche la costruzione di un’identità popolare che spiega l’esito elettorale chavista al di là delle difficoltà economiche. Al passivo: il chavismo non ha potuto superare – nemmeno parzialmente – un’economia e una società fondate essenzialmente sulla rendita e che l’intellettuale Fernando Coronil ha denominato lo “Stato magico”. Senza dubbio, la rivoluzione anticapitalistica che Chávez ha immaginato non si è mai verificata – né si verificherà: il Venezuela continua a essere un paese ultracapitalista e le assidue iniziative di Chávez sul corporativismo, le comuni, ecc. sono ben lontani dall’incidere sul modello di accumulazione di rendita, un “socialismo petrolifero” in grado di ridistribuire rendita ma incapace di assicurare la produzione dei beni di prima necessità, tuttora importati dalla Colombia, dal Brasile, dall’Argentina… o dagli Stati Uniti, come il consumo lussuoso di whisky scozzese.
Come il peronismo degli anni quaranta e cinquanta in Argentina, con un discorso che oppone la nazione all’antinazione, il chavismo è riuscito a dare coesione alle sue basi, ma lasciando fuori un 40% (e occasionalmente un poco più) della popolazione e generando una polarizzazione che, pur efficace per mantenere il potere, rende particolarmente difficile costruire un nuovo ordine stabile. Come è già successo altre volte e da altre parti, il nazionalismo popolare venezuelano ha democratizzato, “nazionalizzando le masse”, e de-democratizzato, sottostimando la realtà istituzionale, persino quella costruita sotto il suo regime. È l’eterna ambivalenza populista che fa diventare così complesse le analisi e le prese di posizione.
Tuttavia se ci sono “due sinistre”, come suole ripetersi, ci sono anche due destre e quella venezuelana starebbe tra le “destre carnivore” (riprendendo un’espressione di Vergas Llosa figlio sulle sinistre populiste, opposte alle vegetariane socialdemocratiche). Una destra che non ha riconosciuto i risultati elettorali favorevoli al chavismo e ha cercato di batterlo per un’altra via.
Si è generata in questo modo la situazione di guerra civile di bassa intensità che ogni tanto torna a emergere. L’ultima manifestazione combina vari elementi.
Da un lato, una situazione economica sempre più critica, con un’inflazione del 56% annuo, svalutazioni selvagge, scarsità, interruzioni di luce, una leadership, quella di Maduro, molto più debole di quella di Chávez che ha vinto raschiando le elezioni. Dall’altro, una forte disputa nell’opposizione per definire una strategia per sconfiggere il chavismo. Se Henrique Capriles – e buona parte dei gruppi imprenditoriali e, sembrerebbe, dei democratici statunitensi – punta a distruggere il bolivarismo per via elettorale, presentandosi come un candidato moderato, Leopoldo López considera che “il cammino sono le strade”. Dopo la sconfitta dell’opposizione nelle elezioni municipali il dicembre scorso, questi falchi antichavisisti si sono convinti che non si può vincere l’apparato elettorale-statale-popolare “rojo-rojito” e che è necessario trasformare la crisi in ribellione sociale. Per questo contano sugli studenti come base di appoggio.
Anche se questa strategia è minoritaria, la repressione delle mobilitazioni, con morti e feriti – e gruppi armati da entrambe le parti – ha trascinato nelle strade migliaia di persone ponendo Maduro in una situazione estremamente complessa e evidenziando i fianchi militaristi e autoritari della costruzione chavista.
È evidente che non tutti quelli che sono scesi negli ultimi giorni per le strade sono “fascisti”. Questo non vuole dire che non possano “oggettivamente” contribuire all’offensiva della destra. E non significa neppure che non esistano “oscure” connessioni tra la destra dura venezuelana, l’uribismo colombiano e i falchi nordamericani. Eppure ciò non toglie che a differenza della Bolivia o dell’Ecuador, dove i governi nazional-popolari hanno costruito un’egemonia relativamente estesa che ha legittimato le loro gestioni, in Venezuela si è sempre mantenuto un 40% – e più – della popolazione militante e irreducibilmente antichavista. La qualità della gestione economica non è estranea alle differenze segnalate. Nemmeno la forma di gestione del potere. Basta vedere un attimo Venezolana de televisión (il canale statale) per provare l’angoscia che la sovrattuazione ideologica può causare. Il “populismo” non raccoglie solo l’opposizione di quelli che si sentono materialmente colpiti dalle sue politiche, ma di settori, specialmente i media, sensibili a quelle sovrattuazzioni e alle loro derive.
Se le rivoluzioni del XX secolo mandavano a fucilare o in esilio i controrivoluzionari reali o immaginati, i socialismi del XXI secolo devono governare nel campo della democrazia parlamentare e gli sforzi omogeneizzatori si scontrano con una diversità sociale che resiste a quelle pulsioni unificatrici del corpo sociale. Il problema per i partiti che si considerano l’espressione indiscussa della “sostanza” del popolo è che “non possono” perdere le elezioni né tantomeno pensare di abbandonare transitoriamente il potere. In questo campo, qualsiasi restrizione istituzionale sembra minore di fronte alla necessità del popolo o della rivoluzione.
Tuttavia, dato che frequentemente le critiche agli “eccessi populisti” finiscono in appelli ad abbandonare la prospettiva delle trasformazioni sociali profonde, in questo momento la domanda per le sinistre non “populiste” sembra essere come combinare radicalità e pluralismo sociale. O, detto in altre parole, come costruire le basi di quello che il canadese Richard Sandbrook chiama “transizioni socialdemocratiche reali”.