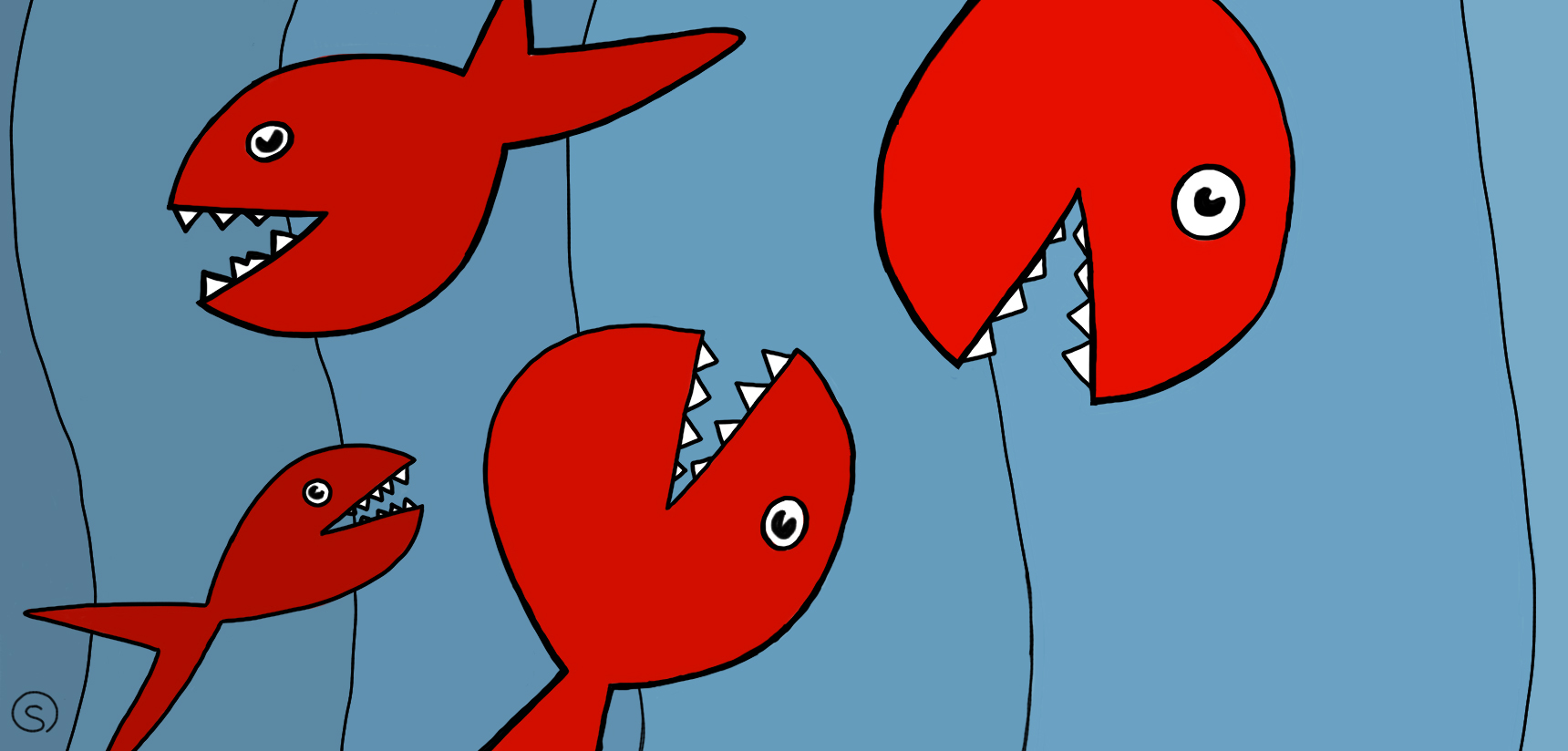di JADEL ANDREETTO.
Un’approssimativa e confusa mappa stradale sentimental-emotiva di Bolzano a partire da Cent’anni a Nordest di Wu Ming 1
SERPENTE
Un carbonazzo si dimena e sibila in mezzo all’incrocio. L’asfalto è rovente, il cielo blu dodger è altissimo, il semaforo scatta, la temperatura sfiora i quarantadue gradi. In giro non c’è nessuno, piazza Mazzini è pura metafisica. Sollevo lo sguardo: il terrazzo dell’attico all’angolo era un rigoglioso giardino pensile, ora non c’è nulla, nemmeno un ramo secco. Negli anni Ottanta ci abitava un politico, uno di quelli travolti dalla tangentopoli locale. Nel 1988 sembrava Beirut. O così dicono i soccorritori arrivati nel cuore della notte dopo che una bomba scoppia davanti alla sede della RAI: una decina di chili di esplosivo sistemanti sotto un furgone. Il tettuccio del camper vola sul tetto del palazzo di sette piani tra le antenne paraboliche, venti metri d’altezza; il guardiano notturno si ritrova ricoperto di vetri e schegge. Quattro delle auto posteggiate vengono distrutte, sono tutte Fiat: una 126, una Prisma, una Uno e una 190. Le altre sono gravemente danneggiate. Il cratere è profondo trenta centimetri.
Una camionetta dei pompieri risale Corso Italia. Qualcuno deve averli chiamati per il serpente che nel frattempo sta strisciando verso Corso Libertà. Succede quando fa così caldo. Una volta, quando ero bambino, con mio cugino ci siamo imbattuti in una vipera che risaliva le scale del suo condominio. Abbiamo assistito alla sua decapitazione da parte del caposcala. Ricordo di averla osservata mentre mordeva una paletta, una di quelle che si usano con le scope per raccogliere la polvere, con cui era sta bloccata. Mi sono sempre chiesto da dove fosse saltata fuori. Bisce, topi e furetti arrivano dalle zone attorno ai fiumi o dai fazzoletti di campagna incastonati nella mappa cittadina. Persino i cervi sono scesi in città, ma una vipera che risale la rampa di scale di un condominio del quartiere popolare… Mi sono immaginato con ribrezzo che qualcuno fosse andato a funghi la domenica e che in qualche modo la bestia si fosse infilata nell’auto. Magari proprio dal cestino dei funghi, per poi strisciarne fuori e trovare la strada per le scale. Resterà per sempre un mistero. È uno di quegli episodi a cui ripenso di tanto in tanto, e a forza di ripensarci sembra quasi un sogno. Mi capita spesso di fare sogni ricorrenti in cui finisco immancabilmente in alcuni luoghi di Bolzano che nella realtà non esistono, ma la ciclicità con cui si presentano alle volte mi confonde. Sono vent’anni che non vivo nella ridente cittadina sudtirolese, eppure i miei luoghi onirici sono sempre lì, tanto che alle volte si confondono con i ricordi e viceversa. C’era un bar, o meglio forse c’era un bar, che apriva a orari strani e non sempre. Era una specie di circolo nei pressi di una delle tante case un po’ bohémien in cui ho vissuto da quelle parti. Non saprei dire se fosse un luogo dei miei sogni o dei miei ricordi. Davvero non lo so. Ho anche provato, senza troppa convinzione, devo essere sincero, a passare da quelle parti, ma non è servito a molto. Se c’era, adesso non c’è più, se non c’era non lo saprò mai. Non saprei nemmeno più a chi chiedere. Non (ri)consoco più nessuno da quelle parti. Questo stato di alterazione onirico mi perseguita e mi culla ogni volta che vedo o sogno Bolzano.
La mia Bolzano è quella dell’infanzia, della fine degli anni Settanta e dell’inizio degli Ottanta e quella della mia giovinezza: gli anni Novanta. C’è ancora, irrimediabilmente, qualcosa di quella città nella Bolzano che rivedo quelle rare volte che ci torno anche se molto è cambiato, a partire da me stesso.
La bomba alla sede RAI, l’infanzia, è esplosa in Piazza Mazzini, dove corso Italia e corso Libertà si incontrano. Italia e Libertà sono un incrocio di parole da maneggiare con cura da queste parti. Siamo nella zona di piazza Vittoria in cui sorge il monumento con i fasci littori e la scritta «hic patriae fines siste signa hinc ceteros excolvimvs lingva legibvs artibvs» (qui i confini della patria. Pianta le insegne! Da qui educammo gli altri alla lingua, al diritto, alle arti), monumento che segna anche un altro confine, quello tra il resto della città e il centro, la cui struttura e architettura sono di stampo prettamente medievale | mitteleuropeo | austrungarico.
Tra piazza Mazzini e piazza Vittoria verso Gries, il quartiere “tedesco”, si diramano una serie di strade la cui toponomastica è decisamente schizoide: Antonio Locatelli, l’aviatore, “leone di guardia” di D’Annunzio, morto durante la guerra d’Etiopia e Reginaldo Giuliani, prete soldato, squadrista cattolico, che fece la Marcia su Roma e partecipò con entusiasmo allo stesso conflitto come cappellano delle Camicie Nere sono i “dirimpettai” di Manilo Longon, partigiano e capo del Comitato di Liberazione Nazionale di Bolzano, impiccato dalla Gestapo e del conte Giannantonio Manci, antifascista e partigiano italiano, eroe della resistenza. Tra loro la piccola via dei Combattenti. Tutti si affacciano a sud su Corso Libertà e a nord su via Armando Diaz. Diaz, come da copione, incontra Cadorna in piazza 4 novembre e assieme rappresentano le due arterie principali del rione che vanta anche una via Montello, una via Col di Lana e una via Principe Eugenio di Savoia che si infilza nella parte tedesca del quartiere come uno stiletto sbattendo contro via Fago e trasformandosi, oltre l’incrocio, in un via dedicata a un pittore che, però, cela su un fianco una strada senza uscita che in pochi conoscono e nella quale, prospiciente ai piccoli e graziosi condomini, si erge un muricciolo alzato ai tempi della guerra oltre il quale c’è uno spazio vuoto delle dimensioni di un campo da calcio, incolto e lasciato alla polvere, alla verzura e ai ratti. Un concentrato di antimateria inspiegabile in un quartiere ricco di una città ricca con prezzi al metro quadrato da far impallidire Manhattan. La stradina in questione è via Tripoli. Un stridio, un’unghia sulla lavagna, uno strisciare di metalli, in mezzo a una manciata di paesaggisti e ritrattisti austriaci.
Via Cadorna, la giovinezza, l’ho percorsa per anni, avanti e indietro, tutte le mattine. Ogni volta che ci ripasso rimetto i piedi dove li ho posati milioni di volte. Se il tempo venisse abolito, il marciapiede sarebbe pieno di miei doppelgänger, così affollato che tra spalla e spalla non passerebbe nemmeno un spillo. Il rischio sarebbe quello di occupare lo stesso spazio con conseguenze devastanti per le mie/nostre molecole. Ma l’illusione del tempo non è ancora stata abolita e io per tutti gli anni delle superiori ho percorso via Cadorna sei giorni alla settimana, nove mesi l’anno. Da un lato le bucoliche passeggiate del Talvera, dall’altro una serie di edifici dall’architettura del periodo fascista. Il razionalismo italiano, tra caserme militari e istituti tecnici, domina l’intera strada. Dopo il corpo d’armata ci sono “i geometri” Delai, “le ragionerie” Battisi che condividono lo spazio (separato da mura e porte tagliafuoco concrete e metaforiche) con l’ITC di lingua tedesca Kunter, l’ITI Galiei e l’IPIA (a chi fosse dedicato non l’ho mai saputo) e più in là le cosiddette “scuole tedesche” tout court. Oggi probabilmente hanno cambiato denominazione, ma le sigle e i nomi all’epoca erano quelli.
Una volta nell’atrio dell’ITC, dopo aver salito le imponenti rampe di scale curve, sulla sinistra, in bronzo, Mussolini saluta gli allievi, mentre al primo piano c’è una nicchia con un piedistallo su cui svetta l’imponente testa, sempre in bronzo, di Cesare Battisti che scruta severa gli allievi. La testa ruota sul suo asse e alle volte qualcuno la gira. Certe mattine guarda il corridoio di destra, certe altre quello di sinistra. Ogni tanto mostra la nuca, senza pudore. Mentre di Battisti ci si prendeva gioco in quanto nume tutelare dell’istituto di cui, in realtà, si sapeva poco o nulla, il Duce se ne stava lì con poca considerazione. Fossero state le ITI (le, sì, con l’articolo al femminile), probabilmente ci sarebbe stata una sventagliata di saluti romani ogni mattina. Fascisti, come in tutta la città, ce n’erano eccome, ma nelle aule del Battisti c’erano anche gli altri. Eppure quel bassorilievo non suscitava la benché minima emozione né dall’una né dall’altra parte. Era semplicemente lì, un complemento d’arredo su cui nessuno si era mai soffermato. Comincio a sospettare di aver sognato pure quello.
 Mentre leggo Cent’anni a Nordest di Wu Ming 1 mi ritrovo a pensare che anche il bassorilievo in salsa equestre del Duce in piazza Tribunale, quello terminato negli anni Cinquanta, come molte altre tracce del fascismo, in città è sempre stato lì; parte del paesaggio; sbiadite nel quotidiano, assimilate come possono esserlo statue, cariatidi, decorazioni sulle facciate dei palazzi di altre città. Al centro di battaglie politiche e malumori intellettuali, ma nella vita dei bolzanini assolutamente irrilevanti, con il passare delle generazioni, monumenti, scritte, bassorilievi, effigi diventano parte del paesaggio, geroglifici ornamentali privi di significato. L’occhio non si sofferma più di quanto non lo faccia su una qualsiasi statua di Garibaldi in giro per il mondo.
Mentre leggo Cent’anni a Nordest di Wu Ming 1 mi ritrovo a pensare che anche il bassorilievo in salsa equestre del Duce in piazza Tribunale, quello terminato negli anni Cinquanta, come molte altre tracce del fascismo, in città è sempre stato lì; parte del paesaggio; sbiadite nel quotidiano, assimilate come possono esserlo statue, cariatidi, decorazioni sulle facciate dei palazzi di altre città. Al centro di battaglie politiche e malumori intellettuali, ma nella vita dei bolzanini assolutamente irrilevanti, con il passare delle generazioni, monumenti, scritte, bassorilievi, effigi diventano parte del paesaggio, geroglifici ornamentali privi di significato. L’occhio non si sofferma più di quanto non lo faccia su una qualsiasi statua di Garibaldi in giro per il mondo.
È lì, è sempre stata lì. Chissà chi è? Ma, in fondo, chi se ne frega. Cioran, in Squartamento, scriveva che «il tempo, complice degli sterminatori, atterra la morale. Chi, oggi, ce l’ha ancora con Nabucodonosor?».
Eppure io continuo a camminare sotto il sole, mentre i pompieri si occupano del carbonazzo, continuo a camminare come faccio sempre quando sono in città e cerco per quanto possibile di risollevare la morale, o per lo meno il morale. Mi muovo indolente tra strade e stradine poco battute. La mia è una forma di esplorazione metropolitana, come quando da ragazzino salivo sugli autobus diretti nei quartieri che non conoscevo e facevo tutto il percorso fino al capolinea per poi tornare indietro. È salendo a bordo del 9 che ho esplorato il CEP (centro edilizia popolare), il quartiere popolare tedesco che si allunga sul dorso della montagna sopra Oltrisarco, o Rencio e Gries con il 6. Il 7 non sono mai riuscito a capire che giro facesse e non sono nemmeno mai riuscito a prenderlo, ma ricordo di aver provato un brivido quando il percorso del 3 venne allungato verso le zone nuove di via Ortles e di via Similaun. Quando poi sono arrivati gli autobus dal 10 al 14 avevo smesso da un pezzo di usare il bus, ero passato alla moto. Devo ammettere che l’arrivo del 14, che andava verso i Piani, mi ha lasciato di stucco. Per anni infatti, verso le dieci di sera, scendevo alla fermata della stazione centrale e con la custodia a zaino del basso me ne andavo verso la sala prove dietro i magazzini generali ai Piani, una bella scarpinata in un quartiere mezzo deserto, fatto di capannoni e case costruite per i ferrovieri in transito, che più tardi, consegnando pizze ho scoperto chiamarsi Ferrotel. Camminavo al buio e al freddo per strade desolate, passando sotto tunnel squallidi e imboccando, con un rinnovato piacere per la scoperta, vicoletti stretti e umidi. Avanzavo, naso al cielo, sguardo perso tra le stelle dei cieli tersi invernali, tra battone e papponi, ubriaconi dallo sguardo spento e un grigiume opprimente lontano anni luce, ma pochi chilometri, dallo scintillante sfavillio del centro della città bomboniera. La sala prove era nel sotterraneo di un capannone della zona artigianale. Per tornare a casa, qualcuno del gruppo mi dava un passaggio. Ci fermavamo là, tra il fragore delle chitarre, fino alle tre di notte, tre ore e mezza dopo dovevo svegliarmi per andare a scuola, ma erano i primi anni Novanta, ero in piena ebollizione e a Bolzano c’erano molte band, ci conoscevamo tutti, suonare era la cosa migliore che ti potesse capitare da quelle parti dove non c’era mai nulla da fare. Eravamo tutti convinti di essere in una piccola Seattle, la Seattle d’Italia, e come noi, erano convinti di questo in molte altre provincie. Poi non so cosa sia successo. Di Seattle forse c’era solo il freddo. E il buio.
Toni melodrammatici a parte, lo scenario era interessante: in una città operaia dove si producono i carri armati per l’esercito americano si aggirano tre serial killer, il primo uccide le prostitute, il secondo squarta a coltellate ragazze poco più che ventenni tra cui la figlia del tuo maestro elementare nell’appartamento accanto a quello di tua madre, il terzo spara a chi parla italiano e muore arso vivo dopo una sparatoria all’ultimo sangue con i carabinieri. Nel frattempo saltano in aria alcuni quartieri a colpi di bombe irredentiste, la scritta Ein Tirol (Un – unico – Tirolo) compare sui muri, prontamente arricchita di una K: KEin Tirol (Nessun Tirolo). C’è un solo posto, in città, in cui si respira un’altra aria, un bar porto di mare in un vicolo del centro che raduna, senza distinzioni etniche, politiche o di età, la fauna singolare che anima i sotterranei di Bolzano. Tra punk rurali, corvi gothic, new waver, hippy fuori tempo massimo, contadini, operai delle acciaierie, colletti bianchi, architetti, studenti, sfaccendati, svalvolati, orchestrali, cialtroni, ragionieri, anarchici, comunisti, qualche fascista, italiani, tedeschi, baristi francesi, figli di papà e figli di puttana, Holler in vicolo Erbe è stato una riserva indiana di cui rimane forse traccia in un qualche video su youtube, girato da chissà chi, durante la tradizionale e spontanea assemblea della vigilia di Natale. Un video che non interessa e non può interessare nessuno tranne chi ha frequentato quel posto all’epoca. Tra gli anni Ottanta e Novanta c’era solo quello. Ed era bello. Ora è un anonimo pub irlandese di una catena in franchise. Bolzano freme e brulica di attività culturali, c’è l’università, ci sono concerti, mostre, eventi. Ora c’è l’università. Ora c’è tutto e tutto è benedetto dalla Provincia, tutto è svedesemente socialdemocratico. Si suona un po’ meno e si fanno più aperitivi. Non che non si bevesse prima, a Bolzano si beve eccome e lo si è sempre fatto, ma era questione di mosche da bar non di happy hour, questione di squallide tradizioni e non di tendenze. Non c’è nulla di male né nell’una né nell’altra cosa e poi, come diceva Sartre ai fini dell’essere ubriacarsi in una bettola o guidare popoli è la stessa cosa.
Sembra quasi che i miei primi vent’anni a Nordest siano stati quelli più interessanti, anche se ora, a vent’anni di distanza la città, sulla carta, offre molto di più.
Sarà che ero giovane e come tutti i giovani, affamato e disperato. Mi sentivo come quel serpente nero in mezzo all’incrocio rovente.
COLONY
I Joy Division erano all’ordine del giorno, uno dei pochi trait d’union della fauna che assiepava vicolo Erbe con un bicchiere di zibibbo in mano, un boccale di birra rossa nell’altra e un po’ d’hashish in tasca. Colony mi ronza nelle orecchie e mi viene in mente che tutti quelli della mia generazione sono figli o nipoti di coloni. Sembra strano a dirsi eppure è così. Veneto, Trentino, Friuli, Istria, Calabria, Sicilia, Campania, Sardegna… In momenti diversi i “coloni” sono approdati da diversi luoghi in suolo sudtirolese e negli anni, al contrario di altre colonie, si sono bolzaninizzati. Il luogo di provenienza non ha più nessuna importanza. Poche generazioni e sono scomparsi gli accenti, le inflessioni e i tic dialettali, finendo in un unico calderone linguisitco: un gergo e non un dialetto che mescola qualche parola veneta e trentina con un vago accento di matrice settentrionale, ma mai chiaramente identificabile. Nessuno, in giro per l’Italia, dirà mai che siete di Bolzano quando vi sentirà parlare – mostrate la carta d’identità verde per sbigottire e farvi credere -. E così, passeggiando per le strade di Don Bosco, Shanghai come la chiamava la generazione di mio padre, potreste imbattervi in qualcuno dall’inequivocabile cognome beneventano che porta il “bocia” a scuola e dà del terrone ai suoi ormai lontani cugini.
La “Colony” a cui faceva riferito Ian Curtis era quella penale di kafkiana memoria, se penso ai racconti di mio nonno, di quando lavorava alle acciaierie e di come abbia fatto di tutto per trovarsi un altro posto di lavoro (alla fine è riuscito a fare “la guardia” dei giardini”) non mi resta che pensare che in effetti sì, il brano, il testo e le atmosfere plumbee dei Joy Division si adattino al contesto.
Quando, dopo l’annessione del Sudtirolo alla penisola, il Duce ha trasformato Bolzano da centro commerciale in centro industriale, lo ha fatto per incentivare i flussi migratori dal resto d’Italia e per italianizzare la nuova colonia.
A Shanghai, ancora oggi il quartiere più nero della città, ha eretto gli alloggi per gli operai in arrivo, case fatte a immagine e somiglianza della sua casa natia: le semirurali: “villette bifamiliari” con orticello e giardino in un reticolo di anguste stradine sterrate che oggi non esistono più. Nella maggior parte dei casi le “villette” erano senza riscaldamento. A Bolzano. D’inverno. Dall’altra parte del fiume, in quella che ancora oggi è la zona industriale, ha costruito, per l’appunto, la zona industriale. Prendete una mappa di Bolzano. Cercate via Genova, poi cercate via Volta, dove si trovano le acciaierie. Fatto? Tracciate il percorso a piedi. Più o meno un quarto d’ora. Oggi.
All’epoca di mio nonno però non c’erano i ponti Resia, Palermo e Roma, per cui i lavoratori di Shanghai dovevano andare fino a Ponte Loreto (quante suggestioni questo nome a cose fatte), a cento metri dalla stazione del treno, e ripercorrere la stessa strada a ritroso sull’altra sponda del fiume. Ogni giorno, ogni mattina alle cinque, e ogni notte dopo il turno, con ogni condizione climatica e temperatura – Bolzano è la città più calda d’estate e la più fredda d’inverno – file di persone in tuta da lavoro, risalivano il grigio mattino, per andare a forgiare il metallo.
C’è voluto del tempo prima che venissero costruiti i nuovi ponti. Nel frattempo il regime ha fatto in tempo a finire, ma i coloni si erano già stabiliti, avevano casa, lavoro e una nuova identità sociolinguistica, erano bolzanini (non Bozner). La zona operaia si era espansa e, da Shanghai, come un tentacolo risaliva la sponda del fiume Isarco in un reticolo di strade italianissime: via Genova, via Parma, via Brescia, via Sassari, via Cagliari, via Palermo, via Alessandria, via Bergamo, via Aosta, via Milano, via Torino – via Dalmazia e via Rodi -, via Treviso (dove c’era una scuola di Esperanto), via Roma, via Napoli, viale Trieste, via Arezzo, via Verona, via Firenze… Ma già da queste parti alle tute blu si preferivano i colletti bianchi.
Mio nonno, padovano, e mia nonna, trentina, con i tre figli, stavano in via Torino, poco distante dal fiume. Dopo la guerra, sulla riva del fiume sorse una baraccopoli di profughi e rifugiati. C’erano molti polacchi. Mia nonna, durante la Grande Guerra era stata in Boemia, nella stessa condizione. Come lei, molti altri. Come lei, anche i nuovi coloni non batterono ciglio. Era nelle cose della vita. Mio padre giocava con i ragazzini polacchi a calcio. E come tutti i ragazzini e bambini del rione andava sul lungofiume con loro o si intrufolava al Lido (il parco con le piscine che ogni bolzanino conosce e dà per certo in ogni città, salvo poi scoprire che dalle altre parti non esiste nulla del genere). Nonostante non si capissero, erano amici. La baraccopoli era dignitosa, la convivenza scontata. Prima che tornassero in Polonia, uno di loro si suicidò. Ancora oggi mio padre non ha capito perché.
Poi, quando mio nonno ha cambiato mestiere, il comune gli ha dato in affitto un appartamento più grande in centro, dietro piazza Verdi, che allora non era esattamente un luogo raccomandabile, sorta di angiporto per puttanieri dal coltello facile e che oggi come il resto della città è un posto tranquillo, checché ne dicano i bolzanini spaventati dal degrado. Era un appartamento ricavato da uno stabile sede della questura asburgica. Le cantine erano le celle per i prigionieri. Quando scendo là sotto, mi chiedo come facessero a sopravvivere anche solo una notte in inverno.
TOPONOMASTICA MAGICA | NOMICIDI
La Seattle d’Italia… Italia, già.
Provate a immaginare: un flusso migratorio dell’ordine di migliaia di persone, con cultura e lingua diversa dalla vostra, si istalla sul vostro territorio. Voi siete costretti a sottostare alle leggi dei nuovi arrivati e a imparare la loro lingua, dovete cambiare il vostro cognome e quello dei luoghi in cui vivete, dovete cambiare il nome dei vostri morti sulle lapidi oppure lasciare tutto e andarvene in un altro paese (che non vi vuole e non vi aiuterà a trasferirvi). Insomma l’incubo di ogni fascio-leghista che dimentica di essere figlio, nipote o pronipote di immigranti che non sono poi andati tanto per il sottile con le popolazioni locali quando è stato il loro turno di riversarsi in terra straniera. Le motivazioni che spinsero gli italiani a emigrare in Sudtirolo erano legate alla fame, alla mancanza di lavoro, alle calamità naturali (terremoti, inondazioni), alle conseguenze della guerra…
Ma chi e perché ha deciso che il Sudtirolo diventasse Alto Adige? Cosa c’entrano gli Stati Uniti e la Guerra Fredda? E perché i primi atti di terrorismo su suolo italico sono avvenuti in terra ex-austriaca? Su questo e molto altro si potrebbe dare una letta a Brennero Connection – alle radici del terrorismo italiano di Gianni Flamini (Editori Riuniti, 190 pp. 14 €). Lascio l’approfondimento a quelle pagine e riparto dalla Seattle d’Italia…
La toponomastica, una parola che in Sudtirolo tutti imparano già all’asilo, è una questione – assurdamente, tragicamente, comicamente – spinosa. Come si chiama un luogo? Chi gli dà quel nome? Parigi è Paris e London è Londra? Bombay è Mumbai? Bolzano è Bozen e Bozen è Bolzano? A quindici anni, ho avuto una “morosa” tedesca che mi ha spalancato le porte della percezione, dato accesso all’impero dei sensi e mi ha fatto scoprire Bozen, una città parallela, fatta di bar, parchi, scuole, club, sale prove, case bohémien quanto la mia ma con l’affaccio su piazza Walther e luoghi di ritrovo di cui non conoscevo l’esistenza e di cui nessun italiano aveva idea. A ripensarci, sembra davvero strano. La città non è poi così grande, eppure ha una doppia vita, una doppia geografia della socialità, dell’intrattenimento e della cultura. È come se per qualche motivo le particelle di italiani e tedeschi vibrassero a due velocità leggermente diverse, occupando lo stesso spazio e lo stesso tempo, ma non la stessa dimensione. E per me è stata il passe-partout per il portale dimensionale che mi ha condotto a Bozen partendo da Bolzano, uno dei viaggi più bizzarri che abbia fatto.
Durante il processo di italianizzazione – il processo, volontario o forzato, di assimilazione culturale alla cultura e lingua italiana – della colonia negli anni Trenta, il geografo e politico fascista Ettore Tolomei venne incaricato di rivedere la toponomastica sudtirolese. Quello che venne definito “il becchino del Sudtirolo” (Totengräber Südtirols) dai suoi abitanti si macchiò dell’efferato delitto di nomicidio. Un atto di magia nera. Dare un nome alle cose significa evocarle, nominare qualcosa è farlo apparire, è un incantesimo. Se dico trattore, nella vostra mente si forma l’immagine di un trattore. Ho evocato il mezzo agricolo con una sequenza di lettere, se non è magia questa… Rinominare qualcosa è un atto di necormanzia: ha a che fare con la morte e la putredine. Tolomei uccise con una penna millenni di tradizioni e culture, in favore di altre, più o meno arbitrariamente. Il Rosengarten, il giardino delle rose del mitologico Re Laurino, la montagna incantata, che al tramonto si tinge di rosa e maestosa, ma serena, abbraccia la città venne rinominata Catinaccio riprendendo goffamente la forma ladina Ciadenac. Il mito eziologico che spiegava con una leggenda il fenomeno dell’enrosadira è crollato, tutta la sua poesia si è sgretolata sotto i colpi della penna di Tolomei. Cercando di disinnescare una mitopoiesi, una tradizione, una lingua, una cultura andando a ripescare un origine traballante legata al latino, ha innescato un incantesimo e cercato di annichilirne un altro. Giardino delle Rose e Catinaccio non sortiscono lo stesso effetto, non evocano la stessa cosa, sono magie diverse e la psiche stessa di chi vive all’ombra del Catenaccio o alle pendici del Giardino delle Rose subisce l’incanto in modo diverso. Il necroforo Tolomei ha scelto di lanciare un incantesimo dalle conseguenze plumbee, metalliche, in assonanza con il rumore delle fonderie e dell’acciaio colato, lo stesso che ha tolto l’udito a mio zio e a molti altri operai, lo stesso che scandisce i giorni dei miei amici che lavorano all’Iveco per costruire i carri armati per l’esercito americano e che poi sono finiti a fare i meccanici in Afganistan.
Le idee sono come i metalli, hanno un suono, annotava Longanesi e il suono di Bolzano è un suono fatto di metallo, che questo suono sia come un’idea però è un altro paio di proverbiali maniche. Eppure. Eppure, a pensarci bene, il Südtirol, anzi (concedetemi il neologismo per principianti) il Südtirock, il sottobosco musicale ha avuto sempre un altissimo tasso metallico. Prima o poi tutti hanno suonato, nelle sua varie declinazioni e commistioni, il metal (e l’hardcore punk). Ci sono almeno tre gruppi molto apprezzati a nord del confine (Skanners, Anguish Force e Graveworm) e una miriade di band e progetti che devastano le sale prove, le cantine, i magazzini e i garage di mezza provincia. Bolzano. Città operaia dal suono operaio. Chi, quando si parla di Bolzano, ha in mente solo il mercatino di Natale, le ciclabili e la famosa qualità della vita, l’avrebbe mai detto?
Ma è ancora così? I miei vent’anni a Nordest sono lontani vent’anni e le cose, per quanto lentamente sono cambiate. O forse come diceva Fitzgerald: «è buffo tornare a casa. Tutto ha lo stesso aspetto, lo stesso odore, ti dà la stessa sensazione di sempre. Ti rendi conto che l’unico a essere cambiato sei tu».
E allora riprovo la vertigine di ripercorrere il labirinto dei passi e del tempo: da piazza Verdi, dal nuovo teatro comunale, dove una volta sorgeva un polveroso parcheggio sgangherato, imbocco via Marconi con gli internet point pakistani, supero la questura, scavallo il ponte Druso che, come diceva mio nonno ultracomunista, era comunque meglio quando c’erano le aquile del Ventennio, passo davanti all’Eurac, l’accademia scientifica sorta sullo scheletro dell’ex-GIL (gioventù italiana del littorio) e piego su viale Trieste fino ad arrivare davanti al Lido. Do le spalle allo stadio e osservo. La mia scuola materna ed elementare. È lo stesso percorso che facevo in solitaria quando avevo otto o nove anni. Solo che dove c’è la ciclabile c’era il terrapieno della ferrovia e prima dell’angolo tra via Druso e viale Trieste, dove c’è il cortile interno dell’Eurac, c’era una spianata sterrata con un’officina meccanica in fondo. Era una specie di scorciatoia. Mi infilavo nel cortile di terra rossa, tra rottami, auto con il cofano aperto, cani spelacchiati, e lo attraversavo in tutta la sua lunghezza, salivo una scaletta arrugginita sopra l’officina che portava all’entrata di un cinema porno e a un piccolo campo nomadi e sbucavo all’inizio del ponte. Se mia figlia, che ha pressappoco l’età in cui facevo questo percorso, facesse la stessa cosa, mi verrebbe un colpo (e probabilmente i servizi sociali mi farebbero una visita).
Se abolissimo di nuovo il tempo io e il bambino che ero ci pesteremmo i piedi e formeremmo un’unica stramba creatura, allo stesso modo, i ricercatori dell’Eurac impegnati in una qualche conferenza, vedrebbero, comodamente seduti sulle poltrone di pelle gialla di lusso, qualche pellicola tedesca in cui un tizio con i baffi a manubrio non va tanto per il sottile con una bionda prosperosa, mentre chi legge il giornale nel moderno caffè della struttura, si ritroverebbe a sorseggiarlo in una roulotte circondato da bambini con il moccolo al naso.
Il ponte da cui parte l’omonimo viale che arriva fino al bivio per Merano e costituisce la spina dorsale della città ha un nome che da grande ho sempre, come tutti i bolzanini, dato per scontato: Druso.
Da piccolo invece mi chiedevo, mentre lo percorrevo, cosa o chi fosse. Lungi da me domandare a qualcuno o cercarlo sull’enciclopedia, davo a quell’enigmatica parola ogni giorno un significato diverso. Oggi era un oscuro regno dell’Asia, domani un musicista, un famoso cavaliere medievale, un animale (sì, un animale come se ci fosse via Tigre o via Armadillo) o una qualche bella signora d’altri tempi. E così ogni giorno era un’avventura, come se non bastassero il cortile dei rottami, i cani, il cinema con i suoi curioso manifesti “solo per adulti” e lo sgangherato caravan serraglio urbano.
Druso… Chi era? E, una volta scoperto l’arcano, allora Bolzano è romanamente Italia come dice lo slogan dei manifesti di casa Pound? O è Austria. O è Tirolo? Be’, se fosse un social network si potrebbe optare per lo stato it’s complicated.
L’asse su cui la città si divide in parte anche etnicamente, prende il nome dal generale che nel 15 a.C. costruì la statio romana in loco. I romani però non furono i primi ad abitare queste lande, ma poco importa, Bolzano è sempre stata luogo di transito e di commercio ed è passata sotto diversi domini e signorie: dal Conte di Tirolo a Barbarossa, dal vescovado di Trento a quello di Bressanone, dai Medici agli Asburgo.
Da via Druso; poco prima del ponte che separa il centro dal resto della città, in direzione della fasciatissima piazza Vittoria, già piazza della Pace, già piazza Vittoria (la pirandelliana vicenda del cambio di nome della piazza varrebbe un racconto a parte) si può imboccare viale Venezia, così chiamato perché le case furono costruite dai veneziani e ancora oggi hanno uno stile unico in città, e poi non dimentichiamo che Casanova passò un po’ del suo tempo nei vicoli tagliafuoco del centro medioevale come racconta Sándor Márai nel suo romanzo pubblicato dai tipi di Adelphi, La recita di Bolzano; si può anche risalire via San Quirino, tribuno romano votato al martirio cristiano e tra Venezia e Quirino ci sono via Fiume e via Zara, a ricordare la comunità istriana e via Peter Mayr, che prese parte all’Insorgenza tirolese a inizio Ottocento liberando per qualche mese, sotto la guida di Andreas Hofer, il territorio dall’occupazione franco-bavarese. Lo stesso Andreas Hofer che, in seguito, è diventato un simbolo del movimento anti-italiano e a cui è dedicata una strada in centro che corre parallela a via Cavour. Dalle parti della stazione, poco distante da lì, si celebra invece un altro Mayr. Joseph Mayr Nusser, che quando fu il momento di decidere se restare nel Sudtirolo italiano o andarsene nei territori del III Reich, decise di rimanere, ma venne comunque arruolato forzatamente nelle SS. Il suo rifiuto di prestare giuramento lo condusse alla morte nel campo di sterminio di Dachau, in pieno cuore di tenebra… Grande è la confusione sotto il cielo bolzanino, grande la confusione nei cuori assopiti dei suoi abitanti, che sotto l’influsso di tali e tanti incantesimi toponomastici vagano, inconsapevoli del peso magico che grava sulle loro spalle, in preda al volere capriccioso dei nomi e dei numi; sono tutti, non solo io, come serpenti neri che si dimenano in mezzo a incroci roventi.