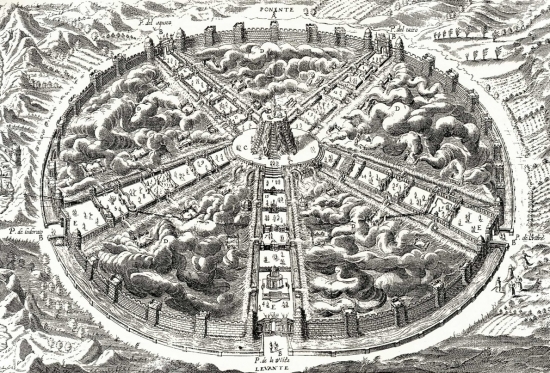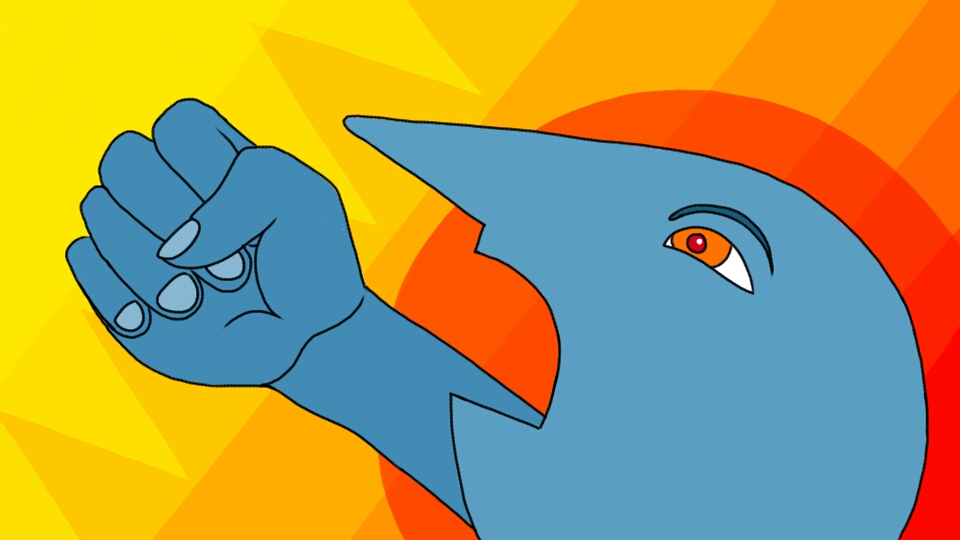Di MARCO BASCETTA
La responsabilità di questa guerra, anche tenendo conto del contesto geopolitico che ne ha forgiato numerose condizioni, non può che essere addossata alla Russia, in quanto paese aggressore che ha deciso di risolvere con le armi gli attriti sui suoi confini occidentali. Ma l’allargamento del conflitto, verso il quale il mondo sta rapidamente precipitando, chiama in causa altri responsabili. Il vertice con i rappresentanti di 43 paesi convocato dagli americani nella loro grande base militare di Ramstein in Germania non può definirsi altrimenti che come un consiglio di guerra. Con l’intento dichiarato di giungere a una completa vittoria militare dell’Ucraina.
Cosa questo significhi quando sconfitto si vorrebbe il Paese più esteso e la seconda potenza nucleare del pianeta non è chiaro ed è decisamente inquietante. Fatto sta che non si parla più di far cessare la guerra, ma di vincerla. Con costi umani ed economici incalcolabili e che infatti tutti si guardano bene dal calcolare. La diplomazia si è dissolta in un latrato irresponsabile e minaccioso, che esula da ogni possibile prospettiva negoziale. Ad ogni giorno che passa, ad ogni pronunciamento della Nato, di Londra e di Washington, ad ogni replica moscovita, la possibilità di un compromesso si fa sempre più evanescente, per non dire impossibile.
Se si può capire, senza peraltro apprezzarla, la retorica patriottico-muscolare di uno Zelensky che si considera il centro del mondo e la chiave del suo futuro politico, del tutto irresponsabile e irritante è quella del sottosegretario britannico alla difesa James Heappey che suggerisce agli ucraini (ma, per carità, la scelta è loro…) di usare le armi pesanti ricevute da Londra (oltre che dagli Usa e da altri paesi Nato) per colpire obiettivi in territorio russo. Non da meno i toni del segretario alla Difesa americano Lloyd Austin che, ritenendo minacciata l’Europa intera, muove un passo ulteriore verso l’ipotesi della «guerra totale».
La prima vittima politica di questo conflitto e della sua escalation a guida angloamericana è l’Unione europea, oscurata, allineata, senza voce e senza proposte, senza punto di vista sulla guerra e sulla pace, dedita da mane a sera a dimostrare che i suoi gretti interessi economici non macchieranno la purezza dei «valori occidentali». Le sbruffonate muscolari di Boris Johnson e del suo governo, dovutamente concimate da una guerra sul suolo europeo e dalla crisi delle interdipendenze economiche globali, ci offrono, fra l’altro, un insegnamento che gli europei hanno finora evitato di ascoltare. Brexit non conduceva solo fuori dall’Unione europea ma contro di essa. In una logica nella quale la competizione, anche e soprattutto sul piano geopolitico, prevale largamente sulla cooperazione, nonostante la rappresentazione di facciata di uno schieramento comune e condiviso in tutte le sue scelte.
Che l’influenza tedesca sull’Europa orientale fosse mal tollerata a Londra e Washington non è certo un mistero e il conflitto tra Kiev e Mosca una buona occasione per ridefinirne i contorni. Inoltre, nella sua agonia, l’Unione europea si trova a dover calibrare il metro della democrazia solo sulla maggiore o minore avversione nei confronti della Russia, oggi spietatamente incarnata da Putin. Cosicché le destre nazionaliste, che si tratti di Marine Le Pen, di Salvini, dell’Afd non vengono più giudicate sulle ideologie che veicolano e sulle politiche che conducono, ma sul posizionamento in rapporto a Mosca, cosa che potrebbe volgere in popolarità quando le conseguenze di una guerra prolungata si abbatteranno sulle economie europee. Mentre la Polonia, sotto procedimento per infrazione dello stato di diritto, si ritrova miracolosamente ad essere un baluardo della democrazia. Titolo negato invece all’ex sodale del defunto gruppo di Visegrad Victor Orban per non avere voluto una rottura totale con Mosca. Lo stesso metro viene applicato, su tutt’altro versante, ai movimenti pacifisti, in evidente difficoltà, dal momento che non si contemplano soluzioni diverse dalla piena vittoria militare ucraina, alla quale «si deve credere» come ci crede Zelensky, dicono a Washington e Londra. Altrimenti si fa il gioco di Mosca.
Se la Russia di Putin ha indubbiamente accumulato tutti i requisiti propri di un “impero del male”, questo non produce automaticamente un impero del bene che lo fronteggi. Dalla discarica della guerra fredda è stato ripescato un vecchio deplorevole arnese: il “mondo libero”, ripetutamente citato in questi giorni da Zelensky e dall’amministrazione americana. A quest’ultimo appartenevano, tanto per ricordare i suoi esponenti più raccapriccianti, lo scià di Persia Reza Pahlavi, il dittatore filippino Ferdinand Marcos e quello indonesiano Suharto, Augusto Pinochet, la Giunta argentina e numerose dittature centro e latinoamericane. All’occasione gli islamisti afghani e Saddam Hussein.
Dopo la stagione fallimentare della democrazia d’esportazione e degli «Stati canaglia» (modesto surrogato del dissolto impero sovietico del male) il «mondo libero» continua ad ospitare personaggi come Erdogan, il filippino Rodrigo Duterte, la monarchia saudita, Bolsonaro, nonché il generale Al-Sisi, esportatore di gas democratico. A riprova del fatto che con la democrazia la geopolitica non c’entra nulla, tanto poco quanto il «mondo libero» con la libertà, nemmeno quella formale della tradizione borghese. Resta beninteso la possibilità che una sconfitta militare o un lungo logoramento bellico porti alla caduta di un regime. Senza risalire al 1917 è accaduto nel secondo dopoguerra ai colonnelli greci (Cipro), alla dittatura di Salazar in Portogallo (guerre coloniali), alla Giunta argentina (Falkland). Ma a guardare il mondo contemporaneo e le parti in causa sembra una possibilità perfino più remota delle più utopiche speranze pacifiste. Probabile è invece che la guerra sfugga a qualsiasi controllo e disegno strategico con esiti catastrofici. Tutti gli indicatori muovono oggi in questa direzione.
Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 29 aprile 2022.